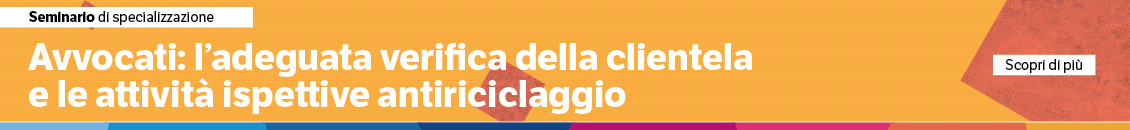Struttura, funzione ed efficacia solo endoesecutiva dell’accertamento dell’obbligo del terzo
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 25 luglio 2022, n. 23123 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi
Massima: “Nell’espropriazione forzata presso terzi, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e, da ultimo, dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, l’accertamento dell’obbligo del terzo si configura alla stregua di un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso, sicché l’ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato”.
CASO
Radicata un’espropriazione mobiliare presso terzi ed essendo stata contestata la dichiarazione di quantità resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., venivano esperiti gli accertamenti prescritti dall’art. 549 c.p.c. (nella versione della norma risultante dalle modifiche da ultimo introdotte nel 2015), all’esito dei quali, ravvisata l’esistenza dell’obbligo del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato, entrambi erano condannati in solido a rifondere le spese al creditore procedente.
Quest’ultimo, tuttavia, ne impugnava la liquidazione con opposizione agli atti esecutivi, che veniva accolta dal Tribunale di Lecco.
La sentenza così emessa era gravata con ricorso per cassazione dal terzo pignorato, secondo cui, nel rideterminare le spese di lite, il giudice di merito aveva errato nel fare riferimento ai parametri ministeriali previsti per i giudizi di cognizione, nell’individuare lo scaglione di valore e nell’applicare la maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza delle domande.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha operato un’accurata ricostruzione della natura, della struttura e della funzione dell’accertamento dell’obbligo del terzo, traendone le relative conseguenze anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite.
QUESTIONI
[1] La disciplina dell’accertamento dell’obbligo del terzo è stata profondamente innovata dalle riforme introdotte a partire dal 2012, che hanno trasformato quello che era un giudizio autonomo in un incidente di cognizione presieduto e deciso dallo stesso giudice avanti al quale si svolge il processo esecutivo.
Nell’assetto anteriore a tali modifiche, la verifica dell’effettiva esistenza ed entità del credito assoggettato a espropriazione forzata si configurava come una parentesi cognitiva funzionalmente collegata alla procedura espropriativa presso terzi (che, nelle more, restava sospesa ex lege), ma, nel contempo, strutturalmente separata e autonoma, celebrata nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione che si concludeva con una sentenza idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale nei rapporti tra debitore esecutato e terzo pignorato.
Con la riscrittura dell’art. 549 c.p.c., un tale accertamento è stato degradato a subprocedimento interno al processo esecutivo, demandato al medesimo giudice dell’esecuzione e definito con ordinanza inidonea alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato.
Per quanto riguarda i caratteri salienti di questo nuovo subprocedimento, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il riferimento operato dalla norma all’istanza postula un atto di impulso proveniente dalla parte interessata all’individuazione del credito staggito (creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo), che esclude l’attivazione ex officio. Detta istanza – la cui proposizione non presuppone il conferimento di un’autonoma e distinta procura alle liti al difensore – può essere formulata oralmente in udienza o con ricorso depositato in cancelleria e, oltre alla contestazione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. o alla sollecitazione di un potere di verifica del giudice dell’esecuzione, deve contenere gli elementi tipici della domanda giudiziale (petitum e causa petendi), ovvero l’indicazione della misura – quantomeno nel suo massimo – del credito dell’esecutato verso il terzo (al limite anche per relationem, fino a concorrenza dell’importo pignorato) e del titolo dell’obbligazione da accertare.
L’istanza va portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell’incidente endoesecutivo, con modalità idonee al raggiungimento dello scopo e senza dovere osservare moduli sacramentali: può, quindi, senz’altro reputarsi adeguata la notifica del verbale o della memoria scritta contenente l’istanza all’esecutato e al terzo pignorato che non siano comparsi all’udienza in cui essa è stata formulata, fatta salva la facoltà per il giudice dell’esecuzione di fissare le concrete attività da svolgere e le relative scansioni temporali.
Instauratosi il contraddittorio, il terzo debitor debitoris, da ausiliario di giustizia (tenuto a collaborare ai fini dell’individuazione della res oppignorata mediante la dichiarazione prescritta dall’art. 547 c.p.c.), diviene parte in senso proprio e, di conseguenza, abilitato a spiegare ogni più ampia difesa, con l’assistenza di un difensore munito di ius postulandi.
Lo svolgimento dell’incidente endoesecutivo resta, in generale, sottratto all’operare delle preclusioni proprie degli ordinari giudizi di cognizione ed è rimesso alle determinazioni del giudice dell’esecuzione, che dovrà sempre e comunque assicurare il rispetto del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa delle parti.
Per quanto concerne l’attività istruttoria, ferma restando l’ordinaria ripartizione degli oneri probatori (di talché il creditore istante è tenuto a provare l’esistenza e l’entità del credito verso il terzo del proprio debitore, o l’appartenenza a questi della res staggita, mentre sul terzo pignorato grava l’onere di dimostrare il fatto estintivo idoneo a escludere la sussistenza di un proprio debito nei confronti dell’esecutato e la sua anteriorità al pignoramento), l’art. 549 c.p.c. si limita a prescrivere l’esecuzione dei necessari accertamenti.
Ciò evidenzia, da un lato, l’ampia libertà di cui dispongono le parti e il giudice nell’individuare gli strumenti probatori ritenuti più efficaci e, dall’altro lato, l’esonero dalle prescrizioni limitatrici tipiche dell’ordinario processo di cognizione: in questo senso, il giudice dell’esecuzione deve ritenersi legittimato a disporre ex officio ogni mezzo di prova che reputi necessario (anche al di là dei limiti di ammissibilità stabiliti dalla legge per alcuni di essi), ricorrendo financo all’acquisizione di prove atipiche o innominate; l’assunzione delle prove deve considerarsi svincolata dal rigorismo formale tipico del giudizio di cognizione ordinaria, sicché, in via esemplificativa, assumendosi informazioni e non testimonianze, non sarà necessaria l’articolazione dei fatti in capitoli separati e specifici; venendo meno la distinzione tra prove legali e prove libere, nonché tra prova propriamente detta e argomento di prova, il convincimento del giudice dell’esecuzione potrà fondarsi anche su elementi che, valutati nel differente contesto di un giudizio di cognizione ordinaria, non risulterebbero provvisti di analoga vis demonstrativa.
Va, peraltro, evidenziato che oggetto dell’accertamento è il credito dell’esecutato nei confronti del terzo in misura corrispondente a quella del credito azionato in via esecutiva, aumentato della metà ai sensi dell’art. 546, comma 1, c.p.c., giacché tale limite individua l’oggetto del processo esecutivo; di conseguenza, come affermato da Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1170, perché vengano accertati – e, conseguentemente, assegnati – crediti dell’esecutato nei confronti del terzo in misura superiore, non è sufficiente che il creditore che abbia, nel frattempo, acquisito ulteriori titoli esecutivi, intervenga nella procedura esecutiva già pendente, ma è necessario che il pignoramento venga esteso, mediante notifica dell’atto di intervento al debitore e al terzo e che, nel contempo, sia modificata la domanda di accertamento, previa richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., in quanto ne sussistano i presupposti.
L’incidente endoesecutivo si conclude con la pronuncia di un’ordinanza, che produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini previsti dall’art. 617 c.p.c. Stante il tenore dell’art. 549 c.p.c., essa non assume valenza di giudicato sostanziale in ordine ai rapporti intercorrenti tra le parti o sulle questioni tra le stesse controverse, né può interferire, in qualsiasi modo, nell’ambito di giudizi o procedimenti di cognizione pendenti in altra sede e aventi per oggetto il credito dell’esecutato verso il terzo. Il provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione, quindi, fonda esclusivamente il potere di disporre l’assegnazione o la vendita forzata dei beni o dei crediti pignorati presso il terzo, siccome accertati, spiegando effetti vincolanti solo nel successivo ed eventuale procedimento di esecuzione forzata promosso dall’acquirente o dall’assegnatario nei confronti del terzo pignorato inadempiente.
All’esito di questa ricostruzione, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo mantiene comunque natura contenziosa.
Di conseguenza, il giudice dovrà anche disporre, con capo separato e distinto da quello eventualmente pronunciato ai sensi dell’art. 95 c.p.c. (che assume valenza meramente strumentale rispetto alla distribuzione o all’assegnazione del ricavato), la regolamentazione delle relative spese, facendo applicazione in via analogica – in difetto di una regola ad hoc – del principio di soccombenza: così, in caso di accoglimento della domanda di accertamento, il terzo pignorato sarà tenuto a rifondere le relative spese, visto che la necessità di instaurare l’incidente di cognizione è riconducibile alla sua violazione del dovere di cooperazione, non avendo reso la dichiarazione di quantità o avendone fornito una erronea o non veritiera.
L’inapplicabilità dell’art. 95 c.p.c. al subprocedimento di accertamento esclude che possa farsi riferimento ai compensi previsti per la fase di trattazione delle procedure esecutive presso terzi, in quanto inidonei a remunerare adeguatamente le attività difensive espletate nell’ambito dell’incidente endoesecutivo, essendo concepiti nella diversa prospettiva di un ordinario processo esecutivo, che non conosce appendici cognitive. Si dovranno, quindi, applicare i compensi previsti per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, liquidando gli importi tra quelli minimi e quelli massimi ivi stabiliti, a seconda del modo in cui si è effettivamente dipanata ciascuna fase e alle attività concretamente svolte, ponderando in modo particolarmente mirato la possibilità di accordare le maggiorazioni riferite a procedimenti stricto sensu di cognizione (con conseguente obbligo di motivare in maniera più approfondita il loro eventuale riconoscimento).
Per quanto concerne, invece, l’individuazione dello scaglione di valore cui fare riferimento per la liquidazione dei compensi, in caso di integrale accoglimento della domanda, di rigetto della stessa o di diniego della pronuncia di merito, andrà considerata la somma domandata con l’atto introduttivo (criterio del disputatum), visto che il debitore e il terzo che abbiano ottenuto la reiezione integrale delle pretesa avanzata dal creditore hanno diritto a una rifusione dei compensi parametrata all’intera somma ex adverso infondatamente richiesta, essendo stati costretti a difendersi in relazione a tale presunto – ma insussistente – valore; in caso di accoglimento parziale dell’azione, invece, rileverà l’importo effettivamente attribuito dal giudice (criterio del decisum).
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia