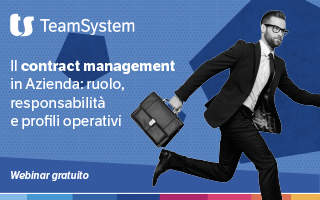I requisiti dell’attività di disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313, Pres. Cirillo – Est. Giudicepietro
[1] Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – Forma – Contestazione generica od implicita – Sufficienza – Esclusione – Specifico riferimento al documento e al profilo contestato – Necessità (art. 214 c.p.c.)
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte.
CASO
[1] Una contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava, ai fini IRPEF, e a carico della ditta individuale riferibile alla medesima, un maggior reddito d’impresa non dichiarato. Tra i motivi di ricorso, in particolare, si lamentava la circostanza per cui le fatture contestate non fossero state sottoscritte dalla contribuente, bensì dal marito della stessa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso rilevando, tra l’altro, che le fatture contestate, anche se fossero state emesse dal marito deceduto della ricorrente e all’insaputa di quest’ultima, erano comunque riferibili alla omonima ditta.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava integralmente la sentenza impugnata, con decisione che veniva fatta oggetto del ricorso per cassazione sfociato nella pronuncia in commento. Per quanto qui interessa, la contribuente rilevava che, avendo negato di essere consapevole dell’emissione delle fatture oggetto di accertamento, adducendo come esse fossero state emesse da terzi (in particolare, dal coniuge deceduto) e quindi dall’istante non conosciute, la C.T.R. avrebbe dovuto stabilire attraverso l’esame degli atti processuali se all’istante fosse imputabile l’emissione delle fatture in contestazione; altrimenti opinando, si sarebbero ricondotte nell’alveo della responsabilità fiscale del contribuente anche gli atti illeciti commessi da terzi, in violazione dei principi generali in materia di responsabilità tributaria.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte giudica infondato il motivo di ricorso proposto.
In prima battuta, la Cassazione chiarisce come, secondo la ricorrente, nessuna responsabilità fiscale può essere fatta valere in capo a colui che, pur risultando cartolarmente l’esecutore della prestazione fatturata, sia del tutto inconsapevole dell’emissione della fattura in quanto quest’ultima risulti fraudolentemente redatta da un terzo.
Tuttavia – venendo al profilo di diretto rilievo ai fini del presente commento -, la ricorrente non risultava aver specificamente disconosciuto le proprie firme sui documenti fiscali.
A tal proposito, il provvedimento ricorda l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale e inequivoco, sicché deve ritenersi inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (in tal senso, Cass., 19 luglio 2012, n. 12448); inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo a ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (così, Cass., 19 agosto 2004, n. 16232).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo la contribuente aveva omesso di esercitare tale espresso e dettagliato disconoscimento relativamente alle sottoscrizioni apposte sulle fatture contestate con la conseguenza per cui, in definitiva, i tributi evasi, accertati nei confronti della ditta individuale, dovevano considerarsi dovuti in quanto riferibili all’attività commerciale svolta dalla contribuente medesima.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in commento interviene sul tema dei requisiti che l’attività di disconoscimento disciplinata dall’art. 214 c.p.c. deve presentare al fine di produrre gli effetti che la legge vi ricollega.
Anzitutto, può essere utile ricordare il complessivo quadro normativo, unitamente alla disciplina in materia di efficacia della scrittura privata prodotta in giudizio.
Ai sensi dell’art. 2702 c.c., «la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta»: in altri termini, la scrittura privata acquista l’efficacia di prova piena circa la paternità delle dichiarazioni contenute nel documento se la sottoscrizione apposta sullo stesso sia espressamente riconosciuta dall’autore, ovvero se si verifichi una delle fattispecie che la legge equipara al riconoscimento espresso.
Tra tali fattispecie è annoverato il riconoscimento tacito che, ex art. 215 c.p.c., si verifica quando la parte costituita in giudizio non disconosca la scrittura prodotta in giudizio nei suoi confronti nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
L’attività di disconoscimento – che, dunque, è funzionale a impedire l’integrazione della fattispecie di riconoscimento tacito della sottoscrizione, cui conseguirebbe l’incontestabilità della provenienza della scrittura dal soggetto che ha omesso di disconoscerla – è descritta al precedente art. 214 c.p.c. nei termini di “formale negazione” della propria sottoscrizione (per tutti i concetti sin qui esposti sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, a V. Baroncini, sub art. 2702 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2016, 429 ss.).
Nell’elaborazione maturata attorno all’attività di disconoscimento – e, in particolare, alla “formale negazione” richiesta ex lege – oltre alle indicazioni rinvenibili nei principi di diritto espressi dalle pronunce di legittimità richiamate in sede di soluzione del caso de quo, solitamente si afferma come tale locuzione non sottintenda il ricorso a formule sacramentali, rendendosi però necessaria una inequivocabile dichiarazione della parte di non essere l’autrice della scrittura, nonostante sulla medesima sia apposto il suo nome (in tal senso, Cass., 20 agosto 2014, n. 18042).
Con riguardo alle persone giuridiche, inoltre, si è affermato che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, al fine di contestare l’autenticità della sottoscrizione non sia tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell’art. 221 c.p.c., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell’art. 214, c.p.c., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società (così, Cass., 30 gennaio 2014, n. 2095).
Ancora, con riguardo alle forme del disconoscimento la giurisprudenza di merito ha chiarito che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, infatti, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all’originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (C. App. Bari, 6 luglio 2020, in www.ilcaso.it).
Da quanto risulta dall’esposizione di fatto racchiusa nel provvedimento in commento, nel caso di specie la contribuente non aveva esercitato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle fatture contestate nei modi prescritti dalla legge, così come meglio definiti dall’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi in materia e qui richiamata. Di talché, integratasi nei suoi confronti la fattispecie del riconoscimento tacito, il giudice di merito non ha potuto esimersi dal ritenere per vera la paternità, in capo alla stessa, delle menzionate fatture, con conseguente imputazione alla stessa della relativa responsabilità tributaria.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia