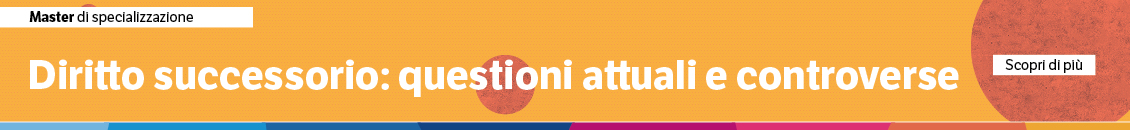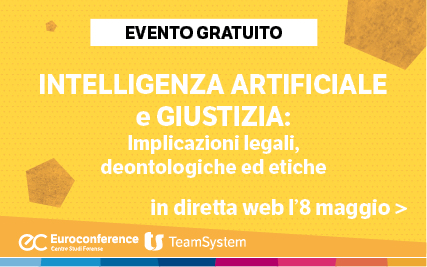I requisiti del testamento olografo
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCassazione civile, Ord., sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25936 – LOMBARDO– Presidente – TEDESCO– Relatore
Testamento olografo
(C.c. art. 602 ss.)
“Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’articolo 602 del codice civile, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, veniva in rilievo una scrittura privata che presentava tutti i requisiti formali del testamento olografo, ma dalla quale non si poteva ricavare l’esistenza della volontà della de cuius di disporre dei suoi beni per il tempo successivo alla morte).”
CASO
La Corte d’Appello di Napoli, nella causa inizialmente proposta da C.P. nei confronti dei fratelli germani C.Mi. e C.M., ha riconosciuto che la scrittura privata proveniente dalla madre delle parti in causa non contenesse disposizioni testamentarie.
Per la cassazione della sentenza C.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi principali. Con il primo, il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado, nell’interpretazione della scrittura privata, non avessero tenuto conto della reale volontà della defunta e del principio di conservazione del testamento e dei suoi effetti. Con il secondo motivo censura la sentenza perché la corte d’Appello, dopo avere constatato l’esistenza di disposizioni equivoche, avrebbe dovuto circoscrivere la nullità a queste stesse disposizioni, preservando la validità delle altre disposizioni. C.P. e Ci.Mi. hanno resistito con separati controricorsi.
SOLUZIONE
Per la Corte di Cassazione il primo motivo di doglianza è inammissibile. Infatti, i giudici di legittimità osservano che affinché si abbia testamento è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte. In altre parole, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, ma occorre altresì l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. I giudici di secondo grado, aderendo a questi principi, avevano correttamente evidenziato che la scrittura privata, benché rispettasse i requisiti di forma previsti dall’art. 602 c.c., non contenesse la volontà della de cuius di disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte. A contrario, la Corte d’Appello ha inteso il documento al pari di un semplice rendiconto indirizzato ai figli e come mero progetto relativo al godimento dei suoi beni. In particolare, la l’attenzione della Corte si è concentrata su alcune previsioni ritenute indice chiaro di un’assenza di volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. Inoltre, la Corte di Cassazione rileva come non sia pertinente, nel caso di specie, il richiamo al principio di conservazione della volontà testamentaria. Infatti, l’applicazione del principio presuppone il preventivo riconoscimento che una data scrittura contenga una disposizione di ultima volontà potendosi “discutere della nullità di una disposizione solo dopo averne accertato il contenuto”. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Infatti, avendo la Corte d’Appello negato il carattere testamentario della scrittura nel suo complesso e non di una parte di essa, non si poteva rimproverare alla corte di merito di non avere dichiarato la nullità solo parziale del supposto negozio testamentario. Pertanto, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio.
QUESTIONI
La pronuncia in commento permette innanzitutto di analizzare la disciplina dettata in tema di testamento olografo e i requisiti della forma richiesti dal dettato normativo. In primo luogo, il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore. Benché presenti qualche svantaggio legato alla possibilità di smarrimento, soppressione o falsificazione, parte della dottrina (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè,2015, p. 834) ritiene che l’olografo abbia il grande vantaggio della semplicità, della segretezza e della redazione in assenza di terze persone. In ordine alla natura giuridica esso è una vera e propria scrittura privata (Cass. sez. II, 22 aprile 1994, n. 3833): ossia un documento liberamente redatto e sottoscritto da un privato. Tale natura non viene meno anche nel caso in cui esso sia depositato presso un notaio o successivamente la sua pubblicazione (Cass. 7 ottobre 1960, n. 2600; Cass. 5 luglio 1979, n. 3849; In dottrina: M. Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p. 86; G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, 2015, p. 834; E. Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994, p. 789). Tuttavia, deve osservarsi che si tratta di una scrittura privata avente particolari requisiti formali: non basta che sia sottoscritta dal suo autore ma deve essere da lui redatta per intero e datata. (Cass. 5 aprile 1978, n. 1570; Cass. 29 aprile 1991, n. 4749). Infatti, l’art. 602 c.c., che contiene la disciplina relativa alla forma dell’olografo, pone anzitutto il requisito dell’autografia integrale: l’olografo deve essere redatto di pugno del testatore tanto nel testo quanto nella data e, naturalmente, nella firma. La scritturazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, matita, gesso, carbone etc.) e su qualsiasi materia (carta, stoffa, legno etc), purché idonea a riceverla: la giurisprudenza ha espressamente escluso la necessità che il testamento olografo sia scritto su un pezzo di carta (Cass. 13 aprile 1959, n. 1089; Cass. 10 aprile 1963, n. 920; Cass. 10 marzo 1965 n. 394). L’autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità, ossia la sicura provenienza da parte del testatore, e l’abitualità, ossia che la grafia deve essere quella usata abitualmente dal testatore. Pertanto, sono nulli, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore (ad esempio una scrittura a macchina, moduli precompilati etc) o redatti con l’intervento di un terzo. Sul punto, infatti, si è ricordato che “il testamento olografo deve essere interamente vergato di mano del testatore anche per impedire che questi, nella confezione del testamento, possa subire illecite ingerenze altrui e manifestare di conseguenza una volontà non formatasi, in tutto o in parte, in maniera libera e spontanea. È pertanto da ritenere che qualora nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti che essa è stata scritta dal terzo durante la confezione del testamento, sciente e consenziente il testatore, il testamento sia nullo per intero giacché dalla prova che alla confezione del testamento cooperò una volontà altrui il legislatore fonda una presunzione assoluta di mancata spontaneità e libertà del volere” (Cass. 5 agosto 2002, n. 11733). In altri termini l’intervento del terzo deve eliminare il carattere della stretta personalità della grafia: pertanto, si è ritenuto valido il testamento nel quale il terzo si è limitato a frenare il tremito della mano del testatore, salvaguardando la riconoscibilità della scrittura. L’art. 602 c.c. si sofferma, anche, sui caratteri della sottoscrizione, da apporsi alla fine delle disposizioni, la quale è valida anche se non contiene l’indicazione del nome e del cognome del testatore, purché designi con certezza la persona di questi (in mancanza di sottoscrizione è discusso se si tratti di inesistenza[1] o la nullità[2] del testamento). La sottoscrizione ha la funzione sostanziale “appropriativa” delle dichiarazioni che precedono: è ritenuta valida la firma con pseudonimo o con soprannome e la sottoscrizione illeggibile se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore. Tuttavia, la sottoscrizione apposta nel corpo delle disposizioni comporta la nullità del testamento ma può dare efficacia alle disposizioni che la precedono quando queste hanno gli elementi per costituire un atto separato e autonomo, indipendentemente, dalle disposizioni non sottoscritte (G. Capozzi, Successioni e Donazioni, Giuffrè, 2015, p. 838). La sottoscrizione sul retro della pagina, contenenti le disposizioni, è stata ritenuta valida in mancanza, in calce alla pagina, di spazio sufficiente (Cass. 23 giugno 2005, n. 13487), mentre la sottoscrizione marginale può adempiere alla sua funzione quando la pagina non presenti in calce alle disposizioni lo spazio necessario per apporla (Cass. 21 marzo 1960 n. 580). Infine, nel suo terzo ed ultimo comma l’art. 602 c.c., detta la disciplina della data, assegnando ad essa un rilievo secondario, giacché la prova della non verità della stessa è ammessa soltanto nei casi e per le finalità normativamente previste. Ad ogni modo, la sua funzione è quella di accertare la capacità del testatore e l’efficacia fra più testamenti redatti dalla stessa persona: la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti e di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. La data deve comunque risultare dal testamento e non “aliude”. Tuttavia, la data può occupare qualsiasi posizione nell’olografo, “può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere le stesse disposizioni di ultima volontà” (Cass. 18 settembre 2001, n.11703: nel caso di specie la data era apposta sulla busta che conteneva la scheda testamentaria. Contra Cass. 24 giugno 1965, n. 1323). L’indicazione della data deve essere completa dunque deve contenere giorno, mese ed anno. L’ipotesi di mancanza di una delle tre componenti, quale che sia, deve essere equiparata a quella di mancanza della data, sicché ne discende l’invalidità del testamento olografo, sotto forma di annullabilità (Cass., 09 dicembre 1988, n.6682). Chiariti i requisiti di forma del testamento olografo, pena l’invalidità del testamento per difetto di forma, si noti che il testamento olografo, avente natura di scrittura privata, costituisce prova documentale ai sensi degli artt. 2699 ss.. Esso è prova storica precostituita, ossia rappresentazione della verità di un fatto formata prima del giudizio ed indipendentemente da esso (Marmocchi, Il testamento olografo tra segretezza e sicurezza, in Riv. dir. civ. 1998, II, p. 817). L’olografo, in forza dell’art. 2702 c.c. fa dunque piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto, se colui contro il quale è prodotto non lo disconosca, negando l’autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Pertanto, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. sez. un., 15 giugno 2015, n.12307). L’ordinanza in commento, si è osservato, riconosce nella scrittura privata redatta dalla madre delle parti il rispetto dei requisiti di forma richiesti dal dettato normativo. Tuttavia, i Giudici di legittimità, ancor prima di esaminare il rispetto dei requisiti di forma, hanno evidenziato come costituisca un prius logico l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. In tal senso la giurisprudenza ha affermato che “ perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà, riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte” (Cass., 08 gennaio 2014, n. 150). Pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria: ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, sarà necessario esaminare ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione.
[1] Giannatasio, Delle successioni, Successioni testamentarie, in Comm. Cod. civ, Torino. p. 137 ss.;
[2] Gabrielli, L’oggetto della conferma ex art. 590, in Riv. Trim. dir. E proc. Civ., p. 1375 ss.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia