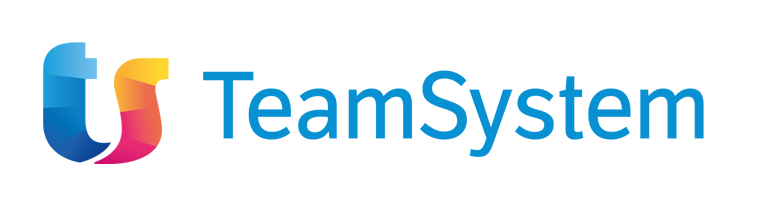Il mancato rideposito del fascicolo di parte (anche della fase monitoria) costituisce mera irregolarità
di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDFAbstract: Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, da ultimo con la sentenza del 28 settembre 2018 n. 23455, la parte che, dopo essersi costituita, ritiri il proprio fascicolo ed ometta di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità, potendo il giudice di merito ovviare al mancato deposito, valutando prudentemente le veline a sua disposizione o, nel dubbio, rimettendo la causa sul ruolo.
La Cassazione tradizionalmente riteneva che non potesse predicarsi esistente nell’ordinamento processuale civile un principio di immanenza, in base al quale, cioè, i documenti prodotti in primo grado dalla parte risultata vittoriosa dovessero ritenersi acquisiti per sempre al processo e al fascicolo di questo. La ragione è evidente: il giudice è tenuto a decidere la causa secundum allegata et probata, senza poter far riferimento a quel che le parti non hanno più messo a disposizione, ridepositando il proprio fascicolo di parte.
Conseguentemente e sempre secondo l’orientamento tradizionale, la Cassazione riteneva soccombente per mancata prova la parte che, pur vittoriosa in primo grado, era successivamente rimasta contumace in appello, non avendo provveduto a ridepositare i documenti prodotti nel fascicolo di primo grado e in quello monitorio, di talché non aveva posto il giudice di appello in condizione di decidere la causa in base alle prove ritualmente e direttamente sottoposte al suo esame in sede di decisione (così anche Cass., 8 maggio 2003, n. 6987). Né a colmare la mancata costituzione in appello poteva ovviare il fascicolo di ufficio formato da cancelliere (in quanto trasmesso dalla cancelleria del giudice di primo grado), contenente anche i documenti prodotti nel giudizio di prime cure: i due fascicoli (quello d’ufficio e quello di parte) conservano infatti una distinta funzione. Ne derivò che il giudice, in mancanza del fascicolo di parte non prodotto dalla parte rimasta contumace in appello, non potesse far altro che dichiararne la soccombenza per mancanza di prova.
Invero, è evidente come la Cassazione in tal caso abbia abbracciato la tesi della natura impugnatoria del giudizio di opposizione utilizzata solitamente ora per statuire il carattere funzionale e inderogabile della competenza del giudice dell’opposizione (Cass. SSUU 8 ottobre 1992, n. 10984), ora per far dichiarare l’inammissibilità del giudizio di opposizione introdotto solo per contestare vizi della fase monitoria senza contestazione alcuna del credito (cfr. Cass. civ. 10 aprile 1996, n. 3319; in dottrina, GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 169 ss; RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 82 secondo cui “essendo attivabile ad iniziativa dell’ingiunto ed essendo destinata ad accertare in modo pieno, e per la prima volta, se la condanna monitoria sia conforme al diritto (sostanziale e processuale), è un giudizio di impugnazione che si struttura con i caratteri, i contenuti e le cadenze proprie del procedimento di primo grado: è, in sintesi, un’impugnazione di primo grado”; sul punto anche TEDOLDI – MERLO, L’opposizione a decreto ingiuntivo, in Il procedimento d’ingiunzione, opera diretta da Capponi, Bologna, 2009, 463 ss.).
Di diverso avviso è invece altra parte della giurisprudenza (cfr. Cass., 1° febbraio 2007, n. 2217, Cass., 18 novembre 2003, n. 17440), la quale propugna l’unitarietà tra la fase monitoria e quella di opposizione, nel senso che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo soltanto a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo il ricorso, in cui è contenuta la proposizione della domanda, presentato per chiedere il decreto di ingiunzione.
Mutano le conseguenze a seconda della tesi cui si aderisca: nel primo caso, sostenendo la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, la mancata (ri)produzione nel giudizio di opposizione e in appello della documentazione comprovante le proprie ragioni determina la soccombenza della parte per evidente carenza probatoria; invece, nel caso in cui si acceda alla tesi dell’unitarietà del procedimento monitorio e di opposizione, strutturalmente bifasico, la carenza probatoria potrà essere risolta nel senso che, considerando la fase monitoria e quella di opposizione un unicuum per il principio di non dispersione della prova, dovrebbe ritenersi già acquisita al processo la documentazione prodotta unicamente nella fase monitoria.
Questa appare invero essere la tesi preferibile, dacché, a seguito dell’opposizione, il decreto ingiuntivo resolvitur in vim simplicis citationis: talché, come ritenuto dalle Sezioni Unite, con sentenza Cass., sez. un., 10-07-2015, n. 14475, le quali avevano ritenuto che l’art. 345, 3º comma, c.p.c. sulle nuove produzioni documentali in appello (nel testo anteriore alla riscrittura del 2012), andasse interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, 3º comma, c.p.c., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio «di non dispersione della prova» ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti pienamente ammissibili.
A tale ultima tesi mostra di aderire, da ultimo, la Cassazione nella sentenza 28 settembre 2018, n. 23455, dove afferma i seguenti ulteriori principi:
- “la documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fonda la pretesa vantata deve ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione”.
- “la prova documentale e testimoniale esaminata dal giudice di primo grado che, quanto alla sua storicità, ne dà conto in motivazione, pur soggetta a nuova valutazione da parte del giudice d’appello deve ritenersi acquisita agli atti, anche in base alla sentenza di primo grado pronunciata, visto il valore di atto pubblico del provvedimento decisorio del giudice”.
Ne deriva, quindi, che il giudice d’appello, stante l’acquisizione agli atti della documentazione prodotta dal ricorrente in via monitoria, ben avrebbe dovuto far fronte alla mancanza del fascicolo di parte con una prudente valutazione delle veline a sua disposizione (avendo la parte offerto “copie di cortesia” dei documenti prodotti, inserite poi nel fascicolo d’ufficio) o attraverso la rimessione della causa sul ruolo; infatti, il mancato deposito del fascicolo ritirato ad opera della parte pur ritualmente costituita e che abbia già assolto i propri oneri probatori integra una mera irregolarità.
Orientamento questo che pare attenuare gli oneri dell’appellante, allorché l’appellato, vittorioso in prime cure, non si costituisca in appello e ometta perciò di ridepositare il proprio fascicolo: ben due pronunce delle Sezioni Unite onerano, infatti, l’appellante a provare la fondatezza delle proprie doglianze, producendo in appello copia dei documenti della controparte, ove questa sia rimasta contumace in seconde cure. Per Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498, l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l’appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, ma una revisio fondata sulla denunzia di specifici «vizi» di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata; ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte (nella specie, rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare; non senza aver comunque riconosciuto che, nel sistema processualcivilistico vigente – in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio; ne consegue che la parte che nel corso del processo chieda il ritiro del proprio fascicolo ha l’onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano inseriti, onde impedire che qualora essa, in violazione dei principi di lealtà e probità, ometta di restituire il fascicolo con i documenti in precedenza prodotti, risulti impossibile all’altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.
In egual modo Cass., sez. un., 8 febbraio 2013, n. 3033 ha ritenuto che l’appellante il quale affermi che la documentazione prodotta dal convenuto in primo grado provava l’esistenza e non il pagamento del suo credito, abbia l’onere di provare tale motivo di impugnazione, ancorché il convenuto non riproduca in appello la documentazione prodotta in primo grado: infatti, tenuto conto dell’odierna configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 c.c., vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste. Perciò, il c.d. principio di «immanenza della prova», in base al quale la prova, una volta entrata nel processo, vi permane, va inteso con riferimento non al documento materialmente incorporante la prova, bensì all’efficacia spiegata dal mezzo istruttorio, virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti, delle quali tuttavia, quella che ne invochi una diversa valutazione da parte del giudice del grado successivo non è esonerata dall’attivarsi perché lo stesso possa concretamente procedere al richiesto riesame.
Come ben vedesi, l’ultimo arrêt dal quale abbiamo preso le mosse (Cass., 28 settembre 2018 n. 23455), pare discostarsi dal solco tracciato dalle Sezioni Unite e da altri precedenti di legittimità, discorrendo di mera irregolarità e di necessità di esaminare le “veline” e finanche di rimettere la causa sul ruolo, onde acquisire i documenti mancanti.
Orientamento quest’ultimo certo preferibile, in luogo di quello avallato dalla “doppia conforme” delle Sezioni Unite nel 2005 e nel 2013, sulla base di una sorta di presunzione di verità della sentenza di prime cure, con inversione dell’onere probatorio in capo alla parte appellante.
Peraltro, nell’era del PCT (Processo Civile Telematico), in cui anche i documenti vengono depositati telematicamente e, in tal modo, permangono nel fascicolo telematico, il c.d. principio di “immanenza” pare potersi predicare non solo per le prove costituende acquisite nel corso dell’istruttoria, ma anche per le prove precostitutite depositate e prodotte dalle parti in uno ai rispettivi atti processuali.
La tecnologia può fungere, insomma e per una volta, da buon viatico per il superamento di obsoleti formalismi.