Le Sezioni Unite sugli oneri della parte interessata alla dichiarazione dell’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDFCass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456 Pres. Spirito, Rel. Di Marzio
Procedimento civile – Prova testimoniale – Inammissibilità – Rilievo d’ufficio – Giudice –Eccezione – Nullità della prova – Sanatoria (C.p.c., artt. 112, 156, 157, 158, 246, 190; D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 209, art. 283)
Massima: “L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”.
CASO
La vicenda in esame trae origine dalla citazione di alcuni degli eredi una vittima di sinistro stradale avverso l’assicurazione quale designata per il risarcimento secondo la disciplina di cui agli artt. 283 ss. del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 209, c.d. codice delle assicurazioni private.
La compagnia si costituiva contestando i presupposti per l’accoglimento della domanda e le relative difese venivano accolte dal tribunale, che, in particolare, giudicava inattendibili le dichiarazioni rese dalla terza trasportata, ascoltata come testimone nonostante l’eccezione di formulata dall’assicurazione.
La sentenza era confermata in appello, sulla base dei fatti come ricostruiti in primo grado.
Gli eredi proponevano ricorso per cassazione, lamentando tra il resto, con il primo motivo, che il giudice di secondo grado avrebbe errato nel condividere la statuizione del primo giudice in ordine all’incapacità a testimoniare dalla terza trasportata.
SOLUZIONE
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per ragioni processuali inerenti la novità della questione proposta alla Corte, e nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., esprime i seguenti tre, distinti principi di diritto: “l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova”; “ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”; “la parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione”.
QUESTIONI
I tre principi di diritto sopra riportati sono in realtà ispirati ad una sola logica, avallata dalla Cassazione a seguito del complesso ragionamento giuridico trasfuso nella lunga motivazione con cui la Corte ha corredato la sentenza (resa ex art. 363 c.p.c. malgrado l’inammissibilità del ricorso, e questo, data la relativa infrequenza con cui il giudice di legittimità ricorre allo strumento, attesta sin da subito il rilievo attribuito alla questione): la responsabilizzazione della parte interessata alla dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla controparte.
Esaminati i vari orientamenti sostenuti in passato dalla Giurisprudenza, infatti, le Sezioni unite hanno in sostanza avallato il modello meno rassicurante per la parte (e, incidentalmente, meno laborioso per il singolo magistrato) sulla collaborazione del giudice nel prevenire il vizio processuale dichiarando ex ante l’inammissibilità della prova prima dell’escussione del testimone, o quanto meno nell’eliminare il vizio già maturato dichiarando ex post la nullità della prova; e hanno così assegnato alla stessa parte un triplice onere – rappresentato (i) dalla formulazione dell’eccezione prima dell’ammissione del mezzo; (ii) dall’immediata (“subito dopo”) eccezione della nullità del mezzo di prova, esperito in presenza di una non rilevata ragione di inammissibilità ex art. 246 c.p.c.; (iii) dalla riproposizione dell’eccezione di nullità al momento delle precisazioni delle conclusioni – che, pur in assenza di precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità, era sì ordinariamente assolto dai difensori più scrupolosi ma di cui il sistema avrebbe potuto fare serenamente a meno se si considera che esso a prima vista origina più problemi che soluzioni.
Una prima questione, in realtà già risolta nell’ormai “vecchio” rito ordinario pre Cartabia e per la stessa via superabile anche con la nuova scansione delle memorie precedenti l’udienza ex art. 183 c.p.c., è rappresentata dal momento in cui la parte può tempestivamente formulare l’eccezione di inammissibilità della testimonianza “prima dell’ammissione del mezzo”, per usare le (impegnative) parole della Corte.
Nel rito previgente, e in ogni caso per i giudizi instaurati prima del 28 febbraio 2023, la risposta transitava dall’alternativa tra la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. per le prove dirette richieste dalla controparte nella propria seconda memoria e l’udienza di discussione sui mezzi di prova, ove concretamente fissata, per le ipotetiche dichiarazioni testimoniali richieste in prova contraria.
Oggi, la nuova scansione che comprime le memorie istruttorie in un momento anteriore alla prima udienza permetterà in ogni caso alle parti di formulare l’eccezione in tale occasione, ovvero, laddove la censura ex art. 246 c.pc. riguardi una prova diretta avversaria, nella propria terza memoria integrativa; e, dove riguardi invece una prova contraria, direttamente in udienza o – nella remota ipotesi in cui il giudice ritenga di disporre la celebrazione dell’udienza di prima trattazione in modalità c.d. cartolare, malgrado le difficoltà apportate dalla necessità di procedere all’ormai necessario interrogatorio libero – nelle stesse note scritte sostitutive dell’udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Un secondo problema attiene alla possibilità materiale, per la parte interessata, di proporre l’eccezione prima dell’ammissione.
Non di rado infatti l’indicazione dei testimoni è svolta, nelle memorie istruttorie, con le sole generalità e la residenza senza la specificazione delle ragioni per cui egli potrebbe, e negli auspici di chi lo indica a testimone, dovrebbe essere a conoscenza dei fatti della causa.
La questione è complicata dal fatto che nessuna norma richiede espressamente tale specificazione nei suddetti atti, e tanto meno a pena di inammissibilità, con la conseguenza che le informazioni sul punto emergono solitamente dalle dichiarazioni rese dal testimone al giudice quando quest’ultimo, già fatto accomodare il testimone e prima di procedere all’escussione vera e propria, gli pone le domande di rito tra cui quella, rilevante ai fini che occupano, degli eventuali legami con una o più delle parti in giudizio.
In questo caso, la pretesa che la parte interessata all’inammissibilità del testimone formuli l’eccezione prima dell’ammissione condurrebbe a due esiti alternativi, entrambi inaccettabili sul piano pratico, rappresentati dall’assegnazione a tutte le parti di un onere di investigazione nei confronti di tutti i testimoni (nel tempo, talvolta ristretto, compreso tra la conoscenza dei nominativi e la possibile ammissione da parte del giudice) sulle possibili ragioni di inammissibilità ex art. 246 c.p.c., oppure il suggerimento operativo, contrario a evidenti esigenze di economia processuale, di formulare eccezioni di inammissibilità a tappeto, in modo da eliminare il rischio che – a informazioni ricevute, cioè in udienza – l’eccezione risulti inammissibile per tardività non essendo stata sollevata “prima dell’ammissione del mezzo”.
E’ verosimile che sul punto, onde evitare i due estremi appena accennati, si affermerà presto o tardi un orientamento più permissivo rispetto a quello in termini generali espresso dalla sentenza in commento, e vòlto a limitare la richiesta di formulazione in epoca anteriore all’ammissione ai casi in cui dalle informazioni in atti sia evincibile, almeno in astratto, la ragione di inammissibilità (ad esempio perché il testimone è pacificamente un condomino in una causa in cui ciò rileva ai fini di cui all’art. 246 c.p.c., o il coniuge in regime di comunione legale dei beni), e a consentire la formulazione per la prima volta in udienza laddove l’interesse qualificato del testimone emerga soltanto in quella sede.
L’alternativa è un’applicazione meccanica dei principi di diritto espressi dalla Cassazione anche ai casi in cui nessuna informazione sulla persona del testimone sia disponibile alle parti (se non il nome e il cognome e, talvolta, la residenza) prima che il giudice, in udienza, interroghi il testimone sui rapporti con le parti e il possibile interesse nella causa ex art. 252 c.p.c., e la conseguente sanzione di inammissibilità per l’eccezione formulata in udienza perché, per usare ancora le parole della Corte, essa non sarebbe stata formulata “prima dell’ammissione” bensì alle soglie dell’assunzione: e ciò non è evidentemente accettabile, conducendo al risultato paradossale (e correggibile soltanto con le farraginose forme della rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c.) che il giudice dovrebbe ritenere tardiva un’attività che non poteva essere compiuta prima.
Si può infine osservare sul piano generale che a prima lettura stupisce – in un’epoca in cui il processo corre verso la riduzione dei tempi e ove possibile l’economia delle attività processuali, di parte e del giudice – l’evidente rigidità della decisione: essa non elimina infatti neppure uno dei tre requisiti (l’eccezione di parte prima dell’ammissione, l’eccezione di nullità subito dopo l’escussione, la conferma dell’eccezione con la precisazione delle conclusioni) e pone così in capo alle parti almeno due attività – la seconda e la terza – che ben avrebbero potuto ritenersi assorbite nella tempestiva formulazione della prima; e, in alterativa, ben avrebbe potuto la Corte risolvere a monte il problema ritenendo rilevabile d’ufficio il vizio e così eliminando in radice i profili relativi ai termini e alla forma dell’eccezione di parte.
Una visione d’insieme della regolamentazione emergente dal triplice onere non elimina l’impressione di una sostanziale corsa ad ostacoli per la parte interessata all’effetto di inammissibilità e, in termini più tecnici, un non scontato favor della Giurisprudenza (e non necessariamente del legislatore, che ai profili processuali dell’eccezione non dedica una disciplina particolare oltre alla norma generale dell’art. 246 c.p.c.) per il mantenimento, nel materiale in atti, della dichiarazione resa dal soggetto pur sospetto di parzialità.
Dietro il fenomeno può forse scorgersi un’encomiabile volontà di limitare ove possibile l’incidenza statistica dei casi in cui un’informazione rilevante per la causa non possa entrare nell’orizzonte visivo del giudice (o, se già entrata, debba uscirne a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di nullità) e così di riservare al giudice del merito e alla fase di valutazione della prova, senza fredde e astratte predeterminazioni normative, l’esame giudiziale della concreta inattendibilità del testimone, se effettivamente sussistente.
Il ragionamento metagiuridico sotteso alla sentenza in commento, in altre parole, sembra obbedire al quesito, effettivamente di non facile soluzione sul piano logico: perché chi versa nella fattispecie di cui all’art. 246 c.p.c. dovrebbe per ciò solo dichiarare il falso, peraltro sottoponendosi così al rischio della sanzione penale prevista dall’art. 372 c.p.), in un numero di ipotesi così alte da giustificare che nella totalità dei casi il giudice debba astenersi anche solo dall’ascoltarlo? E perché non lasciare invece al giudice (almeno quando la parte abbia omesso l’assolvimento di uno dei tre oneri) la valutazione in concreto dell’ipotesi che, più o meno eccezionalmente, il testimone pure interessato abbia ricostruito fedelmente il fatto la cui è chiamato a confermare o smentire?
L’orientamento si inserisce così nella tradizionale insofferenza della giurisprudenza per le prove legali, qui per la c.d. prova legale negativa rappresentata dalla previa valutazione, da parte del legislatore, del fatto che potrebbe non essere terzo nella rievocazione dei fatti di causa un testimone che avrebbe titolo a partecipare al giudizio in qualità di parte.
Esso si segnala dunque per il singolare effetto di prendere sì le mosse da un’obiettiva intensificazione degli oneri formali in capo alle parti (anche in assenza di espressi indici normativi che giustifichino la scelta se si considera che, dei tre oneri, soltanto la proposizione dell’eccezione di nullità trova un aggancio nel diritto positivo, e in ogni caso “nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso” ex art. 157, comma 2 c.p.c., e non “subito dopo” l’escussione), ma con il positivo effetto di potenziare gli strumenti in mano al giudice per l’accertamento della verità dei fatti di causa, e ciò trova conforto nell’immagine di un processo “giusto” ai sensi dell’art. 111 Cost.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia



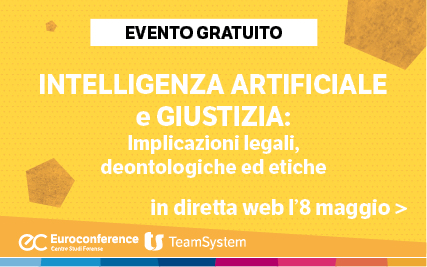






26 Aprile 2023 a 15:08
Buongiorno avvocato,
al di là di una formulazione complessivamente non molto chiara dell’articolo, che mi è costata un po’ di fatica nella comprensione di alcuni enunciati, desideravo richiamare la Sua attenzione su alcuni vizi presenti nella esposizione dei fatti così come narrati.
Lei dice che il tribunale di primo grado giudicava inattendibili le dichiarazioni rese dalla terza trasportata, ascoltata come testimone nonostante l’eccezione di formulata dall’assicurazione, epperò poi Lei scrive, in relazione al ricorso presentato dagli eredi, che il giudice di secondo grado ha condiviso la statuizione del primo giudice in ordine all’incapacità a testimoniare della terza trasportata.
E’ evidente dunque che la testimone o è stata giudicata inattendibile o è stata dichiarata incapace a testimoniare.
Poi Lei cita un virgolettato della Cassazione che, evidentemente, è riportato male: ““Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità…”.
E’ evidente, infatti, che la testimonianza così assunta non è affatto affetta da nullità – cioè in virtù della formulazione della eccezione – ma è nulla se la eccezione è poi giudicata fondata.