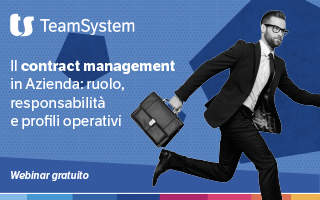Le opposizioni endoesecutive sono strutturalmente e necessariamente bifasiche, ma il procedimento è comunque unico ai fini della litispendenza
di Stefania Volonterio, Avvocato Scarica in PDFLa Cassazione, con la pronuncia n. 25170 dell’11 ottobre 2018, ha chiarito che le opposizioni esecutive hanno una struttura bifasica necessaria e che, pertanto, la prima fase sommaria è necessaria ed ineludibile, pena l’inammissibilità della successiva fase a cognizione piena. Rimane, tuttavia, la necessità, a particolari fini, di considerare queste due fasi come parti di un unico procedimento.
Con la sentenza n. 25170 dell’11 ottobre 2018 della Terza Sezione Civile, la Corte di cassazione aggiunge un nuovo tassello al tema della natura bifasica delle opposizioni esecutive.
Come noto, sia l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. sia l’opposizione agli atti esecutivi di cui al successivo art. 617 c.p.c. sia, infine, l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. danno vita a un procedimento che si struttura in due fasi, che così si possono brevemente descrivere: una prima fase sommaria, nella quale al giudice viene chiesta la pronuncia di un provvedimento di natura cautelare, volto alla sospensione del processo esecutivo; una seconda fase a cognizione piena, volta a valutare funditus le doglianze mosse con l’opposizione.
Sull’ineludibilità della struttura bifasica è intervenuta, da ultimo, la pronuncia della Suprema Corte della quale si è dato conto in principio (Cass. n. 25170/2018), che ha avuto ad oggetto un caso nel quale è stata proposta un’opposizione agli atti esecutivi mediante la diretta instaurazione (peraltro con ricorso e non con atto di citazione) del giudizio di merito, con la totale omissione della fase sommaria.
La Corte di cassazione, nel solco di una precedente consolidata giurisprudenza, censura il giudice del merito, che ha considerato la fase sommaria, siccome evitabile dall’opponente che non abbia interesse ad ottenere un provvedimento cautelare di sospensione del procedimento esecutivo e ribadisce la natura indefettibilmente bifasica dell’opposizione.
Innanzitutto, chiarisce la Corte, è necessario che “il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell’ambito del processo esecutivo”: ciò sia per favorire la possibilità che le parti, anche in ragione della concessione o meno della sospensione del processo esecutivo, possano valutare se proseguire o abbandonare l’opposizione stessa; sia affinché il giudice dell’esecuzione, evidentemente così edotto della proposta opposizione, possa eventualmente esercitare i suoi poteri ufficiosi volti a garantire la regolarità della procedura o una sua corretta direzione, così magari giungendo a una sorta di “autocorrezione”, che renda superflua la prosecuzione dell’opposizione proposta.
La Corte si sofferma anche sulla necessità di tutelare gli interessi di tutte le parti del processo esecutivo, tra i quali, in particolare, gli intervenuti e gli “eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto” (ad es., i potenziali interessati all’acquisto del bene staggito).
Infine, la Cassazione passa all’enunciazione di ragioni sistematiche a sostegno della necessarietà della fase sommaria, sottolineando che “la stessa previsione dell’assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, all’esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell’opponente”, mentre può mancare, dopo quella sommaria, la fase a cognizione piena, che rimane, essa sì, meramente eventuale.
Con questa recente pronuncia, la Cassazione chiarisce che le opposizioni esecutive non solo hanno una natura bifasica, ma che tale struttura è necessaria e imprescindibile.
Si deve tuttavia prestare attenzione al fatto che questa “bifasicità” continua ad avere caratteri peculiari: se, infatti, da un lato, le due fasi del procedimento mantengono comunque, seppure nei limiti visti sopra, una propria reciproca autonomia e sono poi diverse quanto a modalità di introduzione (ricorso/atto di citazione) e regole procedimentali (rito camerale/rito ordinario), dall’altro lato la giurisprudenza, per altri versi, considera comunque l’opposizione come procedimento unico ed unitario.
Quanto al primo aspetto, è noto, ad esempio, che il provvedimento di sospensione eventualmente pronunciato nella fase sommaria ex art. 624 c.p.c. è idoneo a sopravvivere alla mancata instaurazione della fase di merito (che, come detto sopra, è solo eventuale) ed anzi a determinare l’estinzione della procedura esecutiva, ai sensi del 3° comma dello stesso art. 624 c.p.c.; ed è altrettanto noto che il medesimo provvedimento di sospensione può essere oggetto di autonoma impugnazione mediante reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., senza che per proporre il gravame si debba attendere la sentenza che definisce la fase a cognizione piena.
L’affermarsi di una concezione comunque unitaria del procedimento di opposizione, seppure bifasico, ha portato a statuire che il ricorso introduttivo dell’opposizione, sia essa agli atti esecutivi o all’esecuzione (con la precisazione che quest’ultima, nel caso il processo esecutivo non sia ancora iniziato, si introduce con citazione nelle cause soggette al rito ordinario e con ricorso in quelle soggette al rito del lavoro, a mente dell’art. 618 bis c.p.c.) è idoneo a “reggere” tutto il successivo procedimento.
Deriva da ciò, ad esempio, che a seguito della riforma dell’art. 327 c.p.c. con la riduzione da un anno a sei mesi del termine di impugnazione, il momento decisivo per determinare l’applicabilità o meno del novellato termine è stato identificato in quello di proposizione del ricorso introduttivo della fase sommaria dell’opposizione, proprio perché “l’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta in due fasi, di cui una sommaria e l’altra a cognizione piena, è e resta un unico procedimento, per cui, ai fini dell’applicazione del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria” (Cass. 9352/2017, commentata da R. Metafora in www.eclegal.it che, conformemente a Cass. 9246/2015, ha superato il precedente orientamento espresso della stessa Cassazione con la sentenza 22838/2012, secondo il quale “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell’applicazione del termine lungo – ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – per l’impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito”).
Ed ancora, la concezione unitaria dell’opposizione ha portato con sé anche l’inapplicabilità a tutte le due fasi del procedimento, e quindi anche a quella che si svolge nelle forme del rito ordinario, della sospensione feriale dei termini (così Cass. 13928/2010).
In ultimo, occorre dare conto dell’esistenza di situazioni “ibride”, come quella relativa alla statuizione sulle spese di causa, tema sul quale la Cassazione ha avuto modo di affermare che “nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito”.
Siamo quindi di fronte ad un fenomeno complesso, che impone all’operatore di prestare attenzione alle possibili insidie di procedimenti che sono strutturalmente bifasici sul piano procedurale, ma unitari quanto a pendenza della lite.