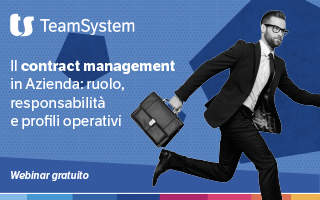La responsabilità civile delle (e nelle) strutture sanitarie per difetto di organizzazione
di Mirko Faccioli, Avvocato e Professore associato di diritto privato Scarica in PDFLa responsabilità civile per danni alla salute del paziente riconducibili a carenze strutturali ed organizzative degli enti sanitari ha iniziato ad emergere in giurisprudenza e attirare l’attenzione della dottrina indicativamente a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, in stretta connessione con il più vasto fenomeno del passaggio dalla responsabilità del medico alla responsabilità medica (o sanitaria) e con la presa di coscienza dell’irriducibilità del rapporto contrattuale intercorrente tra la struttura sanitaria e il paziente allo schema del contratto d’opera intellettuale facente capo alla figura del medico libero professionista.
Da quest’ultimo punto di vista è stato infatti messo in evidenza che, con la conclusione del contratto (atipico e complesso) «di spedalità» (o «di assistenza sanitaria»), la struttura ospedaliera si obbliga a garantire al malato, accanto alla prestazione diagnostica e terapeutica erogata anche dal medico libero professionista, un’ampia ed eterogenea serie di prestazioni accessorie quali, per esempio, vitto e alloggio – vale a dire prestazioni lato sensu alberghiere – in caso di ricovero, l’assistenza infermieristica, la fornitura di medicinali, l’apprestamento delle attrezzature tecniche e degli impianti necessari all’esecuzione della prestazione medica in senso stretto, e così via.
In forza di queste considerazioni è emersa, pertanto, una distinzione tra il profilo dell’organizzazione dell’attività medica e il profilo della prestazione stricto sensu sanitaria che ha aperto le porte alla possibilità di configurare, in caso di danni cagionati al paziente dalla mancata o scorretta esecuzione delle prestazioni accessorie a quella medica di cui si è detto sopra, una responsabilità diretta dell’ente sanitario per deficienze strutturali e organizzative, distinta ed autonoma tanto dalla responsabilità personale dei professionisti che operano al suo interno quanto dalla responsabilità c.d. vicaria e indiretta per i danni cagionati dai medesimi. Questa forma di responsabilità – di natura oggettiva, secondo l’impostazione prevalente – può essere affermata, in particolare, quando l’ente nosocomiale non garantisce, tra le altre cose: la sicurezza e la salubrità dell’ambiente ospedaliero e delle attrezzature utilizzate per le cure (si pensi, per esempio, al tema delle infezioni nosocomiali); la disponibilità di tutti gli strumenti e i macchinari necessari per l’esecuzione della prestazione sanitaria, compresi quelli atti fronteggiare eventuali complicanze ed emergenze; la disponibilità di personale, sia medico che paramedico, adeguatamente qualificato e in numero sufficiente; la custodia e la protezione dei pazienti in tutto in parte privi della capacità di autotutela (ad iniziare da minori e malati di mente); l’efficienza dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane e materiali a sua disposizione (per esempio nell’apprestamento dei turni di servizio).
Una volta stabilito che la struttura sanitaria risponde senz’altro dei pregiudizi alla salute del paziente causati dalle proprie carenze strutturali e organizzative, va precisato che l’inadeguatezza dell’apparato organizzativo e strutturale dell’ospedale non elimina né attenua i profili di responsabilità in capo al singolo professionista sanitario, che anzi viene, in tali casi, ad incontrare una serie di specifici e appositi doveri, finalizzati a tutelare la salute del paziente di fronte alle inefficienze organizzative dell’ente, l’inadempimento dei quali viene sanzionato tramite il suo coinvolgimento nel giudizio di responsabilità della struttura secondo la regola della solidarietà.
Da un esame complessivo della materia sembra quindi potersi affermare che il difetto organizzativo fa gravare sul sanitario nuovi e diversi compiti, quali: verificare l’adeguatezza della struttura – anche dal punto di vista della professionalità del personale che lavora al suo interno – nella quale dovrebbe essere erogata la prestazione diagnostica o terapeutica; informare il paziente delle deficienze strutturali e organizzative delle quali egli sia a conoscenza, in modo che il malato possa consapevolmente decidere di sottoporsi al trattamento in quella piuttosto che in un’altra struttura; nel caso in cui il paziente non sia in grado di prendere questa decisione, attivarsi perché venga trasportato e assistito in un nosocomio più efficiente e adeguato alle sue esigenze; infine, nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo finora descritto, fare tutto quanto rientra nelle sue possibilità per cercare di sopperire alle deficienze dell’apparato organizzativo e strutturale in cui dovrà comunque essere eseguito il trattamento medico. Ed è importante evidenziare che destinatario del dovere in esame è non soltanto il medico dipendente dell’ospedale, ma pure il c.d. medico di fiducia del paziente, vale a dire il libero professionista che, avvalendosi delle apparecchiature nonché del personale paramedico e infermieristico messogli a disposizione da una clinica alla quale egli non è però legato da alcun rapporto di lavoro o di servizio, provvede ad eseguire il trattamento diagnostico o terapeutico promesso direttamente al proprio cliente sulla base di un contratto d’opera intellettuale.
Si tratta di profili, quelli sinteticamente esposti, che sono tra l’altro destinati a rivestire ancora maggior importanza pratica con l’entrata in vigore della c.d. Legge Gelli-Bianco del marzo 2017, considerato che quest’ultima vede tra i suoi aspetti fondamentali quello di garantire la sicurezza delle cure e impone di perseguire tale obiettivo (anche) mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie nonché tramite l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative degli enti nosocomiali.