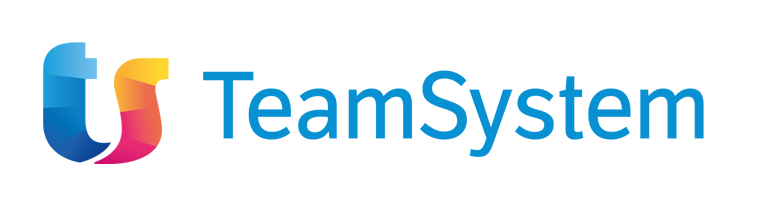La nuova condizione di procedibilità ex art. 696 bis c.p.c. nelle controversie in materia di responsabilità medico-sanitaria
di Marika Ragni Scarica in PDFLa legge n. 24 del 2017, mediante l’introduzione della condizione di procedibilità ex art. 696 bis c.p.c. in alternativa alla mediazione, rappresenta un tentativo, non del tutto convincente, di promuovere il c.d. case management delle controversie di responsabilità medico-sanitaria. Infatti, sebbene la riforma intenda valorizzare l’anima conciliativa dell’istituto, non offre un articolato che aggiunga al mero ostacolo della procedibilità una più accorta strutturazione del procedimento. Occorrerà, comunque, attendere le prime applicazioni giurisprudenziali per valutare gli effetti del potenziamento di questo strumento.
Il 1° aprile 2017 è entrata in vigore la legge di riforma della responsabilità medico-sanitaria (l. n. 24 del 2017) che all’art. 8 introduce, per l’azione civile di risarcimento danni, l’ulteriore condizione di procedibilità della consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., oltre a quella della mediazione già introdotta dall’art. 5, d.lgs. n. 28 del 2010.
Tale novità legislativa impone una rimeditazione dei rapporti tra l’ormai collaudato istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, la mediazione ed il processo, allo scopo di verificare l’impatto della scelta di assurgere lo stesso al rango di condizione di procedibilità, lasciandone sostanzialmente immutato lo schema legislativo.
La c.d. consulenza tecnica a fini conciliativi rientra tra le forme di a.d.r. che più si collocano in prossimità del contesto giurisdizionale (tant’è che è stata ricondotta alla categoria della conciliazione delegata da Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, in Riv. dir. proc., 2005, p. 781), sotto il controllo del giudice e la guida di un consulente – tecnico ma anche conciliatore – la cui indagine potrebbe, alternativamente, consentire la soluzione conciliativa della controversia o confluire in un processo a cognizione piena come materiale probatorio.
La collocazione sistematica all’interno dei procedimenti di istruzione preventiva e lo sganciamento dal presupposto cautelare del periculum, danno ragione della natura composita dello strumento, nel quale, accanto alla funzione conciliativa, permane la finalità di pura anticipazione d’una porzione dell’istruttoria ordinaria.
Il dibattito ancora attuale riguarda, infatti, il rapporto tra le due funzioni o, piuttosto, la prevalenza dell’una sull’altra, da cui si fanno conseguire diverse implicazioni in punto di valutazione della sua ammissibilità. Tuttavia, la rigida valutazione di ammissibilità del ricorso predicata da parte della recente giurisprudenza (Trib. Napoli 20 febbraio 2017, e 5 dicembre 2016, in Dejure; Trib. Milano 6 aprile 2017, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 8 febbraio 2017, in www. Dejure; contra Trib. Foggia 09 maggio 2016, in www.ilcaso.it), che la esclude nel caso in cui il dissidio tra le parti verta sull’an debeatur, dovrà essere rimeditata alla luce dell’introduzione della condizione di procedibilità.
Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 8, comma 2°, inoltre, suggerisce di ritenere adempiuta la condizione con la sola presentazione del ricorso, anche se questo viene dichiarato inammissibile, a meno di non voler riconsiderare anche il consolidato orientamento secondo cui l’ordinanza di rigetto non è impugnabile né riproponibile (ex multis, v. Cass. 7 marzo 2013, n. 5698, in Dejure).
Con lungimiranza, la nuova previsione lascia prefigurare una gestione multistep della fase iniziale del procedimento, ispirandosi al c.d. case management, ossia alla possibilità da parte del giudice di modellare lo schema processuale del caso concreto in base alla complessità della lite.
La legge n. 98 del 2013 (di conversione del c.d. decreto del fare), modificando l’art. 5, comma 4°, lett. c), d.lgs. n. 28 del 2010, aveva già chiarito la questione relativa al rapporto tra il tentativo obbligatorio di mediazione ed il procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c., configurandoli quali istituti funzionalmente alternativi.
Oggi, l’alternatività viene ribadita dalla norma in commento, secondo cui l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ed in tal caso, ove il giudice rilevi che il procedimento «non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento».
La disposizione solleva qualche perplessità, oltre che per l’approssimazione del linguaggio tecnico utilizzato, soprattutto perché lascia aperto il problema del coordinamento con le regole del procedimento di mediazione.
È opportunamente previsto che, qualora la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi, la domanda divenga procedibile e gli effetti della stessa retroagiscano se, entro i successivi 90 giorni, è depositato il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.
Sebbene la prassi giudiziaria dimostri l’eccesso di ottimismo del legislatore – poiché difficilmente è possibile esaurire l’intero iter procedurale in tale lasso di tempo – la norma cerca un contenimento dei tempi di accesso alla tutela giurisdizionale, noto cavallo di battaglia della tendenza alla c.d. degiurisdizionalizzazione del contenzioso.
Anche in questo caso, dunque, si cerca di assicurare la compatibilità con il precetto costituzionale dell’art. 24 mediante l’indicazione di un periodo massimo di durata e l’anticipazione degli effetti della domanda giudiziale (tra i tanti, v. Dittrich, Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in www.judicium.it).
Tuttavia, la disciplina lascia residuare numerosi dubbi interpretativi che di seguito ci si limita a segnalare, rinviandone la valutazione alla luce delle prime applicazioni giurisprudenziali.
In primo luogo, l’asimmetrica regolazione della condizione di procedibilità rispetto all’omologa fattispecie della mediazione non sembra rispondere ad una precisa esigenza processuale: mentre in caso di mediazione in corso il giudice si limita a rinviare di tre mesi il processo, con riferimento all’art. 696 bis c.p.c. si pretende che la parte più diligente presenti un formale atto d’impulso alla procedura, definita istanza «di completamento del procedimento».
L’imposta riassunzione ad istanza di parte non trova giustificazione a meno che si ipotizzi l’interruzione o la sospensione della procedura a fini conciliativi, in seguito alla proposizione della domanda giudiziale. Tale evenienza non pare in linea con le caratteristiche del procedimento, poiché l’eventuale inerzia dell’ausiliario sarebbe censurabile dal giudice quale grave motivo per la sostituzione del c.t.u., a norma dell’art. 196 c.p.c.
Sembrerebbe comunque doversi escludere che l’improcedibilità sanzioni anche la mancata proposizione della menzionata istanza nel termine di 15 giorni fissati dal giudice con ordinanza, predicata invece da certa giurisprudenza con riferimento alla mediazione (Trib. Lamezia Terme 22 giugno 2012, Trib. Roma 26 marzo 2012, entrambe in www.ilcaso.it). Di conseguenza, il rigetto in rito per improcedibilità dovrebbe sopraggiungere nel solo caso in cui non sia mai stato depositato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
Si è persa l’occasione per chiarire la natura ordinatoria del termine suddetto, nonostante le notevoli incertezze interpretative sollevate dall’analoga disposizione inserita nella disciplina della mediazione (alla luce dell’approccio ancora in voga che, ad onta dell’art. 152, comma 2°, c.p.c., ammette la perentorietà anche qualora questa non sia espressamente prevista dalla legge: Trib. Bari 4 ottobre 2016, in www.ilcaso.it; Trib. Firenze 4 giugno 2015, in Dejure).
Viceversa, viene immotivatamente sancita la natura perentoria del termine di durata massima di sei mesi, con disposizione che, da un lato, si presta a strumentalizzazioni dilatorie e, dall’altro, rende insensibile il procedimento alle peculiarità del caso concreto, impedendo al giudice di ampliarlo nell’ipotesi in cui le indagini peritali risultino particolarmente complesse, nonostante l’accordo delle parti e giusto il disposto dell’art. 153 c.p.c.
Peraltro, il problema del mancato allineamento dei termini di durata massima della mediazione e dell’a.t.p. a fini conciliativi dovrà trovare una soluzione rispettosa della libertà delle parti di scegliere il mezzo di conciliazione più consono alle proprie esigenze, nonché del potere del giudice di governare il processo in un’ottica di riequilibrio della posizione delle parti, non solo sul piano formale, ma anche della tutela sostanziale.
Il c.d. case management del processo, infine, non riguarda solo la valutazione sulla procedibilità, ma si spinge fino a quella relativa al rito applicabile: l’art. 702 ter c.p.c. consente comunque al giudice di disporre il passaggio al rito ordinario qualora il caso richieda un’istruttoria più complessa.
Qualora il procedimento non fosse concluso, quale che sia la ragione, nel termine perentorio di sei mesi, sembra opportuno ammettere che il giudice, investito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia legittimato a disporre l’integrazione delle operazioni peritali, eventualmente previa conversione del rito. È altresì ragionevole assumere che la relazione depositata dopo il decorso del termine di sei mesi sia liberamente valutabile come prova atipica.
Ulteriori criticità si rinvengono nel quarto comma dell’art. 8 l. n. 24 del 2017, che introduce l’inderogabile obbligo di partecipazione di tutte le parti (decretando il superamento dell’opinione che ammetteva l’operatività della contumacia: Trib. Milano 13 aprile 2011, Corriere merito, 2012, 141), ma senza chiarire come esso debba attuarsi. Plausibilmente, si potrà riferirlo all’obbligatoria partecipazione dei consulenti di parte, escludendo l’estensione dell’orientamento che in tema di mediazione richiede la presenza personale della parte a fianco dell’avvocato (Trib. Pavia 2 febbraio 2015; Trib. Bologna 11 novembre 2014, entrambe in www.ilcaso.it).
Soltanto un breve cenno può concedersi al draconiano corredo di sanzioni riservate alla parte che non partecipa al procedimento. Le perplessità si nutrono soprattutto con riferimento all’emancipazione delle penalità in discorso da ogni valutazione in termini di soccombenza: ciò potrebbe dare adito a comportamenti abusivi dei danneggiati che, nonostante l’infondatezza delle loro pretese, intendessero esercitare e coltivare l’azione risarcitoria al solo scopo di conseguire la refusione dei costi di consulenza e di lite, nonché il pagamento della pena pecuniaria.
In definitiva, difetta ancora una compiuta disciplina capace di garantire l’economia processuale sia nella forma che nella sostanza: neppure un cenno, infatti, si concede alla regolazione della specifica competenza professionale del consulente-mediatore, né di una formalizzata – ma flessibile – dialettica tra le parti e tra queste e il giudice.