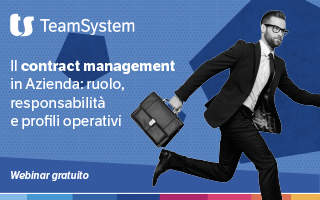La natura giuridica e gli effetti del regolamento del supercondominio
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. II, 10 settembre 2019, n. 30246 – Pres. Felice – Rel. Scarpa
[1] Comunione – Diritti reali – Condominio negli edifici – Regolamento di condominio – Supercondominio – Clausole delimitanti i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive – Opponibilità ai successivi acquirenti – Condizioni – Fondamento – Configurabilità come atto di liberalità – Esclusione – Ragioni
(Cod. civ. artt. 1117, 1117 bis, 1138).
[1] “Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall’originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l’uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. L’attribuzione in comproprietà di cose non ricomprese nell’art. 1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalità, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio.”
CASO
[1] La pronuncia in epigrafe trae origine dalla controversia insorta tra un supercondominio, proprietario, tra le altre, di un’area oggetto di piano di lottizzazione preservata dall’edificazione in vista della realizzazione di un porto, e una società costruttrice.
I rapporti fra le parti erano contenuti nell’art. 4 del regolamento del supercondominio che, oltre a prevedere una serie di diritti reali di godimento in favore della costruttrice, utili alla realizzazione del porto, tra cui un diritto di superficie ex artt. 952 e ss. c.c. e alcuni diritti di servitù, sanciva anche la comproprietà di tali terreni subordinata alla condizione risolutiva per la quale, se entro 19 anni dalla data di deposito del regolamento per realizzare il porto si fosse reso necessario dismettere e/o comunque trasferire porzioni dell’area all’autorità competente o a terzi, queste sarebbero tornate di proprietà esclusiva del supercondominio, con l’obbligo di trasferirle a chi di competenza.
Decorso inutilmente tale termine senza che venisse costruito il porto, il supercondominio citava in giudizio la costruttrice chiedendo al giudice, tra le altre, di accertare il mancato avveramento della condizione risolutiva e il consolidamento della proprietà piena ed esclusiva delle aree oggetto di lite; di dichiarare estinti i diritti di superficie e di servitù previsti nel regolamento di condominio e di accertare che la realizzazione del porto non fosse più possibile.
Il Tribunale, acclarato il mancato avveramento della condizione risolutiva, dichiarava l’acquisizione della proprietà piena ed esclusiva in capo al supercondominio e la risoluzione delle clausole attributive dei diritti di superficie e di servitù ed affermava, inoltre, che la costruzione del porto doveva ritenersi impossibile alla stregua delle disposizioni normative sopravvenute ordinando, di conseguenza, il rilascio dell’area occupata dalla convenuta. Parimenti la Corte d’appello adita, con motivazioni parzialmente diverse, confermava la decisione di merito e, pertanto, la società soccombente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi.
SOLUZIONE
[1] Per quanto di interesse, con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 1138 c.c. sostenendo che, dal momento che il “regolamento di condominio” disciplina i diritti e gli obblighi dei condomini, “tra i quali evidentemente non rientra il supercondominio”, la Corte d’Appello avrebbe errato nel qualificare il regolamento in esame come regolamento di condominio, idoneo a trasferire al supercondominio un diritto reale sull’area oggetto di lite, ma avrebbe dovuto qualificarlo come donazione nulla per mancanza di forma e di bilateralità.
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, nel rigettare il ricorso principale, ha analizzato la natura giuridica del regolamento del supercondominio e ha precisato che, nel caso di specie, trattandosi di un regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio, tale regolamento non è mai qualificabile come atto di liberalità bensì come regolamento di condominio.
QUESTIONI
[1] La sentenza in epigrafe offre l’occasione per analizzare brevemente la natura giuridica del supercondominio e del relativo regolamento.
Il termine supercondominio viene comunemente impiegato per designare una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni –
quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc. – in rapporto di accessorietà con i fabbricati (così Cass. civ. n. 9096/2000; Cass. civ. n. 14791/2003).
Per quanto riguarda la disciplina applicabile una parte della dottrina, sull’assunto che nel supercondominio coesisterebbero parti in condominio e parti in comunione, riteneva applicabile ad ognuna di esse la relativa disciplina, a seconda della diversa funzione realizzata dai beni comuni. In particolare, se tali beni non erano necessari per l’esistenza o per l’uso delle unità abitative, avrebbero trovato applicazione le norme dettate in tema di comunione, mentre se le cose comuni erano in rapporto di accessorietà con le porzioni immobiliari si sarebbero applicate le norme sul condominio. Altra parte della dottrina optava per l’applicazione del regime della comunione, mentre un ulteriore orientamento dottrinale era favorevole all’applicabilità della disciplina condominiale (artt. 1117- 1139 c.c.).
In giurisprudenza, invece, sin da prima della riforma del condominio, l’orientamento maggioritario riteneva applicabile estensivamente al supercondominio la disciplina del condominio degli edifici purché i beni di cui all’art. 1117 c.c. fossero comuni ad una pluralità di edifici distinti, ciascuno dei quali costituente un condominio autonomo, e purché tra i beni comuni e i beni oggetto di proprietà esclusiva sussistesse un rapporto di accessorietà ossia un collegamento materiale o funzionale. La normativa della comunione ordinaria, al contrario, si riteneva applicabile relativamente a beni e impianti, anche posti nello stesso complesso residenziale, privi della relazione di accessorietà, ma dotati di una propria autonoma utilità (Cass. civ. n. 14791/2003; Cass civ. n. 9096/2000; Cass. civ. n. 7286/1996).
La diatriba dottrinale e giurisprudenziale in merito alla disciplina applicabile all’istituto del supercondominio è stata risolta dal legislatore nel 2012, il quale, nell’ambito della più ampia riforma del condominio, ha provveduto ad inserire, all’interno del codice civile, l’art. 1117 bis il quale prevede espressamente l’applicazione diretta delle disposizioni contenute negli artt. 1117 ss. c.c., in quanto compatibili, «in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.».
Il supercondominio, quindi, è una particolare forma di condominio che si realizza, al pari di quest’ultimo, non appena più soggetti acquistino la proprietà di singole unità immobiliari riconducibili ad un comprensorio includente parti di interesse comune aventi carattere di necessità, e che determina, ex lege, una situazione di contitolarità di tali parti, derogabile solo con l’assenso di tutti i comproprietari. Ovviamente, nel supercondominio, solo l’amministrazione dei beni oggetto di proprietà comune fra i condomini che lo compongono segue le regole del condominio, mentre l’amministrazione dei beni di proprietà esclusiva e dei servizi necessari ad ogni singolo condominio che compone il supercondominio rimane completamente autonoma.
Al pari del condominio, pertanto, anche il supercondominio viene in essere ipso iure et facto, ove il titolo non disponga altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto (Cass. civ. n. 2279/2019; Cass. civ. n. 27084/2018; Cass. civ. n. 1344/2018; Cass. civ. n. 27094/2017; Cass. civ. n. 19939/2012; Cass. civ. n. 3945/2008; Cass. civ. n. 2305/2008).
Per quanto riguarda, invece, la natura giuridica del relativo regolamento, l’art. 1138 c.c. dispone che, quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento contenente norme che disciplinino l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese. Il supercondominio, di frequente, supera questa soglia dimensionale e, pertanto, la relativa organizzazione viene disciplinata da uno specifico regolamento supercondominiale che si affianca a quelli dei singoli condomini. Il suo contenuto, tipico e necessario, al pari del regolamento di un singolo condominio, consiste nella previsione di norme attinenti all’uso delle cose comuni e nella ripartizione delle spese, da effettuarsi secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché in norme dettate per la tutela del decoro dell’edificio e relative all’amministrazione del medesimo. Nella struttura supercondominiale, poi, il regolamento può prevedere anche pattuizioni particolari attinenti a specifiche destinazioni della cosa comune, alla costituzione di diritti reali di godimento, come, ad esempio, diritti di servitù, salvo l’impossibilità, per le norme regolamentari, di poter in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino quali risultano dagli atti di acquisto o da successive deliberazioni assembleari.
Il regolamento del supercondominio può essere predisposto, in via unilaterale, dall’unico originario proprietario che, in genere, è il costruttore dell’intero sistema edilizio. In questi casi, l’orientamento consolidato della giurisprudenza, avallato anche dalla sentenza in epigrafe, afferma che «il regolamento di un supercondominio, predisposto dall’originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l’uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca» (in questi termini Cass. civ. n.14898/2013).
La Suprema Corte, nel caso in commento, specifica ulteriormente che il regolamento di supercondominio di contenuto convenzionale, predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio ed accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti, in quanto espressione di autonomia negoziale, può attribuire la comproprietà di cose, non incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 c.c., ai condomini partecipanti al complesso, indipendentemente dalla sussistenza di fatto del rapporto di strumentalità che determina la costituzione ex lege del condominio edilizio e dello stesso supercondominio (cfr. Cass. civ. n. 29908/2018; Cass. civ. n. 4432/2017 e Cass. civ. n. 15794/2002).
La Seconda Sezione, in altri termini, sottolinea che il regolamento del supercondominio, anche quando ha ad oggetto l’attribuzione in comproprietà di beni non ricomprese nell’art. 1117 c.c., mantiene la sua natura convenzionale e non costituisce un atto di liberalità, come, invece, avrebbe voluto il ricorrente nel caso oggetto della sentenza n. 30246/2019.