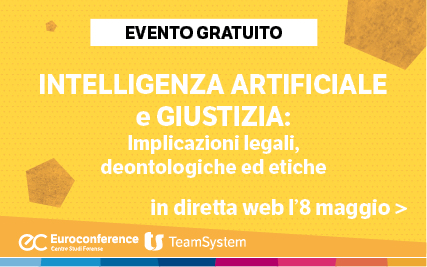La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, sent. 18 marzo 2021, n. 7770 – Pres. Frasca – Rel. Sconditti
[1] Responsabilità – Risarcimento del danno – Danni non patrimoniali – Danno da perdita del rapporto parentale – Condizioni di risarcibilità – Liquidazione del danno – Tabelle milanesi
(Cod. civ. artt. 1223; 1226; 2059)
[1] “Va premesso che nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione”
CASO
[1] Dopo un breve ricovero di 8 giorni, Tizio decedeva in una struttura ospedaliera e i suoi familiari ricorrevano al Tribunale adducendo che l’evento morte era stato causato da una totale omissione di attività diagnostica e chiedendo, quindi, l’accertamento della responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda mentre la Corte territoriale adita riformava parzialmente la sentenza. In particolare, in merito ai danni risarcibili, la Corte concordava con il primo giudice circa l’esclusione della risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita del bene della vita, invece, relativamente al danno da perdita parentale iure proprio, facendo riferimento alle tabelle milanesi, evidenziava che le stesse prevedono una forbice tra € 163 mila ed € 327 mila e che i criteri equitativi di liquidazione dovevano tenere conto dell’età dell’uomo al momento del decesso (74 anni), nonché della convivenza dei familiari che invocavano il relativo ristoro da perdita parentale. La Corte d’appello riteneva, quindi, eccessivo l’importo liquidato dal primo giudice e lo rideterminava anche in considerazione del fatto che la vittima risiedeva all’estero.
SOLUZIONI
[1] Per quanto di interesse con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione o falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 1223, 1226 e 2059 c.c., art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dal momento che lo stesso Tribunale di primo grado aveva accertato ed affermato che la morte dell’uomo era sopraggiunta a distanza di un apprezzabile lasso di tempo tra il manifestarsi della lesione all’integrità psicofisica e il decesso. Detto lasso temporale è tale da integrare il danno biologico terminale e da rendere meritevole di tutela risarcitoria, trasmissibile agli eredi, anche il danno morale catastrofale, avendo l’uomo subìto in modo vigile tutta la sofferenza dell’agonia. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza in relazione ai vizi rilevati e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, fornendo importanti precisazioni in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento offre l’occasione per fare delle brevi considerazioni in tema di danni non patrimoniali risarcibili in caso di decesso.
Occorre premette che, negli ultimi approdi giurisprudenziali anche a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. civ. n. 15350 del 2015 con nota di L. D’ACUNTO, Le sezioni unite riaffermano l’irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, in Nuova Giur. Civ., 2015, 11, 11008; R. FOFFA, Il danno da morte tra Epicuro e Guglielmo D’Occam, in Nuova Giur. Civ., 2015, 11, 11008; P. VALORE, Le sezioni unite confermano l’irrisarcibilità agli eredi del c.d. danno “tanatologico”, in Giur. It., 2015, 10, 2063), la giurisprudenza ha sottolineato che alla vittima può essere risarcita la perdita di un bene avente natura non patrimoniale nella misura in cui la stessa sia ancora in vita. In altre parole il diritto alla reintegrazione della perdita subita presuppone la capacità giuridica ossia è riconoscibile soltanto in favore di un soggetto esistente. I danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili iure hereditatis, sono i seguenti:
- il danno biologico (c.d. danno terminale, dunque la lesione del bene della salute) quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso. L’accertamento di tale danno è questione di fatto, e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, essendo necessario a tal fine, che tra l’evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo (la giurisprudenza è vasta: Cass. civ. n. 1877 del 2006; Cass. civ. n. 15491 del 2014, Cass. civ. n. 22228 del 2014, Cass. civ. n. 23183 del 2014);
- il danno morale soggettivo (c.d. catastrofale o da lucida agonia), consistente nella sofferenza sopportata dalla vittima nel comprendere l’inevitabilità della fine imminente. Anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l’accertamento dell’an presuppone «la prova della cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della fine» (i precedenti sono numerosi: Cass. civ. n. 6754 del 2011 con nota di L. V. BERRUTI, Nota in tema di danno non patrimoniale da morte, in Giur. It., 2012, 4, 796; Cass. civ. n. 7126 del 2013, Cass. civ. n. 13537 del 2014).
Il danno biologico terminale deve essere tenuto debitamente distinto dal danno psicologico-morale ed, infatti, ai fini del riconoscimento del danno biologico terminale, elemento rilevante è il trascorrere del tempo tra la lesione e il decesso mentre non ha importanza la presenza della lucidità della vittima, presupposto, al contrario, essenziale per il riconoscimento del danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale).
Ciò che rileva ai fini del riconoscimento del danno morale catastrofale è l’intensità della sofferenza morale, a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso ed, invece, nel danno biologico terminale unicamente il lasso di tempo intercorso.
Se, quindi, le Sezioni Unite nel 2015 (e poi la successiva giurisprudenza) affermarono la necessità, ai fini del riconoscimento del danno iure hereditatis, che il decesso non si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo, in quanto viene meno il soggetto cui sia riferibile il danno e al cui patrimonio sia acquisibile il credito risarcitorio, ove, invece, un certo lasso di tempo tra l’evento e il decesso esiste, la situazione cambia radicalmente. Infatti, «la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto “capace” di essere titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2) con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione – inferita a soggetto titolare di capacità giuridica – dalla morte, evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica». Di conseguenza nell’intervallo di tempo tra la lesione ed il decesso sussiste sempre un danno biologico strictu sensu inteso al quale può aggiungersi un danno morale dato dalla consapevolezza dell’imminente decesso.
Ciò posto in merito alla tipologia di danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili iure hereditatis, nella sentenza in epigrafe, la Suprema Corte si sofferma sul profilo liquidativo. Nello specifico il Tribunale, riconoscendo la spettanza del danno non patrimoniale iure hereditatis, aveva liquidato un importo unitario di danno da perdita della vita nel quale erano confluite anche le sofferenze fisiche e psichiche patite prima della morte e della durata dell’agonia, breve ma molto intensa. L’importo non era, dunque, solo la risultante del danno da perdita della vita ma anche del danno biologico terminale e del danno catastrofale, voci di danno domandate dagli originali attori come risultante dagli atti introduttivi. La Corte territoriale, pertanto, secondo la Suprema Corte, escludendo la spettanza del danno da perdita della vita, di fatto, ha omesso di pronunciare in ordine al danno biologico terminale ed al danno catastrofale, il cui risarcimento era stato richiesto dagli attori e su cui aveva pronunciato il Tribunale, accogliendone la relativa domanda. L’importo liquidato in dispositivo dalla Corte territoriale, invece, corrisponde esclusivamente al danno iure proprio, senza che però in sentenza vi sia alcuna statuizione circa il danno biologico terminale e quello catastrofale. L’omissione di pronuncia deriva dalla circostanza che, essendo stato devoluto mediante il gravame il rapporto controverso in appello relativamente al danno iure hereditatis, l’originaria presenza della domanda e relativa pronuncia del Tribunale imponevano al giudice dell’appello di decidere non solo sul danno da perdita della vita ma anche su quello biologico terminale e su quello catastrofale.
In ultima istanza la Suprema Corte, con riferimento alla liquidazione equitativa del danno in riferimento alle Tabelle milanesi, afferma che «nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione» (Cass. 14 novembre 2019, n. 29495; 29 maggio 2019, n. 14746).
Alla luce delle predette osservazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza d’appello.