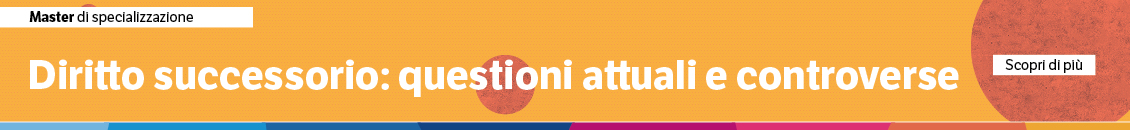Institutio ex re certa e concorrenza con la successione legittima
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24310 del 05/08/2022
Successioni “mortis causa” – successione testamentaria – disposizioni a titolo universale e a titolo particolare – Istituzione di erede “ex re certa” – Possibilità di concorso con erede legittimo – Sussistenza
Massima: “Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione “ex re“, l’erede in tal modo istituito può partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle “res certae” attribuitegli ed il valore dell’intero asse ereditario”.
Disposizioni applicate
Codice Civile, articoli 457 comma 2 e 588 comma 2
[1] Alla morte di Tizia, la successione veniva regolata da un testamento con il quale era attribuita al di lei marito, Tizio, la quota di proprietà (pari ad 1/2) della defunta su di un immobile in regime tavolare.
Caio, fratello della defunta, agiva in giudizio per rivendicare la qualità di erede legittimo della de cuius in concorso con il coniuge superstite. Deduceva che, in contrasto con la devoluzione ex lege dell’eredità, Tizio aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia un certificato di eredità nel quale si assumeva che fosse l’unico erede della moglie. Diversamente, a suo giudizio, il testamento non attribuiva al coniuge se non la quota parte di quell’unico bene, aprendosi sul resto la successione legittima, che vedeva il concorso tra lui ed il coniuge.
Il Giudice di primo grado, accertava che la disposizione di cui sopra costituiva istituzione di erede ai sensi dell’articolo 588 c.c., comma 2, e confermava il certificato di eredità rilasciato dal Tribunale di Gorizia.
Caio proponeva appello avverso tale sentenza, sostenendo che la disposizione testamentaria, correttamente interpretata, costituiva legato e non istituzione di erede, ma si vedeva soccombente anche nel secondo grado di giudizio. La Corte d’appello osservava che, nella specie, ricorrevano una pluralità di elementi che “portano a attribuire a Tizio la qualifica di erede ex re certa ex articolo 588 c.c., comma 2; allo stesso, infatti, la de cuius intese attribuire il bene indicato come frazione rappresentativa dell’intero patrimonio (…)“.
La Corte d’Appello argomentava, fra l’altro, in base al rilievo che “risulta dai documenti di causa che, al momento della redazione del testamento, la de cuius era titolare unicamente del bene indicato nella scheda testamentaria; gli ulteriori beni caduti in successione[1] le pervennero successivamente come risulta dal decreto tavolare del 22 settembre 2003 (…)“.
[2] Caio promuoveva ricorso in Cassazione, articolandolo su tre motivi dei quali è il primo a venire in esame nella presente analisi.
Con tale motivo si censurava la sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto che, al momento della redazione del testamento, la de cuius non avesse altri beni all’infuori della quota degli immobili di cui ha disposto per testamento in favore del coniuge. Si sosteneva che la testatrice, come risultava dalla relazione di consulenza tecnica, fosse comproprietaria dei beni, acquistati in concorso con il fratello a seguito della successione dei genitori, apertesi nel 1980 e nel 1987, prima della redazione del testamento, che risale al 1994, beni che costituivano la parte più cospicua del patrimonio. Si faceva notare ancora che, a seguito di richiesta di informazioni disposta nel corso del giudizio di primo grado, era stato appurato che la de cuius era titolare di cospicue somme di denaro e di investimenti mobiliari.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo fondato, così argomentando.
Dapprima, gli Ermellini ricordano come “di fronte all’attribuzione testamentaria di beni determinati occorre vedere quale sia stata la intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli, ed allora si avrà successione a titolo particolare o legato, ovvero se, pur indicando nominativamente quei beni, il testatore abbia inteso lasciarli quale quota del suo patrimonio, ed allora si avrà successione a titolo universale e istituzione di erede”.
L’analisi dei giudici si sposta, quindi, su quello che, ancora oggi è uno dei punti maggiormente dibattuti in materia: la destinazione dei cespiti dei quali il testatore non abbia espressamente disposto, o perché da lui ignorati, o perché da lui volontariamente taciuti o, ancora, perché sopravvenuti al momento della confezione del testamento.
Viene a tal proposito affermata la possibilità del concorso fra l’istituito ex re certa e l’erede legittimo, richiamando alcuni dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità[2] ed affermando che “in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (…).
La quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda”.
La sentenza in commento conclude, quindi, che “il connotato essenziale della istituzione ex re certa non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio.[3] Ciò che è essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, è la possibilità di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse.[4] Se non vi è quella attitudine, ma l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non può che essere considerato legatario”.
Fatte tutte queste precisazioni in punto di diritto, gli Ermellini applicano i principi enunciati al caso di specie, rilevando che punto focale della questione sia l’indagine sulla composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, ed evidenziando come la Corte d’appello abbia errato laddove ha ritenuto che la testatrice, al momento della redazione del testamento, non avesse altri beni all’infuori della quota degli immobili attribuiti al coniuge.[5]
[3] Se il ragionamento degli Ermellini in ordine alla non corretta valutazione del patrimonio della defunta al momento di redazione del testamento compiuta dal giudice di Secondo grado è certamente condivisibile, ai fini che qui interessano non può non notarsi il tentativo della pronuncia in esame di far apparire come prevalente un orientamento che, forse, così dominante nella giurisprudenza di legittimità non è.
La sentenza in commento, infatti, riporta come nella “giurisprudenza della corte di cassazione, è stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla giurisprudenza più recente, che sembra negare, in termini assoluti, la possibilità del concorso fra l’erede legittimo e l’istituito ex re, che sarebbe l’unico erede in virtù della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria”. Non sembra superfluo precisare come questa posizione, che si vuole quasi ridurre a minoritaria o di scarsa rilevanza, sia quella in realtà assunta dalle Sezioni Unite nel 2018.[6]
Altrettanto non secondario è rilevare come in tutte le pronunce successive a tale data richiamate nella sentenza in commento a sostegno della propria posizione (ed in apparente contrasto con le Sezioni Unite) il giudice estensore e relatore fosse sempre lo stesso, che è il medesimo di quella oggetto dell’odierno commento.
Come si è avuto modo di affermare in altra occasione[7], tale più recente giurisprudenza di legittimità ha sposato la tesi di autorevole risalente dottrina[8] che distingue a seconda che il testatore abbia volutamente omesso dei beni dal testamento ovvero non ne conoscesse l’esistenza o siano sopravvenuti: nella prima ipotesi, dovrebbe concludersi per l’apertura della successione legittima. Nella seconda, invece, sarebbe preminente il ruolo della volontà del soggetto disponente, volta a istituire erede in una quota (indirettamente) determinata quel soggetto, in proporzione all’intero suo patrimonio esistente al momento della redazione.
Tesi che è stata oggetto di critica da parte di altra autorevole dottrina, che non ritiene giustificata una distinzione a seconda della conoscenza o meno dell’esistenza di ulteriori beni al momento di redazione del testamento: una volta accertata la volontà del testatore di assegnare determinati beni come quota di eredità, o quale chiamata universale dell’unico soggetto istituito, non possono non discenderne tutti gli effetti che il sistema, nella sua coerenza, le attribuisce ivi compresa la sua forza espansiva. E non si rinviene alcuna eccezione a tale generale principio che giustifichi una esclusione di tale effetto.[9]
A parere dello scrivente, sembra meglio cogliere nel segno la giurisprudenza più recente che, pur apparendo in contrasto con le Sezioni Unite, costituisce, in realtà, una specificazione e conferma dei principi in essa affermati.
Non si tratta di negare la forza espansiva della chiamata ereditaria, ma solo di precisare che se il testatore non ha indicato tutti i beni di cui conosceva l’esistenza, non può affermarsi che le attribuzioni ex certa re abbiano escluso l’operare della successione legittima. In tale ottica deve essere letto il principio della vis espansiva affermato dalle Sezioni Unite: esso “non si riflette in un diverso modo di applicare la regola del concorso fra i due tipi di successione, ma nell’equiparazione, circa la sorte dei beni non contemplati, tra l’erede istituito ai sensi del primo comma dell’art. 588 c.c. con quello istituito ai sensi del secondo comma della norma. In questi termini il principio vuol dire che l’acquisto dell’istituito ex re certa non è necessariamente limitato alla singola cosa attribuita come quota; con la conseguenza che la successione legittima, qualora non si sia già aperta in applicazione dell’art. 457, comma 2, c.c., non si aprirà autonomamente per i beni ignorati o sopravvenuti.”[10]
[1] Si trattava di alcuni beni alla defunta pervenuti in forza delle successioni dei propri genitori, ma in relazione ai quali l’intavolazione era intervenuta successivamente alla redazione del testamento.
[2] Vengono richiamate Cass. Civ. n. 737/1963 (ove la Suprema Corte ha chiarito che l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede), Cass. Civ. n. 17868/2019 e Cass. Civ. n. 9487/2021.
[3] Nello stesso senso anche Cass. Civ. n. 42121/2021
[4] È la sentenza stessa a richiamare i precedenti di Cass. Civ. n. 5773/1980, n. 2050/1976 e n. 1368/1971
[5] La Suprema Corte ha rilevato un errore della Corte d’Appello laddove non ha considerato che si discuteva di beni in regime tavolare acquistati mortis causa, rispetto ai quali l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione non è estensibile, ed occorre verificare la qualità di erede di un determinato soggetto in base alle ordinarie regole del diritto successorio. Anche in regime tavolare, dunque, “il giudice, chiamato a qualificare una disposizione testamentaria come eredità o legato, o chiamato a stabilire se la disposizione, in ipotesi considerata istituzione ex re, esaurisca o meno l’asse tenuto presente dal testatore, non potrebbe espungere dall’indagine i beni in ipotesi acquistati prima del testamento, soltanto perché non ancora intavolati”.
Pertanto, la Corte d’Appello ha errato laddove non ha considerato i beni ereditati da Tizia come già facenti parte del testamento di questa al momento di redazione del testamento.
[6] Ordinanza n. 17122 del 28 giugno 2018. Sia la pronuncia delle Sezioni Unite che la successiva Cass. Civ. n. 17868/2019 sono state oggetto di commento nella presente newsletter, rispettivamente in data 11/12/2018 ed in data 17/09/2019
[7] Ci si riferisce a RAMPONI, “La Cassazione torna sui suoi passi? Ancora su institutio ex re certa e successione legittima”, in Newsletter Ec Legal del 17/09/2019.
[8] TRABUCCHI, Nota a Cass., 23 marzo 1963, n. 737, in Giurisprudenza Italiana, 1964, I, 1, pag. 186.
[9] In tal senso, BONILINI, Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, Tomo II, La successione testamentaria, pagg. 246 ss.; si veda altresì TATARANO, Il testamento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2003, pag. 364.
[10] Così Cass. Civ. n. n. 17868/2019
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia