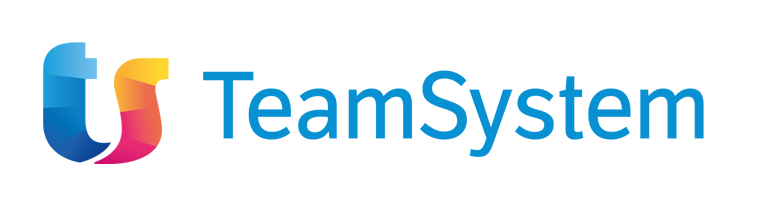Il DDL per l’efficienza del processo civile: commento a prima lettura delle novità in materia di appello
di Fabio Cossignani Scarica in PDF
È approdato al Senato il disegno di legge delega S.2284 (Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile). Si coglie l’occasione per un’analisi a prima lettura dei criteri direttivi in materia di appello.
- La crisi della giustizia civile
Lo stato in cui versa la giustizia civile in Italia è preoccupante e non si scorge ancora una tangibile inversione di tendenza.
Peraltro, il confronto tra la mole degli interventi “riformatori” che si sono succeduti negli ultimi 30 anni e i frutti conseguiti rischia di indurre alla rassegnazione.
Anche nell’odierna legislatura, al pari delle precedenti, si confida di porre rimedio al problema con specifiche e puntuali riforme del codice di rito. In questo senso sembra orientato anche il DDL delega, già approvato dalla Camera, e ora all’esame del Senato (n. 2284).
Il legislatore continua a non comprendere la scarsa importanza rivestita dalle disposizioni processuali.
Il problema, al contrario, affonda le proprie radici nella crisi culturale di operatori e cittadini, nonché in un sistema organizzativo inefficiente e povero di mezzi.
Ciò non significa che la modifica delle disposizioni del codice di procedura non possa essere utile. Sarebbe tuttavia più proficuo ragionare nell’ottica di un complessivo e generale ripensamento del sistema, da compiersi in uno con la riforma (generale) del sistema organizzativo degli uffici.
Viceversa, continue e settoriali modifiche, oltre a non comportare alcun tangibile beneficio, creano notevoli complicazioni sotto il profilo del diritto intertemporale, rendendo ardua finanche l’individuazione della norma concretamente applicabile al caso di specie.
- I criteri direttivi per le modifiche in materia di appello.
L’art. 1, co. 2, lett. b), del DDL reca i criteri direttivi di riforma relativi al giudizio di appello, che verranno di volta in volta riportati testualmente e analizzati.
2.1 Termini per impugnare
“ 1) prevedere che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall’appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall’impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima”.
Nella parte in cui si intende variare il dies a quo per l’impugnazione, legandolo alla comunicazione e non al deposito della sentenza, la previsione può apparire ragionevole, anche se non molto significativa sotto il profilo dell’ “efficienza”.
Le perplessità nascono invece dalla prevista possibilità di riduzione del termine (lungo, se non si va errati) a non oltre 90 giorni dalla comunicazione.
Il legislatore sembra non avvedersi che sono in primis le parti a subire gli effetti negativi della durata dei processi. Se così non fosse, d’altro canto, non vi sarebbe neppure un problema da risolvere.
Ne consegue che comprimere i termini per il compimento di un determinato atto di parte non produce alcun risultato utile, specie là dove la parte onerata abbia già un proprio interesse ad accelerare il compimento di quell’atto.
Da un lato, occorre infatti ricordare che, secondo le norme vigenti, la parte interessata ad abbreviare i termini può notificare la sentenza alla controparte, così facendo scattare il termine breve di 30 giorni per proporre impugnazione (60 in caso di ricorso per cassazione).
Dall’altro lato, di regola è interesse del soccombente (e non della legge) abbreviare i termini di instaurazione del giudizio di impugnazione, allo scopo di ottenere, in tempi rapidi, la sentenza di riforma e, prim’ancora e soprattutto, l’inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Inoltre, il legislatore forse dimentica che, proposto l’appello con citazione ad un’udienza fissata dall’appellante in un termine non inferiore a 90 giorni, è prassi delle corti rinviare tale udienza anche ad anni di distanza (spesso – e impropriamente – ai sensi dell’art. 168 bis, co. 5, c.p.c.), così di fatto rendendo di poca rilevanza pratica la minore o maggiore ampiezza dell’originario termine per impugnare.
2.2 Appello con decisione monocratica
“2) individuare le materie relativamente alle quali l’appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie”.
L’idea di un appello trattato da un giudice monocratico è qualcosa che lascia perplessi, specie se ci si pone nell’ottica di un giudizio che dovrebbe consistere in un percorso di perfezionamento della decisione. Infatti, la decisione collegiale consente il confronto tra le conoscenze e le prospettive dei diversi magistrati. Tale dialogo favorisce una decisione migliore, perché più ponderata rispetto a quella (solitamente) solipsistica del giudice di primo grado.
Nell’ottica del legislatore, sarebbe ragionevole scontare il vantaggio della decisione collegiale nelle cause giuridicamente semplici e nelle cause di modesto valore economico-sociale.
Quanto al criterio selettivo della semplicità – escluse le cause “semplici” di competenza del giudice di pace, non interessate dalla modifica (cfr. art. 350, co. 1, seconda pt., c.p.c.) – appare difficile individuare cause di competenza del tribunale che siano classificabili ex ante, sulla base della materia, come cause di ridotta complessità giuridica.
Del pari, sempre ragionando sulla base della situazione attuale, anche il criterio del valore è opinabile, perché presuppone che vi sia un’apprezzabile categoria di cause di competenza del tribunale che abbiano un contenuto valore economico-sociale. Al di là della soggettività del criterio, escluse la cause per cui è competente per valore il giudice di pace, le cause astrattamente sussumibili in questa categoria non sembrano essere molte.
2.3 Appello con decisione collegiale, ma con trattazione riservata al relatore
“3) Prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall’articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile”.
Nell’appello attuale, la collegialità costituisce la regola. Regola che risulta derogabile solo su iniziativa del presidente del collegio e solo per l’assunzione dei mezzi istruttori, che può essere delegata a uno dei membri del collegio (art. 351, co. 1, c.p.c.).
Il disegno di legge delega sembra voler modificare la struttura della collegialità dell’appello accostandola al modello proprio delle cause di primo grado di competenza del tribunale in composizione collegiale. Viene infatti riservata al relatore l’intera trattazione della causa, mentre al collegio viene attribuita la sola fase decisoria. Peraltro, la delega si premura di riservare al relatore la valutazione sull’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, creando un parallelismo tra l’art. 345, co. 3, c.p.c. e l’art. 183, co. 7, c.p.c. Il provvedimento dovrebbe comunque essere sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice relatore e, ovviamente, dal collegio in sede decisoria.
Non è chiaro se la delega intenda sottrarre alla collegialità anche i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria (art. 351 c.p.c.).
2.4 Cd. filtro in appello: estensione dell’ambito di applicazione e contraddittorio scritto
“4) prevedere che l’inammissibilità dell’appello di cui all’articolo 348-bis del codice di procedura civile si applichi anche quando l’appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l’appello sia inammissibile ai sensi dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Con quest’articolato criterio direttivo il legislatore intende migliorare ed espandere l’applicazione del cd. filtro in appello.
Tali scopi dovrebbero raggiungersi mediante due tipi di intervento:
- i) estendendo l’applicazione del filtro anche all’appello ex 702 quater c.p.c., per il quale, nel contempo, si prevede una restrizione dei nova istruttori sul modello dell’angusto art. 345, co. 3, c.p.c.
- ii) prevedendo un contraddittorio in forma scritta. Si passa dall’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. emessa “sentite le parti” (co. 1) a un procedimento assai più articolato: deposito di una relazione contenente i motivi per cui può essere dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bisp.c. – contraddittorio tra le parti in forma scritta – decisione. Per il caso in cui il relatore non ritenga sussistenti i presupposti per procedere alla declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la delega impone comunque l’emissione di un provvedimento, non motivato, di esclusione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del filtro.
Tali modifiche non sembrano né opportune, né corrette dal punto di vista sistematico.
Innanzitutto, per quanto concerne le modifiche sub i), appare evidente il fatto il legislatore consideri il primo grado del processo “semplificato” (così la nuova nomenclatura della delega) di cognizione e il primo grado nel processo ordinario come giudizi di prima istanza tra loro fungibili. Questa sembra essere infatti la premessa della tendenziale uniformazione (filtro e divieto di nova) che si intende promuovere tra i rispettivi giudizi di appello.
Senza entrare in questa sede nel dibattito sulla natura sommaria o meramente semplificata del procedimento ex art. 702 bis ss. c.p.c., in generale, e del relativo giudizio di primo grado, in particolare, pare comunque troppo semplicistico equiparare un rito regolato da centinaia di articoli di legge a un rito viceversa disciplinato quasi integralmente dal solo comma 3 dell’art. 702 ter c.p.c. Viene il sospetto che sullo sfondo, ben oltre la singola previsione della delega, vi sia l’errata (e pericolosa) convinzione che le forme processuali siano solo un vezzo o, peggio, un ostacolo alla rapida definizione del giudizio. Ma in questa maniera si confonde la forma col formalismo, che peraltro è un’aberrazione che affligge più la cultura del giurista moderno che non la legge processuale in sé considerata.
Al contrario, sarebbe più corretto ritenere che il processo “semplificato” di cognizione, così come è peculiare in primo grado rispetto al rito ordinario, meriti di conservare le proprie specificità anche in appello. E ciò in quanto la fungibilità può forse predicarsi tra i due procedimenti complessivamente considerati, ma non di certo tra i due rispettivi primi gradi di giudizio.
Infatti, il gravame nel rito sommario rappresenta in primo luogo una garanzia offerta alle parti quale contraltare della deformalizzazione del primo grado, deformalizzazione che caratterizza il solo rito semplificato, anche nella nuova versione prospettata dal DDL (v. art. 1, co. 2, lett. a, nn. 4 e 9, che peraltro mirano all’applicazione generalizzata di questo modello procedimentale).
Ne consegue che mal si attaglia all’appello ex art. 702 quater c.p.c. l’idea di un giudizio “chiuso”, latamente cassatorio e fortemente limitato sotto il profilo dello ius novorum.
Quanto invece alle prospettive sub ii), ben venga l’idea di un rafforzamento del contraddittorio. Tuttavia, il problema sembra risiedere più a monte ossia nella opportunità stessa di conservare il cd. filtro in appello.
Infatti, tenuto conto delle notevoli problematiche che il nuovo istituto ha sollevato (in più occasioni sottolineate anche in questa newsletter), sarebbe più ragionevole la sua abrogazione. E d’altro canto, ai fini dell’efficienza del giudizio di appello, sembra già oggi più che sufficiente il modello di “decisione a seguito di discussione orale” ex art. 281 sexies c.p.c., applicabile in secondo grado in forza dell’art. 352, ult. co., c.p.c.
2.5 Limitazione delle questioni pregiudiziali di rito
“5) introdurre criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito”.
Il monito è chiaro. Devono essere contenute le ipotesi in cui una questione di rito possa riverberarsi sulla decisione di merito assunta in primo grado. Lo strumento è la limitazione del potere di eccezione e di rilevazione della questione pregiudiziale in appello.
Le intenzioni sono buone. Vien tuttavia da chiedersi se l’obiettivo non sia già perseguibile, e in larga parte perseguito, in virtù delle attuali norme di legge. Si pensi, in proposito, alla giurisprudenza sul giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883 e successive pronunce).
Il legislatore sembra invece non aver considerato la praticabilità di istituti giuridici che, anziché operare sulla rilevazione ed eccezione del vizio processuale, tendono a sminuirne le conseguenze. Il riferimento è, ad esempio, al regime della declaratoria di incompetenza emessa in sede di impugnazione nel procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 9 bis l.fall.). Lì si prevede espressamente che l’accertamento del vizio processuale (in sede di reclamo) non si riverbera di per sé sulla efficacia della sentenza di fallimento: esso determina esclusivamente la translatio della procedura concorsuale; per quanto riguarda i motivi di impugnazione diversi dalla competenza, l’accoglimento dell’eccezione di rito comporta invece la mera trasmigrazione della loro trattazione dinanzi alla corte di appello competente.