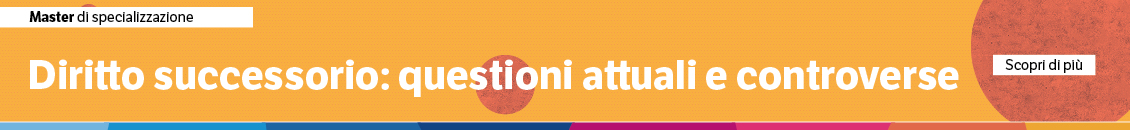Esperibilità dell’azione di riduzione in via surrogatoria: la questione rimessa alle Sezioni Unite
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 23 del 02/01/2025
Successioni Mortis Causa – Successione Necessaria – Reintegrazione Della Quota Di Riserva Dei Legittimari – Azione Di Riduzione – Legittimazione – Eredi e Aventi causa – Creditori personali del legittimario totalmente pretermesso
Occorre rimettere la causa alla Prima Presidente, affinché ne valuti l’opportunità della rimessione alle Sezioni Unite, perché si pronunci sulla questione relativa all’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.
Disposizioni applicate
Articoli 457, 524, 557 e 2900 cod. civ.
[1] Sotto il profilo che qui ci occupa, la sentenza in commento riguarda un’ipotesi di intervento volontario di un terzo creditore (Filano) in un procedimento azionato da due soggetti (Mevio e Sempronio), nominati eredi con un testamento di epoca anteriore ad altro che indicava quale unico erede Caio, asserito debitore del terzo interveniente; quest’ultimo, pertanto, aveva interesse al riconoscimento della validità del testamento posteriore ovvero all’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione per il caso di accertata invalidità del testamento successivo e, dunque, efficacia di quello antecedente, che nominando eredi universali i nipoti comportava la totale pretermissione di Caio (figlio del de cuius).
A prescindere dai profili penali che hanno interessato la vicenda in commento (e che mettevano in dubbio la legittimità stessa dell’intervento del terzo), sia la Corte d’Appello che la Suprema Corte hanno svolto puntuali argomentazioni in diritto sulla esperibilità in via surrogatoria dell’azione di riduzione.
In particolare, la sentenza di secondo grado riteneva, in via preliminare, che Filano non avesse i requisiti per sostituirsi al suo debitore Caio in quanto l’azione surrogatoria, avente carattere necessariamente eccezionale, poteva essere esercitata allorché sussistessero i tre presupposti (i) dell’esistenza di un credito certo, anche se sottoposto a termine o condizione, (ii) dell’inerzia del debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi, e (iii) della sussistenza di un pericolo d’insolvenza, da intendersi nel senso che il contegno omissivo del debitore, o l’inerzia, dovevano essere tali da produrre o aggravare il pericolo dell’insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare le ragioni del creditore. Nel caso di specie, la Corte d’Appello considerava insussistente il presupposto dell’inerzia di Caio nell’esercizio dei suoi diritti e delle azioni a lui spettanti, intesa secondo la giurisprudenza, come trascuratezza.
Specificava, infatti, la Corte d’Appello che Caio, costituendosi nel giudizio di querela di falso in primo grado, aveva chiesto che fossero accolte le domande degli attori, ossia che fosse dichiarata la nullità del testamento olografo del 09/01/2009 di Tizio, e che in caso di dichiarata validità dello stesso, fosse dichiarata la nullità dell’accettazione dell’eredità su esso basata da parte sua e l’autenticità e validità del testamento olografo del 30/05/2008, mentre nel separato giudizio di petizione ereditaria aveva, altresì, esperito l’azione di riduzione per lesione di legittima.
[2] Ed è sulla nozione di trascuratezza, quale presupposto dell’azione surrogatoria dell’art. 2900 cod. civ., che si concentra in prima battuta l’analisi degli Ermellini.
Al riguardo, ricordano come si contrappongano due orientamenti della Suprema Corte.
Un primo orientamento, più tradizionale (al quale ha aderito la sentenza d’appello), che “considera come presupposto dell’azione surrogatoria oltre all’esistenza del credito di chi agisca rispetto al titolare dell’azione ed all’insolvenza del debitore, l’inerzia di quest’ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica”.[1]
Un secondo orientamento, che valorizza il dato letterale dell’art. 2900 cod. civ., che non parla più di inerzia del debitore (come prevedeva il vecchio codice del 1865), ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. “Col termine “trascura” il legislatore ha inteso precisare che a legittimare l’intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell’azione processuale, non è necessaria un’inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto”.[2]
Evidenzia la Suprema Corte come, nel caso di specie, Caio abbia esercitato l’azione di riduzione solo un anno dopo l’esercizio dell’azione surrogatoria del suo creditore, nel separato giudizio di petizione ereditaria promosso dai nipoti sulla base del testamento olografo del 30/05/2008; appare, dunque, decisivo stabilire, ai fini della sussistenza dei presupposti dell’azione surrogatoria, se debba farsi riferimento al primo, o al secondo degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati sulle nozioni di inerzia e di trascuratezza.
[3] Connessa a tale problematica è poi quella del particolare atteggiarsi dell’interesse ad agire nel caso dell’azione surrogatoria.
La giurisprudenza tradizionale, legata alla vecchia nozione di inerzia, e non a quella di trascuratezza dell’attuale art. 2900 cod. civ., ritiene che “qualora il debitore titolare dell’azione non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, venga automaticamente a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. Quest’ultimo non può sindacare le modalità con cui il debitore, al quale solo compete la gestione del suo patrimonio, abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l’azione revocatoria ordinaria ovvero l’opposizione di terzo”.[3]
In tale quadro giurisprudenziale si innestano le osservazioni della sezione giudicante, che ritiene eccessiva questa rigida chiusura, che impedirebbe l’esercizio in via surrogatoria dell’azione anche allorquando l’attivarsi del debitore non sia stato diligente e puntuale, “prestando il fianco ad iniziative strumentali del titolare debitore”.
Suggerisce, la pronuncia in commento, come debba, altresì, tenersi conto di un aspetto determinante: a differenza degli atti che modificano in via diretta ed immediata il patrimonio del debitore, gli atti di esercizio o di non esercizio di un’azione giudiziale costitutiva, come l’azione di riduzione per lesione di legittima, non possono essere resi inefficaci nei loro confronti dai creditori con lo strumento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ.. Tali atti, infatti, “non incidono immediatamente sulla consistenza del patrimonio, potendo modificare tale consistenza solo nel caso in cui intervenga una decisione di accoglimento dell’azione passata in giudicato, con conseguente inutilizzabilità, da parte del creditore che si era surrogato, dell’indicato rimedio dell’azione revocatoria ordinaria (vedi in tal senso Cass. 19.2.2013 n. 4005), ed utilizzabilità del rimedio dell’opposizione di terzo contro la sentenza relativa all’azione tardivamente esercitata dal titolare, solo nell’ipotesi, di ben ardua dimostrazione, in cui la sentenza sia l’effetto di dolo, o collusione a suo danno ex art. 404 comma 2 cod. civ.”.
[4] Il Collegio giudicante evidenzia come sia necessario rimettere alle sezioni unite (pur non sussistendo un reale contrasto sezionale, ma piuttosto rinvenendosi una non applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte da parte dei giudici di merito) la più generale questione dell’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.
Il codice civile, infatti, non ha apprestato specifici strumenti di tutela a favore dei creditori del legittimario pretermesso in materia di azione di riduzione, avendo riconosciuto la legittimazione all’esercizio di tale azione solo a favore dei legittimari, dei loro eredi o aventi causa, senza nulla precisare in ordine ai creditori, menzionati solo al terzo comma dell’art. 557 cod. civ. ma con riguardo ai soli creditori del defunto, i quali non possono esercitare l’azione di riduzione per lesione di legittima, né approfittarne, se il legittimario avente diritto alla riduzione abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, in tal modo evitando la confusione tra il patrimonio del defunto e quello degli eredi.
Gli Ermellini ricordano come parte della dottrina abbia proposto di far rientrare anche i creditori del legittimario nella categoria degli aventi causa dal legittimario; ricostruzione che, però, non ha trovato l’avallo della giurisprudenza.[4]
La via seguita dalla Suprema Corte[5] per giustificare l’esercizio, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso è stata, dunque, individuata nella lettura in negativo dell’art. 557 comma 3 cod. civ.: se, si afferma, “la legittimazione viene espressamente riconosciuta per l’ipotesi in cui l’accettazione è pura e semplice (grazie alla quale i creditori del defunto divengono creditori personali del legittimario a seguito della confusione patrimoniale che viene a determinarsi), non si rinviene la ragione dell’esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica di quelli e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela”.[6]
Tale lettura viene criticata dalla pronuncia in commento, “sia in quanto la disposizione si riferisce solo ai creditori del defunto (…) e non a tutti i creditori ereditari ed in particolare ai creditori del legittimario pretermesso (…); sia in quanto da una disposizione dettata solo in negativo per l’ipotesi dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte del legittimario pretermesso, si pretende di desumere, in positivo, la legittimazione all’esercizio dell’azione di riduzione dei creditori del legittimario pretermesso, che però non rientrano nel numerus clausus dei soggetti che secondo l’art. 557 comma 1 cod. civ. possono esercitare tale azione”.
Il collegio giudicante afferma, poi, che, piuttosto, dovrebbe “ritenersi precluso l’esercizio in via surrogatoria da parte di terzi secondo la previsione dell’ultima parte del primo comma dell’art. 2900 cod. civ., in base alla quale, l’esercizio di detta azione non è consentito quando si tratti di diritti o di azioni che non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Ciò in quanto l’esito vittorioso dell’azione di riduzione per lesione di legittima, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, comporta l’acquisizione da parte del legittimario totalmente pretermesso della qualità di erede”. Ciò, infatti, finirebbe per imporre al legittimario pretermesso un’accettazione dell’eredità, actus legitimus strettamente personale e che viene generalmente considerato come insuscettibile di esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori personali del chiamato all’eredità.
Il quadro giurisprudenziale delineato e la mancanza di un preciso dato normativo di riferimento hanno spinto il Collegio giudicante a stimolare “una riconsiderazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte dello strumento in questione”.
È auspicabile che una tale riconsiderazione intervenga, stante l’oggettivo stato di incertezza che ancora oggi persiste, come già si è avuto modo di evidenziare in altra sede, cui si rimanda per un maggior approfondimento.[7]
[1] In questo senso: Cass. Civ. n. 1996/2016; Cass. Civ. n. 5805/2012; Cass. Civ. n. 7187/1997; Cass. Civ. n. 3665/1988.
[2] In tal senso: Cass. Civ. n. 1867/2000. Si vedano, altresì, Cass. Civ. n. 10744/2009 n. 10744; Cass. Civ. n. 34297/2022; nonché le citate Cass. Civ. n. 7187/1997 e n. 3665/1988.
[3] Così, Cass. Civ. n. 34940/2022; Cass. Civ. n. 58/2012
[4] È la stessa sentenza in commento, tuttavia, a riportare come “sembra avallare, ma incidentalmente, tale tesi, Cass. 20.6.2019 n. 16623, che però si basa essenzialmente sulla lettura in negativo di seguito esaminata dell’art. 557 comma 3 cod. civ. e sulla lettura sistematica degli articoli 557, 2900 e 524 cod. civ.”.
[5] Si veda, da ultimo Cass. Civ. n. 16623/2019.
[6] Così, Cass. Civ. n. 16623/2019 cit.
[7] M. Ramponi, L’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, in Ec Legal del 09/07/2019, https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/pdf/2019-07-09_lesercizio-via-surrogatoria-dellazione-riduzione-parte-dei-creditori-del-legittimario-pretermesso.pdf
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia