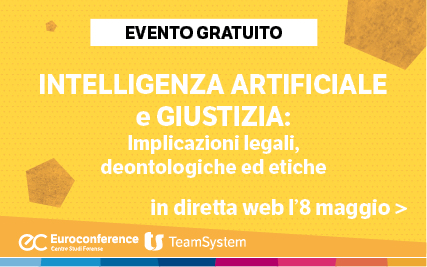Deposito della domanda di concordato in bianco e partecipazione alla gara pubblica: la posizione dell’Adunanza Plenaria
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di FerraraCons. St., A.P., 27 maggio 2021, n. 9 – Pres. Patroni Griffi, Est. Simonetti
Cons. St., A.P., 27 maggio 2021, n. 11 – Pres. Patroni Griffi, Est. Simonetti
Parole chiave: Concordato in bianco – gara pubblica – appalti – esclusione – autorizzazione del tribunale – concordato in continuità aziendale – aggiudicazione.
Massima: “Il deposito di una domanda di concordato in bianco non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche per perdita dei requisiti generali e, pertanto, non preclude la partecipazione alla gara pubblica, ma l’autorizzazione del tribunale fallimentare alla partecipazione alla gara deve intervenire prima dell’aggiudicazione”.
Riferimenti normativi
Art. 161, co. 6 L.F. – art. 186 bis, co. 4 L.F. – art. 14, co. 1 Dir. 2008/98/CE – art. 48, co. 19ter Codice contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) – art. 80 Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) – art. 110 Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) – art. 372 d.lgs. 14/2019
CASO
All’esame dell’Alto Consesso è stato sottoposto il tema delle interferenze tra il concordato preventivo con continuità aziendale, nella specifica accezione del concordato in bianco o con riserva, e la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o della concessione.
La fattispecie che ha dato origine alla A.P. 9/2021 riguarda l’esclusione dalla gara per perdita dei requisiti generali (ex art. 80, co. 5 lett. b Codice dei contratti pubblici) della mandante di un r.t.i. aggiudicatario che aveva presentato domanda di concordato in bianco in corso di gara e ne aveva informato la stazione appaltante solo in un secondo momento (dopo cinque mesi dalla presentazione della domanda di concordato).
Sottesa alla A.P. 11/2021, invece, vi è la questione circa la possibilità di sostituire, con un’impresa estranea, la mandataria di un r.t.i. che partecipi ad una procedura di gara.
SOLUZIONE
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze gemelle, si è espressa in senso favorevole alla possibilità per un’impresa che presenti una domanda di concordato in bianco, preannunciando che chiederà un concordato con continuità aziendale, di partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto o concessione. L’Adunanza Plenaria ha colto l’occasione per chiarire, inoltre, che entro l’aggiudicazione della gara deve intervenire l’autorizzazione del tribunale fallimentare alla partecipazione alla gara pubblica ma non è necessario che entro il medesimo termine vi sia anche l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
QUESTIONI
La questione rimessa all’Alto Consesso riguarda la legittimità della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica da parte di un’impresa che, nel corso della gara, presenti una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco.
Segnatamente, il tema è quello delle interferenze tra il concordato preventivo con continuità aziendale, nell’accezione di concordato in bianco o con riserva, e le vicende dei contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase dell’evidenza pubblica e alla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o della concessione.
Le pronunce si distinguono per interesse perché dopo aver ripercorso l’evoluzione del rapporto tra procedure concorsuali e procedure ad evidenza pubblica, compongono il conflitto interpretativo circa la possibilità per imprese che abbiano presentato domanda per l’ammissione al concordato in bianco di partecipare alle gare pubbliche.
Tradizionalmente, il rapporto tra le procedure concorsuali e le procedure ad evidenza pubblica è stato caratterizzato da antinomia, invero la sottoposizione dell’impresa a fallimento o a procedura similare è sempre stata ritenuta una condizione ostativa o di impedimento alla partecipazione alle gare.
Una prima apertura si è avuta con l’introduzione ad opera del c.d. Decreto sviluppo D.L. 83/3012, del concordato preventivo con continuità aziendale, procedura con finalità “recuperatoria” finalizzata ad assicurare la prosecuzione dell’attività di impresa da parte dell’imprenditore.
Fin dalle origini è stato evidente il forte nesso tra concordato in continuità aziendale e contratti pubblici, ove la continuazione di contratti pubblici già in corso e la partecipazione a procedure di assegnazione di nuovi contratti pubblici erano ritenute funzionali al perseguimento del recupero del valore dell’impresa. Ciò trova conferma nella formulazione dell’art. 186 bis L.F. e nella coordinata modifica dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici del 2006 che ha previsto l’introduzione per il concordato con continuità aziendale di un’esplicita eccezione alla regola dell’esclusione per le imprese in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo.
Coeva è l’introduzione nell’ordinamento italiano del concordato in bianco o con riserva, introdotto all’art 161, co. 6 L.F. che consente all’imprenditore di depositare un ricorso contenente una domanda di concordato avente un contenuto minimo, riservandosi di procrastinare di sessanta o centoventi giorni la presentazione del piano e della proposta di concordato.
Le questioni rimesse al vaglio dell’Adunanza Plenaria possono essere così sintetizzate:
1) se la presentazione di un’istanza di concordato in bianco ex art. 161, co. 6 L.F. da parte dell’impresa mandante di un raggruppamento temporaneo (di seguito r.t.i.) deve ritenersi causa di automatica esclusione dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali ovvero se la presentazione dell’istanza non inibisca la partecipazione alla procedura di affidamento nel caso in cui contenga una domanda prenotativa per la continuità aziendale;
2) se la partecipazione alle gare pubbliche debba ritenersi atto di straordinaria amministrazione e, dunque, possa consentirsi alle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo c.d. in bianco la partecipazione alle gare, soltanto previa autorizzazione giudiziale nei casi urgenti, ovvero se detta autorizzazione debba ritenersi mera condizione integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione;
3) in quale fase della procedura di affidamento l’autorizzazione giudiziale di ammissione alla continuità aziendale debba intervenire onde ritenersi tempestiva ai fini della legittimità della partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione della gara;
4) se le disposizioni normative di cui all’art. 48, commi 17, 18, 19 ter del d.lgs. n. 50/2016 debbano essere interpretate nel senso di consentire la sostituzione della mandante che abbia presentato ricorso di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, cit. con altro operatore economico subentrante anche in fase di gara, ovvero se sia possibile soltanto la mera estromissione della mandante e, in questo caso, se l’esclusione del r.t.i. dalla gara possa essere evitata unicamente qualora la mandataria e le restanti imprese partecipanti al raggruppamento soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione.
Nell’esaminare il primo quesito, l’Adunanza Plenaria ha dato atto del contrasto giurisprudenziale emerso circa l’applicabilità o meno al concordato in bianco della deroga alla causa di esclusione per il concordato in continuità aziendale prevista dagli artt. 80, co.5, lett. b e 110 del Codice dei contratti (si tenga a mente che il contrasto è nato in relazione alla formulazione dell’art. 110 del Codice dei contratti applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. c.d. Sblocca Cantieri).
L’art. 80, co. 5 lett. b del Codice dei contratti esclude dalla partecipazione a gare pubbliche l’operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 del Codice dei Contratti. L’art. 110, invece, sembra ampliare l’accesso alle procedure ad evidenza pubblica anche alle imprese che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato in bianco (tesi che trova conferma nella nuova formulazione dell’art. 110 come modificato dal D.L. c.d. Sblocca Cantieri).
Secondo un primo indirizzo che fa leva sull’effetto prenotativo della domanda di concordato in bianco, in funzione del possibile concordato con continuità aziendale, e sulle finalità anticipatorie e protettive dell’istituto, l’impresa conserva la facoltà di partecipare alle gare pubbliche nel tempo che intercorre tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.[1]
Secondo l’orientamento opposto, invece, l’impresa che abbia presentato domanda di concordato ex art. 161, co. 6 L.F. deve essere esclusa in via automatica dalla procedura di gara.[2] Tra le argomentazioni offerte a sostegno di questa teoria, spiccano l’equiparazione della domanda di concordato in bianco al riconoscimento da parte dell’impresa del venir meno dei propri requisiti di affidabilità, la natura straordinaria dell’atto di partecipazione alla gara che lo renderebbe autorizzabile ex art. 161 co. 6 L.F solo se urgente e il fatto che l’incertezza della fase che si apre dopo la presentazione della domanda di concordato in bianco non rende la procedura comparabile con il concordato con continuità aziendale.
L’Adunanza Plenaria, per risolvere il contrasto, ha ritenuto doveroso approfondire il rapporto tra la legge fallimentare e il codice dei contratti rilevando, in particolare, che è l’evoluzione della disciplina dei contratti pubblici che ha reso complesso il coordinamento tra le due discipline.
La disciplina dei contratti pubblici ha da sempre affrontato il tema della crisi di impresa ponendo l’attenzione sull’affidabilità dell’appaltatore, in ottica di protezione della realizzazione della commessa pubblica. In questo senso, la tutela si è tradotta nell’esclusione obbligatoria ed automatica dell’impresa in crisi. Il legislatore italiano, muovendosi nel margine di scelta lasciato dalle direttive europee in materia di appalti, ha optato per un criterio binario secondo il quale l’esclusione obbligatoria e automatica dell’impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo è la regola, alla quale si affianca un’eccezione nel caso di impresa in concordato con continuità aziendale.
L’esclusione è estesa anche alle imprese nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, ciò ha indotto gli interpreti a ritenere che l’eccezione potesse essere applicata solo alle imprese già ammesse al concordato con continuità. Quest’interpretazione ha trovato ulteriore conferma nell’art. 110 del Codice dei contratti (applicabile ratione temporis).
Secondo un’interpretazione letterale delle norme applicabili ratione temporis, la partecipazione a nuove gare sarebbe preclusa sia all’impresa che abbia presentato domanda di concordato in bianco che all’impresa che abbia presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 e non sia ancora stata ammessa alla procedura.
Tuttavia, un simile assunto sarebbe in contrasto con la lettura dell’art. 181 bis, co. 4 L.F. che prevede che tra il deposito della domanda e il decreto di apertura della procedura, l’impresa possa partecipare alle gare pubbliche se autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ‘se già nominato’. Più interpreti hanno inoltre evidenziato che proprio questa formulazione ipotetica dimostrerebbe che l’art. 186 bis, co. 4 L.F. contempla l’ipotesi del concordato in bianco o con riserva (dal momento che, com’è noto, nel concordato preventivo ordinario la nomina del commissario giudiziale è doverosa).
A queste premesse ricostruttive, l’Adunanza Plenaria affianca ulteriori considerazioni circa l’inquadramento della domanda con riserva, da parte della giurisprudenza della Suprema Corte. Secondo la Corte di Cassazione, il procedimento innescato dalla domanda con riserva, c.d. preconcordato, non sarebbe un procedimento distinto e antecedente rispetto a quello ordinario che si apre con la proposta, ma bensì un segmento di un procedimento unico, articolato in due fasi.[3]
Così esposti i rilievi sul punto, l’Adunanza ritiene che la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non possa considerarsi causa di automatica esclusione né inibisca la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici. La presentazione della domanda non comporta l’automatica perdita dei requisiti generali di partecipazione.[4] Tale interpretazione si applica sia alle imprese che abbiano assunto la qualità di debitore concordatario prima di presentare la domanda di partecipazione alla gara, che alle imprese che presentino la domanda di concordato successivamente rispetto alla partecipazione ad una gara. In entrambi i casi, la partecipazione alle procedure di gara deve essere sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, che funge da punto di equilibrio tra la tutela del debitore e la tutela dei terzi.
Nel caso in cui la domanda di concordato sia successiva alla partecipazione alla gara, l’impresa è tenuta a presentare senza indugio al giudice l’istanza di autorizzazione a partecipare alla gara.[5]
Con riferimento al secondo quesito, l’Adunanza Plenaria ha osservato che, ai sensi dell’art. 186 bis, co. 4 L.F., nel caso in cui sia presentata una domanda di concordato, la partecipazione ad una gara è un atto da sottoporre sempre al controllo giudiziale. In ragione della particolare importanza che riveste l’autorizzazione del giudice, la Plenaria ha ritenuto che il rilascio e il deposito dell’autorizzazione debbano intervenire prima che il procedimento di evidenza pubblica sia terminato, pertanto prima dell’atto di aggiudicazione.
Rispondendo al terzo quesito, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che le stazioni appaltanti hanno facoltà di valutare caso per caso se un’autorizzazione tardiva, ma sopraggiunta in tempo utile per la stipula del contratto di appalto o concessione, abbia efficacia integrativa o sanante.
Da ultimo, per rispondere al quarto quesito l’Adunanza Plenaria ha esaminato i commi 17 e seguenti dell’art 48 del Codice dei contratti rilevando che essi, in deroga alla regola generale dell’immodificabilità della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all’assetto risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, prevedono la possibilità di modificare la composizione del raggruppamento. Questa possibilità è concessa nel caso in cui la mandante o la mandataria sia sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza o crisi di impresa o nei casi previsti dalla normativa antimafia.
Il comma 19 dell’art. 48 del Codice dei contratti prevede, inoltre, la possibilità di modifiche soggettive in caso di esigenze organizzative del raggruppamento tali per cui nella fase dell’esecuzione del rapporto possono giustificare la riduzione del raggruppamento a condizione che le imprese restanti abbiano i requisiti sufficienti e che la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Infine, il comma 19 ter dell’art. 48 del Codice dei Contratti (introdotto con d.lgs. 56/2017) ha espressamente esteso le possibilità di modifica soggettiva del raggruppamento previste dai commi precedenti, alle ipotesi di gara già in corso.
Il quesito rivolto alla Plenaria riguarda la possibilità di modificare la compagine del raggruppamento in corso di gara mediante sostituzione della mandataria o della mandante con un soggetto esterno al raggruppamento.
Il Collegio ha ribadito che la regola dell’immodificabilità è posta a tutela della stazione appaltante, dal momento che evita che possa essere selezionato come aggiudicatario un soggetto del quale non sia stato possibile verificare i requisiti, e della par condicio dei partecipanti.
Secondo l’interpretazione tradizionale, è da escludersi la possibilità di modifiche tramite addizione di soggetti esterni al raggruppamento.[6] L’Adunanza Plenaria, dopo aver esaminato le possibili interpretazioni delle norme in combinato disposto e la normativa europea, ha concluso in senso conforme all’interpretazione tradizionale escludendo la sostituzione esterna della mandante e della mandataria.
Così analizzate le questioni di diritto, il Supremo Consesso ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, co. 6, L.F. non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, co. 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;
b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, co. 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del Codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;
c) l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale;
d) l’art. 48, co. 17, 18 e 19-ter d. lgs. 50/2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva a norma dell’art. 161, co. 6 L.F., e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l’aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l’evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara.
Le pronunce oggetto di esame affrontano un tema di estrema attualità se si considera l’attuale e diffusa crisi economica e finanziaria in cui versa il nostro Paese e gli ingenti piani di investimento in lavori pubblici ed infrastrutture presentati nell’ambito del Recovery Plan per la ripresa dell’economia.
L’interpretazione offerta dall’Adunanza Plenaria, favorevole all’apertura al mercato per le imprese che versino in condizioni di crisi economica è avallata dalla progressiva riduzione delle distonie tra legge fallimentare e codice dei contratti pubblici che culmina nell’impostazione adottata dal nuovo Codice della crisi di impresa.[7] L’attuale formulazione dell’art. 80 co. 5 lett. b del Codice dei contratti richiama espressamente l’art. 186 bis L.F., mentre l’art. 110 del Codice dei contratti è stato modificato dal nuovo Codice della crisi d’impresa che ha disposto che alle imprese che hanno depositato domanda di concordato con riserva si applichi l’art. 186 bis L.F. e che per la partecipazione alle gare, tra la domanda e il decreto di ammissione, sia necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (art. 95 Codice della crisi). Questa misura si spiega nel generale intento di rafforzare gli strumenti finalizzati a tutelare l’asset di impresa.
In senso conforme, la relazione illustrativa del nuovo Codice della crisi di impresa nel ribadire che la domanda con riserva non impedisce la partecipazione a procedure di affidamento, chiarisce che l’intento è di evitare che la domanda si tramuti da strumento di tutela dell’imprenditore ad ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
[1] Si vedano in tal senso Cons. St., sez. V n. 1328/2020, sez. III n. 1772/2018, sez. VI n. 426/2016, sez. III n. 5519/2015, sez. V n. 6272/2013, sez. IV n. 3344/2014.
[2] Si vedano Cons. St., VI n. 3984/2019, sez. III n. 5966/2018.
[3] Si vedano, tra le altre, Cass. sez. I, n. 14713/2019; Cass. sez. I, n. 7117/2020.
[4] Tra le argomentazioni ricordate dall’Adunanza Plenaria a sostegno del proprio orientamento si evidenziano il dato letterale dell’art. 181 bis L.F. e la funzione prenotativa e protettiva del concordato con riserva.
[5] L’omessa o tardiva informazione della stazione appaltante può eventualmente essere valutata come condotta reticente ex art. 80, co. 5, lett. c-bis L.F. Si veda in tal senso anche l’Adunanza Plenaria 16/2020.
[6] Tesi già sposata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 8 del 2012. Il Collegio aveva ritenuto che possibile la modifica soggettiva della compagine del raggruppamento ma solo nel caso di modifica “in riduzione” e non “in aggiunta”.
[7] Si veda anche C. Cost. 85/2020.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia