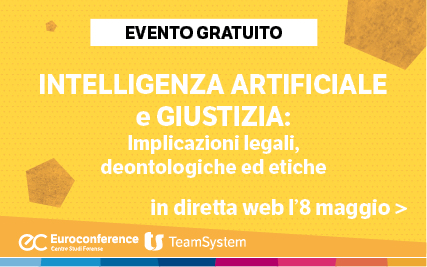Il concorso tra la presunzione di responsabilità per danno da animali e quella da circolazione di veicoli
di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. III, Ord., 07.01.2025, n. 197 – Dott. R. Rossi
Circolazione stradale – Responsabilità civile – Responsabilità per danno cagionato da animali selvatici (art. 2052 c.c.) – Responsabilità del conducente (art. 2054 c.c.)
Massima: “La presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. si confronta con la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c.: se uno dei soggetti oltrepassa la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro, altrimenti entrambi vanno esenti da responsabilità o ne rispondono in pari misura”.
CASO
Tizio conveniva in giudizio la Regione Alfa per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo avvenuto lungo una strada provinciale.
All’esito del giudizio di primo grado, il giudice, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al risarcimento dei danni, ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2043 c.c.
La pronuncia veniva integralmente riformata in appello, con la reiezione dell’originaria domanda attorea.
Tizio ricorre dunque in Cassazione, affidandosi a due motivi.
SOLUZIONE
La Suprema accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando al giudice dell’appello per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, Tizio censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità nell’art. 2052 c.c. dell’ipotesi di sinistro stradale cagionato dalla presenza di fauna selvatica. Il ricorrente denuncia cioè, innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera del giudice di prime cure quanto da parte del giudice dell’appello, della vicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex 2052 c.c., stante le funzioni normative, amministrative e di controllo sugli animali selvatici devolute alla Regione. Tizio lamenta poi anche la non applicazione dei principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità in tema di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica, sostenendo di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistro e la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamento di un animale selvatico, non richiedendosi, al fine di affermare la responsabilità dell’ente regionale, l’allegazione (né la prova) di alcun elemento soggettivo, cioè di una colpa dell’ente convenuto.
Con il secondo motivo, Tizio lamenta che non sia stata ritenuta raggiunta la prova della responsabilità della Regione ex art. 2043 c.c., ravvisabile invece nell’omessa installazione di segnali di pericolo in una strada che – come dimostrato dalle testimonianze assunte – era teatro abituale di sinistri causati dall’attraversamento di animali selvatici.
La S.C. puntualizza anzitutto che la sentenza gravata non brilla certo per coerenza argomentativa, perché, dopo aver affermato che l’attore solo in sede di memorie conclusive inferiva della possibile sussistenza della responsabilità ex art. 2052 c.c. e che quindi il titolo di responsabilità andava ricondotto secondo domanda a quello di cui all’art. 2043 c.c., aveva comunque valutato la domanda di risarcimento dei danni anche ove sussunta nella fattispecie prevista dall’art. 2052 c.c., rigettando la domanda pure sotto tale profilo, sia pure per assenza di colpa della Regione.
Ciò posto, la S.C. ribadisce alcuni principi di diritto, ormai ricorrenti nella giurisprudenza di legittimità.
Anzitutto, precisa che l’individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell’esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (principio già enunciato da Cass. 10/11/2023, n. 31330, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c.; conf. Cass. 08/05/2023, n. 12159).
Per la Corte, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono quindi risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale (la responsabilità trova fondamento cioè nell’uso dell’animale anche solo potenziale, al fine di trarne una qualche utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale, secondo il principio del cuius comoda et incommoda; cfr. Cass. 98/12307) e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così pure Cass. 20/04/2020, n. 7969, Cass. 29/04/2020, nn. 8384-8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550).
Ai sensi dell’art. 2052 c.c. “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. La responsabilità per fatto degli animali è una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva: non è dunque necessario provare la colpa del padrone o dell’utente, i quali rispondono anche se incapaci e per il solo fatto che il danno sia avvenuto a causa dell’animale (in presenza quindi di un nesso causale tra fatto dell’animale e danno), indipendentemente dalla condotta dei primi (Cfr. Cass. 70/1356). La norma in esame prevede in capo al proprietario/utente una presunzione di colpa iuris et de iure a vincere la quale non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale ma occorre la prova del caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra fatto dell’animale e danno.
La S.C. chiarisce poi che, ai fini della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., è necessario che il danneggiato provi che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno. Non è cioè sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c., co. 1 – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità tale per cui non sarebbe stato possibile evitare l’impatto, nonostante ogni cautela; di modo che il contegno dell’animale possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (cfr. Cass. 23/11107).
Rileva ancora la Corte che in tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (in tal senso, da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione).
Ciò premesso, per la S.C. appaiono dunque evidenti gli errori commessi dal giudice territoriale, nella parte in cui ha escluso l’esaminabilità (pur comunque in concreto poi operata) della domanda risarcitoria sulla base dell’art. art. 2052 c.c. e laddove ha individuato il titolo di responsabilità ascrivibile alla Regione nell’inosservanza del generale canone del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.
Ma la gravata sentenza non è conforme a diritto nemmeno nella parte in cui ha negato la responsabilità della Regione riguardata nell’ottica del criterio contemplato dall’art. 2052 c.c. Ed invero, il giudice territoriale, muovendo dall’apodittico assunto della completa omissione della descrizione della dinamica del sinistro, manifestamente contraddetto dallo stralcio dell’atto introduttivo nella sentenza trascritto, ha centrato la propria attenzione sulla condotta serbata dal conducente del veicolo danneggiato, in sostanza indagando (in specie, sulla scorta della presunta velocità di marcia al momento dell’impatto) sulla colpa dello stesso nella produzione dell’occorso. Ma così ragionando, la sentenza gravata ha inopinatamente gravato il soggetto danneggiato dell’onere di provare la diligenza del conducente il sinistro per conseguire il risarcimento, quando invece il giudice territoriale avrebbe dovuto verificare i presupposti di operatività della responsabilità ex art. 2052 c.c.
Questi, in primo luogo avrebbe dovuto quindi riscontrare, sulla scorta dell’andamento del sinistro acclarato in base agli elementi istruttori acquisiti, pur sempre univoci nella prospettazione di un impatto tra l’animale e il veicolo, l’esistenza di un nesso di derivazione causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo in rapporto a quella di guida del conducente del veicolo e soltanto dopo (ed in caso di esito positivo) accertare, ai fini dell’operare della concorrente presunzione sancita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., se il conducente del veicolo danneggiato avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per questi motivi, la S.C. accoglie il ricorso e rinvia al giudice dell’appello per la decisione della causa, alla luce dei principi sopra richiamati.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia