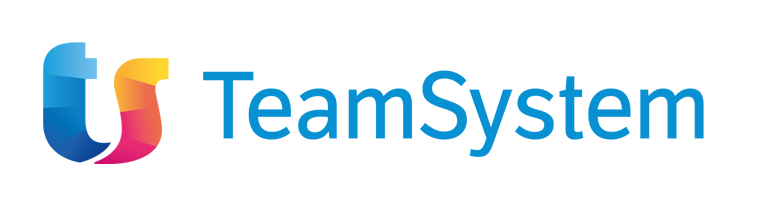Comunione e proprietà esclusiva: ancora sul caso dell’azione di rivendicazione di aree utilizzate (di fatto) come parti condominiali
di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione – seconda sezione civile – ordinanza n. 21481 del 19 agosto 2019
Comunione e condominio – parti di proprietà esclusiva e parti comuni dell’edificio – qualificazione giuridica della domanda: azione di rivendicazione del proprietario – prova del diritto di proprietà – irrilevanza dell’utilizzo dell’area da parte del condominio – irrilevanza della D.I.A. in relazione alla prova del dato dominicale.
Riferimenti normativi: art. 948 c.c. – art. 1117 c.c. – art. 2697 c.c. – art. 1146 c.c.
“… Esso non coglie la ratio decidendi in quanto il giudice d’appello, qualificata la domanda come azione di rivendica, ha fondato la sua decisione sul “titolo versato in atti” e non sull’utilizzo dell’area da parte del condominio.
Ne consegue che la censura avrebbe dovuto investire l’atto di acquisto della proprietà da parte degli attori e non la DIA, che non ha rilevanza ai fini della prova della proprietà del bene …”
1) Il caso all’esame della Corte
La sentenza in commento torna ancora una volta sul tema della contrapposizione tra l’azione di rivendicazione della proprietà esclusiva di un’area, promossa dal proprietario/condòmino, e l’utilizzo (di fatto) della medesima, da parte di alcuni condomìni.
Con stile lapidario e con motivazione decisamente tranchant, la Corte liquida la questione, avendo i condomìni, ricorrenti in terzo grado, travisato la ratio decidendi del secondo Giudice. Ciò, tuttavia, non pregiudica l’opportunità di riprendere un tema lungamente dibattuto e ricco di implicazioni di natura sia sostanziale che processuale.
In breve, la vicenda è la seguente: alcuni condòmini adivano il Tribunale di Alessandria, assumendo di essere proprietari esclusivi di un’area che era stata destinata a box ma che, in realtà, veniva occupata da griglie di aerazione e da tubazioni condominiali, di cui chiedevano la rimozione.
La domanda, che in primo grado veniva rigettata, era invece accolta dalla Corte d’Appello di Torino, la quale qualificava come rivendica l’azione promossa dai proprietari e riteneva che essi avessero assolto all’onere della prova mediante allegazione del titolo di proprietà (non meglio specificato); al contrario, riteneva irrilevante, ai fini della prova della proprietà in comunione, l’utilizzo dell’area da parte dei condomìni (opportunamente osservando che i proprietari appellanti non avevano sottoscritto la D.I.A., presentata dai condomìni per il cambio di destinazione d’uso dell’area).
Ebbene, anche la Suprema Corte, investita della decisione da parte dei condomìni soccombenti in secondo grado, conferma gli anzidetti principi resi nella sentenza d’appello, sia pure in forma meramente enunciativa, posta l’errata prospettazione del motivo di impugnazione (invero i ricorrenti, anziché censurare la qualificazione giuridica della domanda siccome “petitoria” – investendo pertanto l’atto di acquisto della proprietà -, avevano erroneamente ritenuto che la decisione del secondo Giudice fosse piuttosto fondata sulla D.I.A., profondendosi inutilmente in censure circa la tardiva produzione in primo grado).
2) Termini della questione: profili di diritto sostanziale sull’onere della prova nell’azione di rivendicazione in materia condominiale. La posizione della giurisprudenza di legittimità.
La sentenza in commento, con la sua “brevità tacitiana” sul tema dell’azione di rivendicazione promossa da parte dei proprietari/condòmini, non offre, di per sé, molti spunti diretti di riflessione.
In effetti, qualificata l’azione degli attori proprietari come rivendicatoria “pura” (costoro “assumendo di essere proprietari di un’area”, chiedevano la rimozione della situazione lesiva del proprio diritto dominicale e, per l’effetto, la restituzione del pieno utilizzo del bene, vale a dire delle aree di proprietà esclusiva destinate a boxes), la seconda sezione si è limitata a statuire che, a ragione, “… il giudice d’appello (…) ha fondato la sua decisione sul “titolo versato in atti” e non sull’utilizzo da parte del condominio …”.
A prescindere dalle specifiche del caso e dall’errore marchiano nella proposizione del primo motivo di ricorso (forse primaria ragione di una siffatta sbrigativa pronuncia), la Corte avrebbe potuto, comunque, puntualizzare un principio granitico, ovverosia che la prova del diritto di proprietà, qualora la domanda sia “petitoria” in senso stretto (rectius: restitutoria), dev’essere articolata con il massimo rigore (c.d. probatio diabolica), non essendo sufficiente la semplice allegazione del titolo del “proprio” acquisto, da parte dell’attore proprietario[1].
Tale principio, del resto, trova il proprio incontrovertibile fondamento nell’art. 2697, co. 1, c.c., laddove viene enunciato che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ecco quindi che la domanda intesa ad ottenere, oltreché l’accertamento della proprietà di un dato bene, anche la restituzione, la riconsegna o qualunque azione idonea a mettere il proprietario nella condizione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo il bene, implica la prova c.d. “diabolica” in capo al richiedente, il quale non solo deve provare il proprio valido titolo di acquisto ma, qualora non si tratti di acquisto a titolo originario, deve altresì provare di avere ricevuto il bene da chi, a sua volta, era proprietario, e così via fino ad arrivare al primo acquisto a titolo originario. Salva la prova del proprio possesso ad usucapionem, unito eventualmente a quello dei precedenti danti causa (unione dei possessi).
Al contrario, nella diversa ipotesi in cui il bene non debba essere recuperato – in quanto già nella disponibilità di fatto del richiedente tutela – ma, più semplicemente, l’azione miri all’accertamento (sic et simpliciter) della proprietà, al fine di eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sul bene stesso, la giurisprudenza maggioritaria ha sempre ritenuto che l’onere della prova sia integrato mediante la semplice dimostrazione del titolo d’acquisto del bene, da parte dell’attore proprietario[2].
Tale impostazione, tuttavia, è forse destinata a recedere in seguito alla sentenza 18 gennaio 2017 n. 1210, emessa dalla seconda sezione della Suprema Corte (confermata anche da Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 6 maggio 2019 n. 11767).
In essa, infatti, si legge che non deve essere ammessa “… alcuna elusione dall’onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un’azione, quale appare quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione …”.
Peraltro, detta più rigorosa impostazione in materia di onere della prova del diritto dominicale parrebbe trovare adeguato (sia pure incidentale) supporto nella nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 28 marzo 2014 n. 7305[3]: benché chiamata a far luce sul contiguo tema, di carattere sostanziale, della natura giuridica di azione di rivendicazione o di azione personale di restituzione della domanda promossa nei confronti di chi non vanta alcun titolo a giustificazione della disponibilità materiale del bene conteso, le Sezioni Unite, nel qualificare detta domanda come “tipicamente di rivendicazione”, hanno argomentato, in via generale, circa il fatto che ogniqualvolta sia in gioco il diritto di proprietà, tutelato erga omnes, “… occorre che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
L’operazione ermeneutica, operata dalla seconda sezione con la sentenza n. 1210/2017, tradisce, a parere di chi scrive, una certa “forzatura”, posto che impone di trattare in modo identico (onere della piena prova della proprietà) due situazioni diverse: da un lato, quella di colui che si limita a chiedere la mera eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sul bene, di cui detiene comunque il possesso, dall’altro, quella di colui che deve ottenere la restituzione di un bene, da parte del detentore sine titulo (in questo secondo caso, la domanda è tipicamente di rivendicazione, perché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes – che non esiste -ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre dare piena dimostrazione[4]).
Indubbiamente, tuttavia, l’interpretazione effettuata dalla seconda sezione con la sentenza del 2017 ha contribuito a rafforzare – con il conforto delle Sezioni Unite – quell’orientamento, sia pure minoritario, che già in precedenza aveva affermato la non attenuazione dell’onere della prova del dato dominicale, anche nel caso di domanda di mero accertamento, azionata da parte dell’attore, proprietario e possessore al contempo[5].
Per concludere sul punto, vale la pena di rammentare, sempre in tema di onere della prova in materia di rivendicazione, la fattispecie oggetto della sentenza Corte di Cassazione, II sezione, 27.05.2015 n. 10996, in cui – a differenza dei casi analizzati finora – ricorre l’ipotesi, nell’ambito di una domanda di rivendicazione, in cui il convenuto “… riconosca che il bene era di proprietà del dante causa del rivendicante oppure non contesti la proprietà del rivendicante sul fondo”.
Ebbene, in tali casi l’onere probatorio in capo a chi promuove l’azione di rivendicazione – con tanto di domanda di restituzione del bene – è attenuato: più precisamente, non solo non occorre fornire la prova diabolica del diritto dominicale ma sono anche escluse tutte le ulteriori prove che la Corte territoriale aveva (erroneamente) posto a carico dell’attore in rivendicazione (esistenza del bene, possesso di esso da parte del convenuto, illegittimità di detto possesso)[6].
2.1) Irrilevanza della D.I.A. in relazione alla prova del diritto dominicale.
Come già detto, la sentenza in commento statuisce anche in merito agli effetti della denuncia d’inizio attività, rispetto al bene di cui viene vantata la (com)proprietà.
Detto argomento, verosimilmente introdotto dagli attori proprietari al solo fine di corroborare la tesi difensiva della rei vindicatio dell’area (tant’è che, come veniva sottolineato dalla Corte territoriale, la D.I.A. non era stata approvata proprio perché non sottoscritta dai medesimi “futuri attori”, contrari proprio al cambio di destinazione d’uso dell’area in questione), è stato erroneamente ritenuto dai condomìni convenuti – in seguito ricorrenti in Cassazione – quale presupposto fondante la decisione di secondo grado, in merito alla titolarità del bene, utilizzato di fatto in comunione da parte del condominio (si legge infatti nel primo motivo di ricorso che “… la Corte avrebbe fondato la propria decisione sulla DIA …”).
In realtà, la Suprema Corte, prendendo le distanze da siffatta interpretazione, ha affermato che “… la DIA … non ha rilevanza ai fini della prova della proprietà del bene”, rilevando solo sull’utilizzo del bene, e che “… la censura avrebbe dovuto investire l’atto di acquisto della proprietà da parte degli attori …”.
Senza alcuna pretesa di trattazione, in questa sede, di un tema a dir poco spinoso, posta la natura giuridica della D.I.A. quale atto privato, volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge (sia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 29 luglio 2011 n. 15, sia la quasi contestuale Legge 14 settembre 2011 n. 148, all’art. 6, co. 1, lett. c, hanno abbandonato la tradizionale qualificazione giuridica di provvedimento amministrativo a formazione tacita), resta il fatto che si tratta di una mera autodichiarazione, priva di “sacralità” della forma, passibile di esercizio di potere inibitorio da parte della pubblica amministrazione e di azione impugnatoria (di annullamento), ad istanza del terzo controinteressato. In buona sostanza, un mero titolo abilitativo, inidoneo in quanto tale a provare il titolo di proprietà.
3) Profili di diritto processuale. Effetti delle difese petitorie del convenuto sulla domanda personale (contrattuale) di restituzione: onere della prova e aspetti relativi al principio del contraddittorio.
Se finora si sono analizzate le implicazioni, in fatto di onere della prova, connesse alla domanda di rivendicazione (e di mero accertamento), pare congruente ricordare che la già richiamata Cassazione a Sezioni Unite n. 7305/2014 ha escluso l’eventuale trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall’attore come personale (contrattuale), in ragione delle difese petitorie spiegate dal convenuto.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il convenuto promuova, in via riconvenzionale, un’azione di carattere reale, l’onere della piena prova (c.d. probatio diabolica) viene posta a carico del convenuto stesso, non verificandosi una trasformazione in reale dell’azione personale/contrattuale (di restituzione o di rilascio), promossa dall’attore.
La decisione appare giusta e conforme ad uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, qual è l’art. 2697 c.c. ma … per nulla scontata, posto che non mancano decisioni di segno contrario, che cioè addossano all’attore un onere probatorio esorbitante rispetto alla propria domanda[7].
Interessante corollario del richiamato principio giurisprudenziale è quello espresso da Cassazione civile, II sezione, Ord. 09.10.2018 n. 24889, secondo cui, in caso di azione reale in via riconvenzionale da parte del condòmino, convenuto dall’amministratore del condominio per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato sine titulo, il contraddittorio va esteso a tutti i condòmini, dal momento che la riconvenzionale è destinata ad incidere sui diritti dei singoli.
Diversamente, nel caso di azione, da parte di un condòmino, per l’accertamento della natura condominiale di un bene, qualora il convenuto si limiti ad eccepire la proprietà esclusiva sul medesimo – senza svolgere domanda riconvenzionale -, non occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condòmini, posto che la decisione non sarebbe comunque destinata ad incidere sulla comproprietà degli altri soggetti[8].
[1] Ex multis: Cass. civ., sez. VI, Ord. 10.09.2018 n. 21940; Cass. civ., sez. II, Sent. 04.12.2014. n. 25643.
[2] Corte Cass., sez. II, 14.04.2005 n. 7777; Corte Cass., sez. II, 09.06.2000 n. 7894; Corte Cass., sez. II, 04.12.1997 n. 12300.
[3] Prima di tale pronuncia, si vedano, conformi, Cass. civ., sez. VI, Ord. 17.01.2011 n. 884; Cass. civ., sez. II, Sent. 26.02.2007 n. 4416; contra: Cass. civ., sez. III, 19.05.2006 n. 11774.
[4] Cass. civ., sez. II, Ord. 10.10.2018 n. 25052.
[5] Corte Cass., sez. II, 22.01.2000 n. 696.
[6] Saverio Luppino, “Locazioni immobiliari: redazione e impugnazione del contratto”, Santarcangelo di Romagna, 2015, pag. 203 e ss.
[7] Cass. Civ., sez. III, 11774/2006, cit.; sul punto, si legga anche Cass. civ., S.U. 28.03.2014 n. 7305, NOTA di Maria Cristina Vanz, Azione personale di restituzione e difese petitorie del convenuto”, in Riv. Dir. Proc., 2015, 2, 575.
[8] Cass. civ., Sez. Unite, 13.11.2013 n. 25454.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia