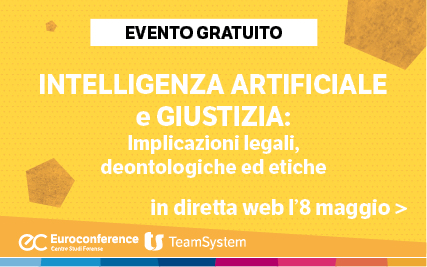Il COMI del debitore ed il trasferimento all’estero della sede sociale
di Federica Pasquariello, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass. civ. Sez. I, Sent. 30 ottobre 2018, n. 27686. Pres. Didone- Est. Vella
Parole chiave: Dichiarazione di fallimento- Giurisdizione fallimentare – COMI- Trasferimento sede sociale
Massima: E’ valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità l’accertamento, ad opera del giudice di merito, di indici probatori idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, che comporta che la competenza giurisdizionale ad aprire la procedura di insolvenza spetti al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (cd. COMI), da individuare fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo della sede statutaria.
Riferimenti normativi: artt. 26 CCI; Reg UE 848/2015; art. 9 l. fall.; Reg. CE 1346/2000
Caso Una società italiana aveva operato il trasferimento in Spagna della sede sociale, con cancellazione della società dal R.I. per trasferimento all’estero nel novembre 2012. Nel settembre 2013 era depositata in Italia istanza di dichiarazione di fallimento. La Corte d’appello di Venezia aveva respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla società dichiarata fallita e aveva ritenuto che il trasferimento all’estero della società si fosse completato meno di un anno prima del fallimento; ha altresì rigettato le censure in punto di asserita inesistenza della società e della nullità della notifica alla stessa effettuata, anche argomentando il carattere fittizio del trasferimento.
Soluzione
La questione riguarda la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi della normativa Unionistica ( Reg. Ce 1346/2000) e interna (art. 9, l. fall.) vigenti all’epoca dei fatti, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società che aveva operato il trasferimento all’estero della sede sociale. Nel merito era stata ritenuta la persistente giurisdizione italiana in quanto l’insolvenza si era manifestata in epoca precedente al trasferimento, e d’altronde il trasferimento risultava fittizio, giacché la società non era stata in grado di comprovare né di allegare la effettuazione di alcuna operazione commerciale nello Stato dove si era trasferita. La Suprema Corte ha ritenuto che si tratti di valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Questioni applicate nella pratica
La pronuncia in esame offre l’occasione di considerare le dinamiche del trasferimento all’estero della sede sociale, sulle quali nell’ultimo decennio è dato registrare una crescente attenzione ed una importante intensificazione dei precedenti giurisprudenziali, anche di legittimità, che dipendono dalla frequenza di queste operazioni in epoca di economie globalizzate. Sullo sfondo, il dibattito sui margini virtuosi di una competizione di ordinamenti ingaggiata dal forum shopping , a fronte del rischio di comportamenti opportunistici; in particolare, nel caso in esame, la questione è quella delle opportunità e delle insidie di un “mercato della insolvenza”, nella misura in cui simili trasferimenti interessino società insolventi – tanto da porre poi il problema di individuare la giurisdizione per l’apertura di una procedura di insolvenza – (Benedettelli, “Centro degli interessi principali” del debitore e forum shopping, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2004, 511 ).
Le complesse implicazioni delle cd. “trasformazioni internazionali” impongono di tenere distinti tra trasferimenti verso un Paese di area UE da quelli verso un Paese extra-UE: in quest’ultimo caso, ai fini della individuazione del Foro fallimentare vale l’art. 9 l. fall. tuttora in vigore, che si riferisce alla sede “principale”, cioè “reale” o “effettiva”; nella prospettiva del Codice della Crisi, in punto di giurisdizione va richiamato l’art. 26, ove si afferma che l’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza in Italia, se qui ha una dipendenza. Il trasferimento all’estero non esclude la giurisdizione italiana “se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore”. Sul piano internazionale, occorrerà dirimere un possibile conflitto di leggi caso per caso, in applicazione dell’art. 25, L 218/1995 (cfr. Ballarino, Le società estere, in Tratt. Dir. Priv. dir. da Rescigno, 17, Torino, 2010, 287): per potere garantire la persistenza dell’assoggettamento dell’ente, ancorché trasferito, alla legge italiana va invocato il principio dell’incorporazione quale criterio di conflitto (Angelici, Le società nel nuovo diritto internazionale privato, in La riforma del sistema di diritto internazionale privato e processuale, Milano, 1996, 113; Benedettelli, Comm.art 25, l. 218/1995, in ‘ NLCC, 1996, 1108). Ove lo Stato estero adotti il c.d. criterio “della sede effettiva”, non riconoscendo la società come munita di idonea soggettività giuridica acquisita in Italia, andrà avviato il procedimento di liquidazione, con ricostituzione secondo le norme del luogo di nuovo insediamento.
Se invece la delocalizzazione della sede porta allo stabilimento un Paese-UE, gioca un ruolo determinante il principio di libertà di stabilimento ( art. 49 TFUE), nonché l’effetto prodotto dal processo di armonizzazione degli ordinamenti societari nazionali, e cosi risulterà salva la continuità dei rapporti giuridici e la sopravvivenza dell’ente, andando escluso che possa essere imposto l’effetto estintivo di una cancellazione, con successiva ricostituzione ex novo della società (v. Mucciarelli, Società di capitali, trasferimento all’estero della sede sociale e arbitraggi normativi, Milano, 2010). Dunque, la mobilità transfrontaliera in area UE comporta una vicenda modificativa, come è confermato, peraltro, dalla previsione di diritti di recesso del socio – v. art. 2437 c.c. per le spa-.
In ambito UE, poi ( esclusa la Danimarca; e salvo l’esito della Brexit in relazione all’U.K.), vale l’individuazione del COMI ( centre of main interest) del debitore ai fini della determinazione della giurisdizione nazionale in caso di società insolvente, secondo l’art. 3, Reg. UE 848/2015, entrato in vigore dal giugno 2017 ( in sostituzione del previgente Reg. CE 1346/2000): ivi è stabilito che “Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il COMI è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per le società e le persone giuridiche si presume che il COMI sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza” ( cfr. Leandro-Meo-Nuzzo, Crisi transfrontaliera di impresa: orizzonti internazionali ed europei, Bari, 2018).
Quanto alle fonti di diritto interno, il Codice della crisi 2019 riprende questa nozione di COMI, riportandola all’art. 2, lett. m); e sulla giurisdizione internazionale, l’art. 26 richiama la normativa dell’Unione europea.
Nel tempo, la giurisprudenza di merito ha elaborato una sorta di catalogo di indici presuntivi della fittizietà del trasferimento della sede ( e di nuova fissazione del COMI di una società), facendo volta volta riferimento: al luogo in cui si forma la volontà dell’ente; alla cittadinanza (italiana) dei componenti del cda o di chi ha maggiormente operato per l’impresa (Trib Roma, 24 aprile 2015); alla assenza di significativi collegamenti con ordinamento straniero ( es. solo apertura di casella postale o di utenza tel o mancato utilizzo del nuovo c/c); alla prosecuzione o meno della medesima attività dopo il trasferimento (fittizio) all’estero o assenza di svolgimento di attività presso la nuova sede estera o continuazione nel contratto di affitto di azienda (in Italia); alla implausibilità di un trasferimento all’estero in presenza di conclamata crisi (Cass., 21 gennaio 2014, n. 1508); alla localizzazione in Italia degli unici valori immobiliari o del domicilio di tutti i soci (Cass., S.U., 11 marzo 2013, n. 5945, in Dir. Fall., 2014, 95 ).
Quando viene rilevato un carattere fittizio e simulato del trasferimento si opera la perpetuazione della giurisdizione del giudice italiano ( sull’assunto che la competenza fallimentare sia inderogabile: cfr. Cass 13 ottobre 2008, n. 25038,): vuoi mediante equiparazione della cancellazione per trasferimento all’estero a quella estintiva, così da dare luogo alla applicazione dell’art. 10 l. fall., entro l’anno dal trasferimento ( cfr. Cass., 4 gennaio 2017, n. 43; Cass., 17 febbraio 2016, n. 3059, in Giur. it., 2016, p. 1402; Cass., S.U., 11 marzo 2013, n. 5945; Cass., S.U., 3 ottobre 2011, n. 20144, in Dir. Fall. 2012, 142 ); vuoi ricorrendo alla rimozione della cancellazione ( Cass., 18 aprile 2013, n. 9414, in Giur. it., 2014, 3; Trib. Milano, 7 gennaio 2013, in Società, 2013, 347). Sembra a chi scrive che invece la questione sulla giurisdizione per l’apertura di una procedura concorsuale debba andare risolta esclusivamente sulla scorta di una corretta individuazione dell’effettivo COMI del debitore, secondo la normativa Unionistica ed interna sopra richiamata. Mentre andrebbe esclusa sia l’applicazione dell’art. 10 l. fall. ( e v. art. 33 Codice della Crisi), stante la natura modificativa e non estintiva dell’operazione di trasferimento intra-UE; ed esclusa d’altronde la correttezza della applicazione dell’art. 2191 c.c. sulla revoca della iscrizione della cancellazione.