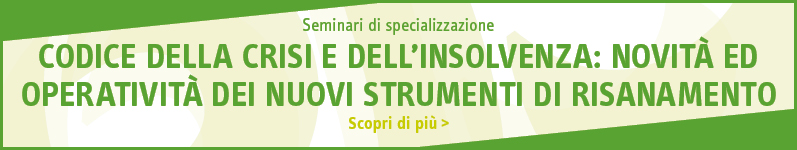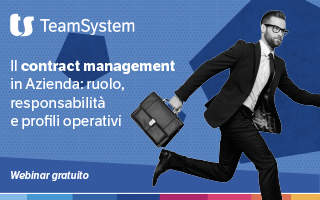Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società fallita: inversione dell’onere della prova e criteri di determinazione del quantum risarcitorio
di Giulio Marconcin, Avvocato Scarica in PDFCassaz., 5 gennaio 2022, n. 198, Pres. A. Scaldaferri – Rel. A. Fidanzia
Parole chiave: Fallimento – Società di capitali – Società per azioni – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Omessa o irregolare tenuta della contabilità – Onere della prova – Ripartizione fra attore e convenuto – Inversione dell’onere della prova – Determinazione del danno – Liquidazione equitativa del danno
Massima: “Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
“Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l. fall., ove la mancanza o l’irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 cod. civ. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa”.
Disposizioni applicate
Art. 146 l. fall. – Art. 2486 cod. civ. – Art. 2697 cod. civ.
La pronuncia in commento offre l’occasione di ripercorrere alcuni principi che trovano applicazione nel contesto di azioni di responsabilità promosse, ex art. 2486 cod. civ., dalle curatele fallimentari nei confronti degli organi gestori di società di capitali. Principi che rilevano in tema di inversione dell’onere probatorio, regolare tenuta delle scritture contabili, valutazione degli atti gestori posti in essere dai medesimi e criteri di quantificazione del danno risarcibile.
In particolare, la Suprema Corte si è focalizzata, inter alia, sulla tematica della ripartizione dell’onere prova (tra attore e convenuto) in relazione al compimento, da parte degli amministratori della società fallita, di atti di gestione non conservativa dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Il tutto, nel peculiare scenario della omessa o carente tenuta delle scritture contabili della società fallita.
CASO
Con sentenza depositata il 25 maggio 2017 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. (OMISSIS) del Tribunale di Tivoli, depositata il 26 agosto 2009, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei confronti dell’amministratore unico (e socio al 50%) della società fallita, e dell’altro socio, titolare dell’altro 50% delle quote della medesima.
L’azione era stata proposta dalla curatela sul presupposto della violazione, da parte dell’amministratore unico della società, del principio di gestione conservativa del patrimonio sociale sancito dall’art. 2486 cod. civ., per avere questi proseguito l’attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società. Il tutto, con conseguente aggravio del passivo della medesima.
SOLUZIONE
Nel motivare la sentenza d’appello, i giudici di seconde cure evidenziavano, per quanto qui di interesse, che essendo onere del Fallimento individuare, in modo specifico, il comportamento dell’amministratore successivo al verificarsi della causa di scioglimento da cui sarebbe derivato il danno alla società, “nel caso di specie le allegazioni della curatela si erano palesate del tutto generiche e non precisate sotto il profilo degli atti specifici di gestione e della loro idoneità a generare ulteriore debito aziendale”.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
La pronuncia in esame, pur non apportando novità significative nel panorama giurisprudenziale di riferimento (cfr. Cass. Civ., 5 febbraio 2015, n. 2156; Cass. Civ., SS. UU., 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. Civ., 8 febbraio 2000, n. 1375; Trib. Ferrara, 1° marzo 2016, tutte in OneLegale) offre alcuni spunti interessanti sui temi dell’inversione dell’onere della prova e della liquidazione equitativa del danno nel particolare contesto in cui vengano a mancare, in tutto o in parte, le scritture contabili o non consentano di ricostruire analiticamente gli atti negoziali contestati agli amministratori.
Sono due, infatti, i profili su cui si fonda la decisone in commento, ossia: (i) la prova circa il compimento – in violazione dell’art. 2486 cod. civ. – di atti gestori non conservativi da parte dell’amministratore unico e la ripartizione, tra attore e convenuto, del relativo onere probatorio per effetto dell’omessa tenuta delle scritture contabili, da un lato, e (ii) l’individuazione dei criteri di determinazione del quantum risarcitorio, dall’altro lato.
Come noto, chi agisce con azione di responsabilità – promossa nei confronti di amministratori di una società di capitali per atti compiuti dopo il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società – è tenuto ad assolvere, ex art. 2697 cod. civ., all’onere di allegare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, ossia: (i) la sussistenza della causa di scioglimento della società ex art. 2484 cod. civ.; (ii) il compimento, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti negoziali da parte degli amministratori; (iii) la prova che tali atti negoziali costituiscano prosecuzione della normale attività (con correlativo rischio) di impresa, come tale idonea a pregiudicare i diritti dei soci e dei terzi creditori.
Sennonché ove, come nel caso di specie, le scritture contabili non siano tenute regolarmente, impedendo alla curatela non solo di ricostruire analiticamente gli atti gestori, ma anche di formulare una precisa quantificazione del danno, lo scenario muta sensibilmente alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 2156/2015 e SS. UU. n. 9100/2015.
In particolare, tale circostanza è rilevante in quanto determina un’inversione dell’onere della prova in relazione alla dimostrazione della circostanza di cui al punto (iii).
Il tutto, con la conseguenza che – osservano i giudici di legittimità – “spett(erà) … agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari”.
Passando, quindi, al tema della quantificazione del danno risarcibile in mancanza delle scritture contabili, la Suprema Corte ha ribadito la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 1226 cod. civ. sulla liquidazione in via equitativa (cfr. App. Milano, 10 giugno 2019, n. 2513, in OneLegale.it).
La liquidazione in via equitativa risponde, evidentemente, all’esigenza di rimediare a una pressoché impossibile determinazione del danno patrimoniale subito dalla società e, di riflesso, dai creditori della medesima.
Per ovviare a tale ipotesi la giurisprudenza aveva fatto ricorso a tre criteri di quantificazione, di cui due di carattere presuntivo ed equitativo: (i) quello c.d. ‘differenziale’ (rappresentato dalla differenza tra attivo acquisito e passivo accertato nel corso della procedura fallimentare) (cfr. Centonze (2016), Art. 2486, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa-Portale, II, Torino, 2882); (ii) quello della perdita incrementale (costituita dalla differenza tra il patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento, eventualmente rettificato per far emergere la perdita, e quello esistente al momento della dichiarazione di fallimento (cfr. ex multis, Trib. Milano, 11 novembre 2002, in Società, 2003, 1015); (iii) quello del danno effettivo (cioè riconducibile alle singole condotte illecite compiute dopo il verificarsi della causa di scioglimento: cfr., tra le tante, Cass SS. UU., 6 maggio 2015, n. 9100, in Società, 2015, 8-9, 1034; Cass., 23 giugno 2008, n. 17033; in Fall., 2009, 569; Cass., 23 luglio 2007, n. 16211, in Giust. Civ., 2007, I, 2708).
Nel 2019, come noto, è intervenuto il legislatore della riforma concorsuale che, nel codificare il criterio giurisprudenziale dei c.d. “netti patrimoniali”, richiamato in diverse pronunce giurisprudenziali, ha introdotto all’art. 2486, terzo comma, cod. civ., una presunzione relativa di quantificazione del danno in misura pari alla “differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484”, fatta salva “la prova di un diverso ammontare”.
Si tratta di una modifica che incide sulla ripartizione, tra le parti, dell’onere della prova dei danni subiti dalla società, scaricando di fatto sugli amministratori convenuti in giudizio l’onere di provare che il danno causato dal loro comportamento sia inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio legale.
Benché il criterio dei c.d. netti patrimoniali sia ora cristallizzato all’art. 2486, terzo comma, cod. civ., l’omessa o insufficiente tenuta delle scritture contabili, non consentendo la ricostruzione dei netti patrimoniali, legittima tutt’ora il ricorso alla liquidazione calcolata come differenza tra attivo e passivo accertati nell’ambito della procedura.
Alla luce di quanto precede, nel caso di specie la Suprema Corte, accertata l’omessa tenuta delle scritture contabili, ha rimesso al giudice di seconde cure il nuovo esame della questione sul rilievo che il curatore aveva assolto all’onere di allegare, da un lato, le condotte inadempienti imputabili all’amministratore nel corso della gestione e di provare, dall’altro lato, la sussistenza del nesso causale tra i medesimi e il danno subito dalla società.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia