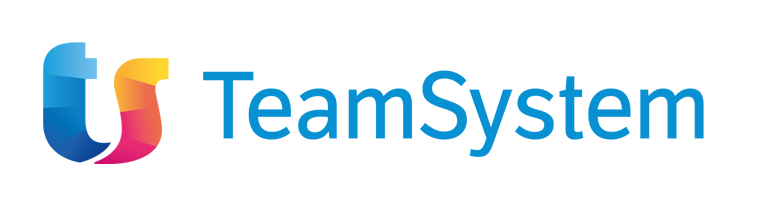Appello e riforme processuali: le modifiche all’art. 342 c.p.c.
di Fabio Cossignani Scarica in PDFSi dà conto delle più recenti riforme che hanno interessato il giudizio di appello, muovendo innazitutto dalle modifiche all’art. 342 c.p.c. che disciplina il contenuto dell’atto di impugnazione.
1. Introduzione
Di regola, nel giudizio di primo grado le facoltà delle parti in punto di allegazione e di prova sono per ovvie ragioni ampie (anche se risultano talvolta cadenzate da un sistema di preclusioni e decadenze). La loro restrizione ingiustificata determinerebbe infatti la violazione del diritto di azione e di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Nel giudizio di cassazione, viceversa, le facoltà delle parti sono per definizione delimitate, in ragione innanzitutto (ma non solo) delle finalità del giudizio stesso, volto a verificare la sussistenza di casi di annullabilità della sentenza (giudizio rescindente) e non invece a fornire alle parti la cd. decisione del caso concreto. Infatti, se il provvedimento viene cassato, la pronuncia sul merito è rimessa al (diverso) giudice del rinvio (giudizio rescissorio), salvi soltanto casi eccezionali (art. 384, co. 2, c.p.c.).
Nel mezzo sta il giudizio di appello. È opinione dominante che il doppio grado di merito non goda di copertura costituzionale e che, pertanto, l’appello possa essere anche sottratto dal sistema delle impugnazioni. Un simile passo non è tuttavia stato compiuto, in virtù della persistente convinzione che il giudizio di appello garantisca alle parti l’accesso a una decisione migliore rispetto alla precedente. Ad ogni modo, la posizione interstiziale dell’appello ne giustifica la duttilità.
Non a caso si sono a lungo contrapposte due differenti ricostruzioni dell’istituto: quale novum iudicum, da un lato, quale revisio prioris instantiae, dall’altro.
La vicenda storica dell’appello disciplinato dal nostro codice disegna una parabola che va da un originario accostamento al primo modello per giungere, in tempi più recenti, a una sostanziale adesione al secondo. Il percorso che conduce dall’appello inteso come mezzo di gravame all’appello come mezzo di impugnazione in senso stretto può dirsi ormai completo e le analogie col giudizio di cassazione si sono fatte via via sempre più evidenti, benché l’appello conservi comunque il carattere di impugnazione a critica libera.
L’ultima tappa di questa evoluzione è segnata dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod., dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 che ha riscritto in più punti la disciplina dell’appello.
2. Il nuovo art. 342 c.p.c.
La novella del 2012 ha modificato l’art. 342, co. 1, c.p.c.
Il testo previgente era il seguente: «L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163».
Questo il testo attualmente in vigore: «L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Prima della riforma, per effetto dell’evoluzione della giurisprudenza sul punto, l’appello era considerato inammissibile ove privo dei «motivi specifici». L’inammissibilità, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo decadenziale (art. 358 c.p.c.), non era espressamente comminata dalla legge, ma veniva dedotta in via interpretativa (v. in particolare Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
I motivi di appello dovevano essere idonei non solo ad individuare la parte di sentenza impugnata (intendendosi per “parte di sentenza” la “questione” decisa e non la “domanda”), ma anche ad esporre le ragioni della riforma, secondo un metro di specificità non predeterminabile a priori, perché necessariamente proporzionato all’analiticità della decisione impugnata. In tale contesto, il motivo specifico solitamente non prescindeva dal momento della “sintesi”, individuando così, quantomeno implicitamente, la diversa e più corretta soluzione che avrebbe dovuto sostituire la precedente.
Tuttavia, va detto che tale ultimo requisito non era stato autonomamente individuato e richiesto dalla giurisprudenza a pena di inammissibilità. Ed è proprio su questo aspetto che si concentra il potenziale innovativo della riforma.
Infatti, al di là della ondivaga formulazione di legge – che separa i contenuti dell’appello a pena di inammissibilità nell’ipotesi di contestazione della ricostruzione in fatto (n. 1) da quelli richiesti in caso di contestazione in diritto (n. 2) (sulla necessità di ritenere complementari tali requisiti, quale che sia la censura mossa alla sentenza, v. Poli, Il nuovo giudizio di appello, in Riv. dir. proc., 2013, 126) – le prescrizioni circa «l’indicazione delle parti del provvedimento» (n. 1) e «l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza» (n. 2) rappresentano null’altro che una trasposizione (giudicata «goffa» da Consolo, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di “svaporamento”, in Corr. giur., 2012, 1133) di consolidati orientamenti giurisprudenziali, se non, addirittura, di principi fondamentali in tema di impugnazioni (ad es., la «rilevanza» della violazione di legge, che, nonostante sia assorbita dal generale requisito dell’interesse ad impugnare, ai sensi del n. 2 dovrebbe per giunta essere “indicata”, quasi che non costituisca un carattere intrinseco della “violazione” denunciata).
Invece, le «modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto [o alla soluzione della questione di diritto]», se intese restrittivamente, sono riconducibili nell’alveo della precedente “specificità” dei motivi, potendo così risultare anche implicitamente dall’atto, ancorché in maniera inequivoca. Ma se la formula di legge viene intesa in senso estensivo, si rischia di onerare la parte alla predisposizione di un “progetto di sentenza”, al fine di agevolare l’attività decisoria del giudice (cfr. App. Salerno, 1° febbraio 2013, in Giust. proc. civ., 2013, 481, con nota critica di Scarselli).
Ci si augura che la giurisprudenza non si adagi su un’interpretazione troppo formalistica, quantomeno perché la sanzione sarebbe palesemente sproporzionata rispetto alla deficienza dell’appello, con sproporzione massima in caso di manifesta fondatezza nel merito di quest’ultimo.
Se si conviene su ciò, la riforma dell’art. 342 c.p.c. va intesa come una modifica non sostanziale del dettato normativo. Va da sé, tuttavia, che la maggiore analiticità della legge sortirà un analogo effetto anche sul contenuto degli atti di appello. La parte impugnante tenderà ragionevolmente a cautelarsi rispetto al rischio di interpretazioni troppo rigide, così che quegli atti che in precedenza sarebbero stati redatti rispondendo al criterio della “specificità dei motivi”, saranno ora redatti con motivazioni sì specifiche, ma molto spesso anche prolisse e pedanti.
Purtroppo, in ciò vi è la conferma che il nostro legislatore non possiede ancora una visione ampia e organica della giustizia civile e dei suoi problemi.
Basti pensare, tra molto altro, che di recente (con d.l. n. 83/2015, conv., con mod., dalla l. n. 132/2015) è stato aggiunto un co. 9 octies all’art. 16 bis d.l. n. 179/2012 che così recita: «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».