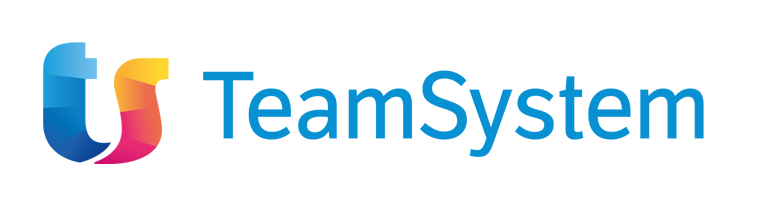Ancora sulla distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10640, Pres. Doronzo – Est. Ponterio
[1] Processo civile – Legittimazione ad agire – Titolarità del diritto sostanziale dedotto – Differenze (art. 81 c.p.c.)
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (nella specie, relativa al pagamento delle differenze retributive e della tredicesime mensilità a una collaboratrice domestica, gravava sulla lavoratrice, ricorrente in primo grado, l’onere di dimostrare la titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo al presunto datore; quest’ultimo aveva ritualmente contestato la propria legittimazione passiva, sia pure nella memoria di costituzione tardiva in primo grado, senza tuttavia che da tale tardività potesse derivare alcuna preclusione dato il carattere di mera difesa della suddetta contestazione).
CASO
[1] Una lavoratrice domestica proponeva domanda di condanna del proprio datore di lavoro al pagamento del TFR e delle differenze retributive e tredicesima mensilità, dallo stesso non versati.
Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al pagamento del TFR, ritenendo non applicabile il contratto collettivo di settore.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Napoli condannava il datore di lavoro al pagamento delle predette differenze retributive e tredicesima mensilità ritenendo all’opposto applicabile, quale parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente, il contratto collettivo sul lavoro domestico. Nel corpo della motivazione, la pronuncia di seconde cure dava atto del fatto che “la sussistenza del rapporto [di lavoro] tra le parti in causa risulta[sse] accertata nella sentenza di primo grado e al riguardo non risulta[sse] proposto appello incidentale”.
Avverso tale sentenza, il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, di cui verrà esaminato il primo motivo. Per suo tramite, il ricorrente denunciava, ex art. 360, n. 5), c.p.c., il fatto che nessuna statuizione era stata adottata, nella sentenza di secondo grado, sulla sua eccezione (sollevata sia in primo grado che nella memoria di costituzione in appello) circa il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità passiva del rapporto di lavoro); sottolineava, inoltre, come tale doglianza costituisca una mera difesa, che la parte può sollevare in ogni stato e grado del giudizio e senza necessità di proporre appello incidentale; evidenziava, infine, che l’attore non avesse allegato e dimostrato l’elemento costitutivo della domanda concernente la titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo al convenuto.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha rigettato, ritenendolo infondato, il motivo di ricorso proposto, dopo averlo riqualificato ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c.
In prima battuta – e in ciò chiarendo una sovrapposizione concettuale in cui spesso s’incappa, nel gergo forense -, la Cassazione ha chiarito come, nel caso di specie, fosse in contestazione non la sussistenza della legittimazione (passiva) ad agire in capo al convenuto, bensì la titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo allo stesso.
Il provvedimento prosegue chiarendo come, in effetti, la titolarità, attiva e passiva, della posizione soggettiva dedotta in giudizio rappresenti un elemento costitutivo della domanda, attinente al merito della decisione, il cui onere dimostrativo grava in capo all’attore, e che le relative contestazioni da parte del convenuto hanno la natura di mere difese, in quanto tali svincolate da termini preclusivi.
Tuttavia, nel caso di specie, doveva ritenersi formato il giudicato interno sul punto, essendo presente, nella sentenza di primo grado, l’accertamento espresso relativo alla titolarità del rapporto di lavoro subordinato in capo al convenuto: conseguentemente, al fine di dolersi di tale statuizione, il convenuto non poteva limitarsi a sollevare una mera difesa nell’ambito della sua memoria di costituzione in appello, ma avrebbe dovuto proporre appello incidentale. In mancanza, la formazione del giudicato interno sul punto della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non può formare oggetto di ulteriore contestazione di parte o rilievo d’ufficio.
Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso per cassazione proposto.
QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene, in definitiva, alle modalità di censura delle questioni attinenti alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Preliminare all’analisi della stessa, peraltro, il provvedimento opportunamente chiarisce la distinzione tra titolarità del rapporto controverso e legittimazione ad agire: concetti sui quali, come noto, spesso si assiste a una certa confusione nel mondo forense e in cui, nel caso di specie, lo stesso convenuto in primo grado è incorso.
La legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell’azione la cui definizione, tradizionalmente ricavata dal testo dell’art. 81 c.p.c. («Sostituzione processuale»), può essere compendiata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio: la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell’affermazione, secondo cui è sufficiente che, all’interno della domanda, l’attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell’obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa. Tale distinzione spiega perché, in caso di difetto di legittimazione ad agire, il processo si chiuda con una pronuncia di rigetto in rito, mentre in caso di accertata mancanza di titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio la domanda dev’essere rigettata nel merito (sul punto, E. Merlin, Elementi di diritto processuale civile, Pisa, 2017, 56 ss.).
La distinzione è stata recentemente chiarita anche dal massimo organo di nomofilachia (Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951, in Riv. dir. proc., 2017, 234 ss., con nota di M.F. Ghirga, Sulla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, richiamata dal provvedimento in commento), dove, in primo luogo, si è precisato che: a) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare; mentre b) la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito della causa.
Sulla scorta di tale distinzione, le Sezioni Unite hanno poi affermato che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto».
Con riguardo al regime giuridico delle contestazioni che il convenuto può sollevare in ordine alla sussistenza della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore, le Sezioni Unite le qualificano quali mere difese, con la conseguenza per cui le stesse sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza peraltro che la contumacia o la tardiva costituzione della parte possano assumere valore di non contestazione o alterare gli ordinari oneri probatori.
Applicando tali principi al caso di specie, è dunque indubbio come gravasse sulla lavoratrice attrice l’onere di dimostrare la titolarità (in particolare passiva) del rapporto di lavoro in capo al datore, il quale la aveva ritualmente contestata nella memoria di costituzione in primo grado, pur se tardivamente depositata: trattandosi di mere difese, come detto, la tardività del deposito della memoria non incide sulla ritualità di tale attività assertiva.
Come si è anticipato, tuttavia, la soluzione della controversia è stata determinata dai vigenti principi in materia di giudicato interno: sulla sussistenza della titolarità del rapporto di lavoro si era infatti espressamente pronunciata la sentenza di primo grado – che, evidentemente, aveva ritenuto assolto il relativo onere della prova gravante in capo alla lavoratrice attrice -, ingenerando un onere, in capo al datore di lavoro tuttora interessato a contestarla, di proporre gravame sul punto, non potendo più ritenersi sufficiente la proposizione di una mera difesa. E in mancanza di appello incidentale, la formazione del giudicato interno su detta questione ne ha impedito l’ulteriore rilievo in sede di legittimità.