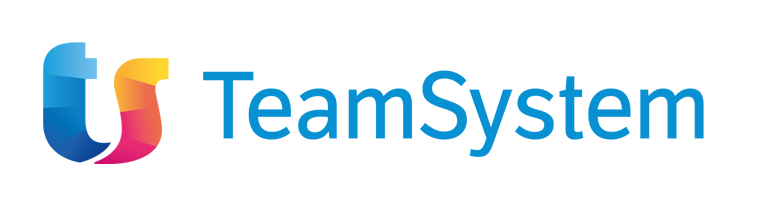Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegrazione nel posto di lavoro
di Ginevra Ammassari Scarica in PDFCass. 2 maggio 2018, n. 10435 – Pres. Di Cerbo – Est. Boghetich
Lavoro (rapporto) – Licenziamento, giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Obbligo di repêchage – Violazione – Tutela reale – Tutela indennitaria – Applicabilità (l. 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 1, comma 42; l. 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18, commi 4, 5 e 7).
[1] Il vaglio giudiziale relativo alla «manifesta insussistenza del fatto» posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo investe non solo le ragioni organizzative addotte a sostegno del recesso datoriale, ma anche l’obbligo di repêchage, la cui violazione, qualora emerga ictu oculi dalle acquisizioni istruttorie, può condurre alla reintegrazione del lavoratore prevista dall’art. 18, comma 7°, St. Lav. a condizione che tale regime sanzionatoria non rappresenti una conseguenza eccessivamente onerosa per il datore di lavoro.
CASO
[1] All’esito del giudizio di reclamo proposto ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, la Corte di Appello di Bologna, nell’accertare il mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage gravante sul datore di lavoro, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e, in applicazione del 5° comma, art. 18, St. Lav., riteneva di applicare la sola tutela indennitaria ivi prevista nell’ipotesi in cui non ricorrano «gli estremi del predetto giustificato motivo» di cui al 7° comma, art. cit.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, la quale ha dedotto che la violazione dell’obbligo di repêchage, nell’integrare l’ipotesi di «manifesta insussistenza del fatto» pure contemplata dal 7° comma, art. 18, St. Lav., conduce alla reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal successivo 4° comma in luogo della tutela indennitaria applicata dalla Corte territoriale.
SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la S.C. afferma che, sotto la vigenza dell’art. 18 St. Lav. così come modificato dalla l. n. 92/2012, il vaglio giudiziale in ordine alla «manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento» per giustificato motivo oggettivo investe entrambi gli elementi costitutivi di quest’ultimo, ovverosia: le ragioni organizzative poste a fondamento del recesso datoriale, nonché l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno della compagine aziendale.
Sulla base di tali premesse, la Corte aggiunge che la prova di tali elementi spetta in via esclusiva al datore di lavoro e che, tuttavia, la «manifesta insussistenza del fatto» ricorre nelle sole ipotesi in cui l’assenza dei citati presupposti emerga ictu oculi dalle acquisizioni istruttorie.
In ultimo, a fronte del margine di discrezionalità contemplato dal 7° comma, art. 18, St. Lav. ai fini dell’applicabilità della tutela reale, la Corte di legittimità afferma che il giudice «può» disporre la reintegrazione del lavoratore prevista dal 4° comma, art. cit. qualora ritenga che tale regime sanzionatorio non rappresenti una conseguenza eccessivamente onerosa per il datore di lavoro, da valutarsi al momento di adozione del provvedimento giudiziale.
QUESTIONI
[1] Secondo il prevalente orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consta di tre elementi strutturali, rispettivamente rappresentati da: i) l’effettiva modifica dell’organizzazione aziendale; ii) il nesso causale tra questa e il recesso intimato; iii) l’impossibilità di ricollocare il lavoratore all’interno della compagine aziendale.
Nella giurisprudenza più recente, quanto alla portata del requisito sub i), cfr. Cass. 15 febbraio 2017, n. 4015, Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro (rapporto), n. 658; quanto, invece, alla rilevanza del collegamento eziologico tra le ragioni organizzative e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato di cui al punto ii), cfr. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201, id., 2017, I, 123 e 590, con note di G. Santoro-Passarelli e M. Ferrari, nonché con nota di richiami di A.M. Perrino; in ultimo, sul presupposto sub iii), riconducibile al c.d. obbligo di repêchage, cfr. Cass. 5 gennaio 2017, n. 160, Riv. giur. lav., 2017, II, 245 con nota di G. Cavellini e Riv. it. dir. lav., 2017, II, 12 con nota di A. Colella).
Sebbene non espressamente previsto dall’art. 3, l. n. 604/1966, l’impossibilità del repêchage è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, sotto il profilo negativo, denota lo stesso nesso causale richiesto dalla norma, giacché comprova che, a seguito della riorganizzazione aziendale, non sussistono posizioni vacanti cui adibire il lavoratore nel legittimo esercizio dello ius variandi (in tal senso, cfr., in dottrina M.T. Carinci, Obbligo di «ripescaggio» nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act, id., 2017, I, 203).
Tale impostazione, che assume l’impossibilità di collocare aliunde il lavoratore tra gli elementi costitutivi che legittimano il recesso datoriale (i.e.: il fatto estintivo del rapporto di lavoro), trova una inequivocabile conferma nella ripartizione degli oneri probatori accolta dalla giurisprudenza di legittimità che, in ossequio al combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 5, l. n. 604/1966, è costante nell’affermare che l’onere di allegazione e prova in ordine al repêchage gravano esclusivamente sul datore di lavoro (così, Cass. 11 ottobre 2016, n. 20436, Foro it., 2016, I, 3843; 13 giugno 2016, n. 12101, Giur. it., 2017, 412, con nota di M.R. Megna; 22 marzo 2016, n. 5592, id., 2016, 1164 con nota di M. Persiani; contra, v. l’isolata posizione di Cass. 10 maggio 2016, n. 9467, id., 2016, 2195 con nota di V. Miraglia, la quale esige una collaborazione del lavoratore nell’accertamento di un possibile repêchage mediante l’allegazione delle altre posizioni in cui avrebbe potuto essere utilmente ricollocato; sul tema, cfr. G. Iannumberto, Licenziamento e repêchage: allegazione e prova, in Riv. it. dir. lav., 2017, I, 398).
Sul punto, si segnala anche Cass. 19 aprile 2017, n. 9867, Foro it., Rep. 2017, voce Lavoro (rapporto), n. 614, la quale, seppur resa in ordine a una fattispecie di licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo, si inserisce nel solco di Cass., S.U., 10 gennaio 2006, n. 141, id., I, 704, con note di D. Dalfino e A. Proto Pisani e, nell’accostare il requisito dimensionale dell’impresa e il giustificato motivo addotto a fondamento del recesso, afferma che tali elementi sono, entrambi, fatti impeditivi del diritto alla reintegra (e non fatti estintivi del rapporto di lavoro) che, pertanto, devono essere provati dal datore di lavoro.
Sul punto, la sentenza in epigrafe, nel conformarsi al descritto orientamento giurisprudenziale, si impone all’attenzione giacché contribuisce a risolvere il contrasto invalso vuoi nella giurisprudenza, vuoi in dottrina, in ordine alla rilevanza della violazione dell’obbligo di ricollocazione del lavoratore a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, la quale ha introdotto una gradazione delle tutele a seconda del vizio connotante il licenziamento e limitato l’applicabilità della tutela reale alla sola ipotesi di «manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento» intimato per giustificato motivo oggettivo; al contrario, qualora non ricorrano i relativi presupposti, trova applicazione la tutela indennitaria c.d. forte prevista dal 5° comma dell’art. 18, St. Lav.
E infatti, la Corte smentisce la posizione di chi ritiene che l’obbligo di repêchage rappresenti un elemento estrinseco al giustificato motivo oggettivo (per una disamina delle opposte posizioni dottrinale espresse sul tema, sia consentito rinviare a G. Ammassari, L’oggetto del giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel c.d. rito c.d. Fornero, in questa Rivista) e afferma che anche la violazione di tale adempimento è idonea ad integrare la insussistenza manifesta del giustificato motivo oggettivo posto a fondamento del recesso di cui al 7° comma, art. 18, St. Lav. e funzionale all’applicazione della tutela reale ivi prevista.
Inoltre, la S.C., nel chiarire l’esatta portata da attribuire alla locuzione «manifesta» menzionata dalla norma, ritiene che tale qualificazione risponda all’intento del legislatore di limitare a ipotesi residuali l’applicabilità della tutela reintegratoria, riconducibile alle sole ipotesi in cui l’assenza dei presupposti legittimanti il licenziamento emerga con evidenza e sia facilmente riscontrabile sul versante probatorio (in tal senso, cfr., anche Cass. 25 giugno 2018, n. 16702, consultabile su www.italgiure.giustizia.it, nonché, già, Cass. 10 gennaio 2018, n. 331, Foro it., 2018, I, 472, la quale, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, afferma che il nuovo regime sanzionatorio previsto dalla riforma c.d. Fornero riserva la reintegrazione nel posto di lavoro, unitamente al risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, a ipotesi residuali ed eccezionali, connotate da una particolare evidenza dell’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento).
Tanto premesso, la Corte rileva che il dettato del 7° comma, art. 18, St. Lav. contempla la mera possibilità di disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e, in tal senso, attribuisce al giudice di merito un potere discrezionale (contra, v. Cass. 14 luglio 2017, n. 17528, id., Rep. 2017, voce Lavoro (rapporto) n. 560) che, in assenza dell’espressa (e specifica) predeterminazione normativa di criteri utili al suo esercizio, deve orientarsi in base ai principi generali dell’ordinamento e alle norme in tema di risarcimento del danno.
Tra questi – osserva la S.C. – figurano gli artt. 1384 e 2058 c.c.: quest’ultimo, come noto, prevede che il giudice possa disporre il risarcimento del danno per equivalente in luogo di quello in forma specifica, qualora quest’ultimo risulti eccessivamente oneroso per il debitore (sull’applicabilità dell’art. 2058 c.c. anche in ipotesi di responsabilità contrattuale, cfr. Cass. 17 giugno 2015, n. 12582, id., Rep. 2015, voce Danni civili, n. 177; in dottrina, sul tema, cfr. D.M. Frenda, Adempimento o risarcimento in forma specifica?, in Riv. dir. civ., 2017, 276; ).
Sul punto, occorre osservare che, nel nostro ordinamento, la norma cardine che, tradizionalmente, presidia il rapporto (in termini di regola-eccezione) intercorrente tra la tutela in forma specifica e quella per equivalente è costituita dall’art. 24, 1° comma, Cost., il quale, attraverso la combinazione del principio di atipicità del diritto d’azione, da un lato, e quello di effettività della tutela giurisdizionale, dall’altro, garantisce a chi è costretto ad agire in giudizio e servirsi del processo «tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire alla stregua del diritto sostanziale» nei limiti del possibile e sempre che ciò non comporti un sacrificio irragionevole per il soggetto obbligato (così, G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile: le azioni, il processo di cognizione, Napoli, 1928, 81).
La sentenza in epigrafe, pur richiamando i principi generali dell’ordinamento, omette ogni riferimento a quelli ricavabili dalla Carta costituzionale, così come omette di distinguere tra tutela in forma specifica in senso stretto e risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c., giacché, nell’introdurre tale norma, accosta il risarcimento per equivalente alla «tutela reintegratoria» tout court (sulla necessità di distinguere i due istituti rimediali, rispettivamente di tipo risarcitorio o restitutorio, a seconda che il danno sia già stato cagionato, o meno, v. S. Mazzamuto, Problemi e momenti dell’esecuzione in forma specifica, in Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. Mazzamuto, II, Napoli, 1989, 475).
Invero, la distinzione non è di poco conto, giacché è opinione condivisa quella secondo cui, a seguito delle ultime riforme che hanno interessato l’art. 18, St. Lav., la reintegrazione nel posto di lavoro ha perso la propria funzione originaria e, mutando altresì la propria natura di strumento di tutela di tipo ripristinatorio, ha assunto un’attitudine sanzionatoria (in tal senso, v., diffusamente, A.D. De Santis, Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile, Roma, 2018, 158).
Attualmente, infatti, la reintegra è prevista esclusivamente dall’art. 2, d.lgs. n. 23/2015, il quale disciplina le ipotesi in cu il licenziamento è affetto da vizi ritenuti particolarmente gravi, tra i quali nullità, discriminatorietà e oralità; del pari, anche la reintegrazione prevista dal 7° comma, art. 18, St. Lav. in ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si accompagna non al pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio termine da lavoratore, bensì alla corresponsione di un’indennità risarcitoria predeterminata nel quantum e onnicomprensiva, giacché riferibile al periodo ricompreso tra il giorno del licenziamento e quello di effettiva reintegrazione, unitariamente considerato (sul punto, cfr. Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86, Foro it., 2018, I, 1842, la quale, nel dichiarare infondati i dubbi di legittimità costituzionali sollevati in ordine a tale disposizione da Trib. Trento 26 luglio 2016, Giur. it., 2017, 718, con nota di F. D’Addio, ha sancito l’onnicomprensività, nonché la natura risarcitoria, e non retributiva, delle somme de quibus, con ovvie conseguenze circa la (possibile) restituzione delle stesse in ipotesi di riforma della sentenza di condanna alla reintegrazione e, in ultimo, alla speculare incoercibilità di quest’ultima qualora il datore di lavoro non la ottemperi; in tema cfr., nuovamente, A.D. De Santis, cit., 158 e 206).
Anche tale distinzione non sembra emergere dalla sentenza in epigrafe, la quale, nel ritenere l’applicabilità dei principi ricavabili ex artt. 1384 e 2058 c.c. alla fattispecie prevista dal 7°, art. 18, St. Lav., si riferisce indistintamente all’eccesiva onerosità della «reintegrazione in forma specifica» quale forma di tutela e/o di risarcimento, ovvero del relativo «regime sanzionatorio» (sul progressivo riconoscimento di una natura duplice, di tipo sanzionatorio oltre che strettamente risarcitorio, connotante gli istituti sottesi al sistema di responsabilità civile, si rimanda al dibattito, che non è possibile approfondire in questa sede, sviluppatosi a seguito di Cass., S.U., 5 luglio 207, n. 16601, Foro it., 2017, I, 2613, con nota di A Palmieri, R. Pardolesi; Corr. giur., 2017, 1042, con nota di C. Consolo; Giur. it., 2017, 1787, con nota di A. Di Majo, in tema di danni punitivi; del pari, molti degli spunti offerti dalla dottrina sul tema, si rinvengono, seppur specularmente, anche con riferimento alla disciplina di cui all’art. 614 bis c.p.c., il quale, nel dettare i criteri per la quantificazione delle misure coercitive ivi previste in ipotesi di inottemperanza degli obblighi disposti dal provvedimento giudiziale di condanna, menziona, a scanso della natura sanzionatoria riconosciuta all’istituto de quo, finanche «il danno quantificato e prevedibile»).
Tanto premesso, la sentenza in epigrafe, a conclusione del proprio ragionamento ermeneutico, afferma che l’eccessiva onerosità della reintegrazione nel posto di lavoro deve valutarsi con riguardo alla compatibilità tra questa e la struttura organizzativa assunta dall’impresa al momento di adozione del provvedimento giudiziale; soluzione, questa, che, nel disattendere il principio cristallizzazione della situazione di fatto al momento dell’intimazione del licenziamento ai fini dell’applicazione della tutela reale, sembrerebbe confortare l’impostazione che, nel regime normativo attuale, afferma la natura sanzionatoria della reintegrazione nel posto di lavoro.
Sul punto, occorre notare che la soluzione accolta dalla Corte desta notevoli perplessità in ordine al principio di parità di trattamento, giacché ammette l’applicabilità di strumenti remediali differenti a licenziamenti individuali o collettivi che, adottati contestualmente dal medesimo lavoratore, siano dichiarati giudizialmente illegittimi in momenti diversi e (solo) occasionalmente caratterizzati da una diversa organizzazione aziendale; in ultimo, ulteriori problemi applicativi sorgono circa l’onere di allegazione e prova dell’eccessiva onerosità della reintegrazione, all’onere di impugnazione di una statuizione resa in tal senso, nonché all’eventuale riforma in appello della stessa, anche in considerazione della tradizionale rilevabilità ex officio riconosciuta a tale circostanza da Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128, Foro it., 2006, I, 106 e 432, con note di A. Palmieri e A.L. Bitetto, nonché in Riv. dir. proc., 2006, 715, con nota di G.F. Ricci (in argomento, cfr. anche Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310, Foro it., 2015, I, 3174, con nota di A. Motto; Corr. giur., 2015, 961, con nota di C. Consolo, secondo cui «la richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica»).