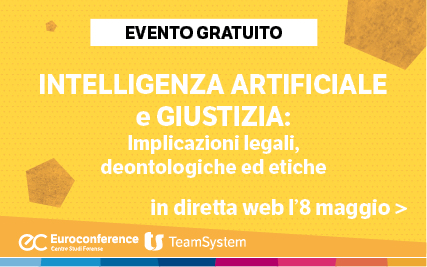Il verbale di inventario notarile costituisce fonte privilegiata per l’ammontare dell’asse ereditario
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCassazione civile sez. II, 05/04/2024, n.9063 (Articolo 775 Codice di procedura civile)
Massima: “Il verbale di inventario redatto dal notaio in base all’articolo 775 del codice di procedura civile, essendo un atto rogato nel corso delle sue funzioni, gode di pubblica fede e costituisce una fonte privilegiata per documentare l’entità dell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.”
CASO
Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda di tre soggetti che sostenevano di essere diventati i proprietari di un terreno nel Comune di Bacoli per successione a causa di morte, ordinandone il rilascio alla detentrice e il pagamento di una somma in denaro a titolo di indennità per mancato godimento dell’immobile. A sostegno della loro domanda i tre soggetti avevano prodotto in giudizio la dichiarazione di successione della loro defunta dante causa, il verbale di pubblicazione del testamento della medesima, l’accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte degli stessi e il relativo verbale di inventario redatto da un notaio ai sensi dell’art. 775 c.p.c. in cui detto bene era inserito. La detentrice del terreno contestava questa decisione, sostenendo di essere proprietaria dell’immobile in questione poiché costituente pertinenza di un fabbricato che aveva in precedenza acquistato dalla defunta, tuttavia, nell’ atto di compravendita non era menzionato nulla. La sentenza della Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado. E dunque la detentrice del terreno ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, la ricorrente lamentava un presunto error in iudicando della Corte di Appello in ordine alla prova della legittimazione attiva e della titolarità del diritto in capo agli originari attori attiva e della titolarità del diritto in capo agli originari attori errore nella decisione della Corte di seconde cure. In particolare, contestava il valore probatorio attribuito dalla Corte di Appello alla dichiarazione di successione della defunta e al relativo inventario redatto dal notaio.
SOLUZIONE
Con la sentenza in commento i giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Il primo motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, non avendo considerato adeguatamente alcuni fatti cruciali riguardanti la legittimazione attiva e la titolarità del diritto in questione. In particolare, viene contestata l’affidabilità del verbale di inventario redatto dal Notaio, sostenendo che non fornisce una prova sufficiente della legittimità dei diritti reclamati. Gli ermellini ritengono la doglianza infondata ritendendo che la Corte d’appello abbia fatto correttamente ricorso al seguente principio di diritto: “il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell’esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l’ammontare dell’asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all’interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare (Sez. 2 – , Sentenza n. 6551 del 16/03/2018).”
Il verbale notarile di inventario ha natura di atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso (art 2700 c.c.) e possiede inoltre efficacia probatoria privilegiata, e quindi fino a prova contraria, in ordine alla composizione del patrimonio ereditario. Il fondamento di ciò si rinviene nella qualifica di pubblico ufficiale posseduta dal notaio verbalizzante e nei caratteri salienti della funzione che l’ordinamento gli attribuisce: in altre parole, il potere di attribuire pubblica fede agli atti da lui formati e il dovere di assicurare la certezza dei rapporti, imporrebbe al notaio l’obbligo di accertare in prima persona la consistenza dell’eredità relitta.
Il verbale notarile possiede, come già detto, efficacia probatoria privilegiata, e quindi fino a prova contraria, in ordine alla composizione del patrimonio ereditario. Il fondamento di ciò si rinviene nella qualifica di pubblico ufficiale posseduta dal notaio verbalizzante e nei caratteri salienti della funzione che l’ordinamento gli attribuisce: in altre parole, il potere di attribuire pubblica fede agli atti da lui formati e il dovere di assicurare la certezza dei rapporti, imporrebbe al notaio l’obbligo di accertare in prima persona la consistenza dell’eredità relitta. Che il compito del notaio assuma tale portata si evincerebbe, inoltre, dagli artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c. La prima norma descrive il contenuto che il verbale notarile deve possedere; mentre la seconda, che impone al notaio di interrogare gli intervenuti in ordine all’esistenza di altri beni da inventariare, definisce un obbligo che non potrebbe essere logicamente svolto se non dopo una personale ricognizione dei beni costituenti l’asse ereditario infatti non avrebbe senso se il verbalizzante dovesse basare la sua attività unicamente sulle dichiarazioni, peraltro interessate, dei soggetti coinvolti nelle vicende successorie. Infine, l’elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell’attività di inventariazione da parte di un pubblico ufficiale, dovrebbe condurre a riconoscere agli esiti di tale attività natura di fonte privilegiata di prova.
QUESTIONI
I giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciuto piena efficacia probatoria all’inventario redatto dal Notaio, infatti, ha natura di atto pubblico e come tale ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fa piena prova fino a querela di falso di quanto il notaio attesti essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, nonché delle dichiarazioni dal medesimo ricevute.
L’inventario deve essere necessariamente scritto perché, tra l’altro, è richiesta la sottoscrizione (art. 2217 c.c. e 775 c.p.c.). e l’inventario giudiziale o per atto di notaio deve essere necessariamente scritto in lingua italiana (art. 122 c.p.c.).
L’inventario deve contenere, argomentando ex art. 772 e 771 in relazione all’art. 126 c.p.c., l’indicazione del giorno, mese ed anno di inizio, continuazione e chiusura (art. 774) e l’indicazione delle generalità delle persone che vi assistono e del luogo in cui si effettua la ricognizione dei beni, nonché delle generalità dello stimatore presente, nominato ex art. 773. Ove siano stati apposti, occorre che si dia atto della integrità dei sigilli e della loro rimozione.
Oltre tali elementi l’articolo 775 c.p.c. prevede in dettaglio il contenuto del processo verbale d’inventario, prescrive infatti che debba contenere:
a) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
b) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento (36);
c) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
d) l’indicazione delle altre attività e passività[1];
e) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli e lineare gli intervalli;
f) le eventuali osservazioni e istanze e le contestazioni delle parti circa l’opportunità di inventariare qualche oggetto che va anche descritto.
L’art. 775 è completato dall’art. 192 disp. att. c.p.c. che obbliga l’ufficiale procedente, prima di chiudere il verbale, a interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell’inventario.
L’interrogazione e la risposta vanno scritte nel verbale di inventario, il quale si chiude con la sottoscrizione di tutti gli intervenuti e dell’ufficiale procedente (art. 126 c.p.c.).
Nel caso di tutela il contenuto dell’inventario presenta alcune peculiarità. Viene qui in rilievo l’art. 364 c.c. il quale prescrive l’indicazione degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e la descrizione delle carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio. Per le formalità di redazione lo stesso articolo rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile (capo III tit. IV lb. IV). Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell’economia agraria alla formazione dell’inventario dell’azienda, che va depositato pure presso la pretura previo inserimento del riepilogo nell’inventario generale (art. 365 c.c.). Nell’inventario generale devono essere compresi anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all’inventario generale (art. 366 c.c.).
Il tutore deve dichiarare eventuali suoi crediti o debiti nei confronti del minore prima della chiusura dell’inventario (art. 367 c.c.).
Come documento descrittivo delle singole cose mobili di cui s’è potuto constatare l’esistenza e la cui identificazione è opportuna in ragione della possibilità di occultarle, l’inventario ha funzione probatoria[2]. Nella formazione di questa prova l’ordinamento tende ad apprestare tutti i mezzi possibili affinché essa risponda al requisito della verità[3].
Lo scopo cautelare dell’inventario in vista del quale è predisposta la disciplina della forma e del contenuto, caratterizzata da varia intensità secondo gli interessi tutelati, si traduce in una efficacia probatoria differenziata dell’inventario a seconda che sia semplice, in contraddittorio, pubblico e giudiziale.
Inventari semplici sono gli inventari (iniziale, di esercizio e di liquidazione) dell’imprenditore commerciale e delle società commerciali.
L’interesse alla veridicità dell’inventario costituisce il denominatore comune dei temi di regolamento della forma, del contenuto, della divergenza tra la verità del fatto reale rispetto al fatto dichiarato, dell’interpretazione[4].
L’efficacia probatoria delle registrazioni contabili dell’impresa commerciale, e quindi anche dell’inventario, è disciplinata negli art. 2709 e 2710 c.c. che rispettivamente prevedono la prova contro e a favore dell’imprenditore.
L’art. 2709 stabilisce che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore”. La formula “fanno prova contro” non esclude che l’imprenditore possa dimostrare che le registrazioni non corrispondono a verità: la norma non prevede una prova piena e assoluta, ma una di quelle presunzioni legali di cui tratta l’art. 2728 c.c.[5] Si tratta quindi di “una presunzione legale iuris tantum contraria all’imprenditore per le risultanze delle annotazioni contabili. Contro tali risultanze è possibile la prova che dovrà concernere l’inesistenza del fatto registrato e conseguentemente la erroneità o falsità della registrazione”[6]. A differenza della confessione scientemente difforme dal vero, la registrazione contabile falsa non vincola l’imprenditore; inoltre, non sono configurabili impugnazioni per incapacità, dolo o violenza contro le scritture contabili, mentre sono possibili contro la confessione[7].
Contro le scritture contabili erronee, nelle quali cioè vi è un’oggettiva divergenza tra il fatto reale e il fatto quale appare nella dichiarazione, vi è il rimedio generale della rettifica, “che costituisce il mezzo apprestato dalla legge per eliminare qualsiasi dichiarazione di verità e sostituirla con altra che non presenti vizi o anomalie”[8]. La base testuale di questo potere di rettifica è data dall’art. 2219 c.c. che espressamente prevede la possibilità di “cancellazioni” nei libri dell’impresa.
Gli inventari in contraddittorio sono quelli per i quali la legge non prescrive la forma giudiziale e gli interessati non si affidano al ministero di un notaio o non fanno ricorso al pretore ai sensi degli art. 769 e 777 c.p.c.
Non sembra fondata la tesi di chi, identificandole con la confessione (stragiudiziale), ritiene che le risultanze dell’inventario (in contraddittorio) fanno fede fra le parti e possano essere impugnate solo se determinate da errore di fatto o da violenza (art. 2732)[9] .
La distinzione, per l’aspetto che qui interessa, tra inventario così redatto e confessione, entrambe dichiarazioni di verità, non risiede, come a prima vista potrebbe sembrare, sull’assenza nel primo dell’animus confitendi, che del resto non è elemento essenziale della confessione[10]; la differenza consiste invece in ciò, che l’inventario in esame è obbligatorio, salvo rinunzia dell’interessato (ad esempio, nell’usufrutto), mentre la confessione è una dichiarazione eminentemente libera. In conseguenza, le dichiarazioni contenute nell’inventario non possono essere eliminate in caso di violenza (morale) o di incapacità, a meno che non siano erronee; la confessione invece, proprio perché ha natura di atto libero, può essere revocata se è stata determinata da violenza o emessa da un incapace, a prescindere dalla veridicità o meno del fatto confessato nel senso e nei limiti precisati dalla recente dottrina[11].
In conclusione, può dirsi che le dichiarazioni contenute nell’inventario redatto in contraddittorio costituiscono presunzioni semplici di verità, superabili quindi con la prova del contrario nell’ipotesi in cui le parti non raggiungano l’accordo sulla rettifica delle dichiarazioni erronee, che presentano cioè una oggettiva divergenza con il fatto reale.
L’inventario redatto dal cancelliere o dal notaio ai sensi dell’art. 769 c.p.c. oppure dal notaio richiesto dagli interessati è un atto pubblico, cioè un documento redatto da un «pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede» (art. 2699 c.c.). La qualità di «pubblico documentatore» del notaio (l. 16 febbraio 1913, n. 89) e del cancelliere (art. 57 c.p.c.), ricorrendo i requisiti previsti dalla legge (art. 2699 e 2701 c.c.), attribuisce ai fatti documentati nell’inventario una presunzione di fedeltà e di esattezza che si traduce in una efficacia probatoria privilegiata. Il documento infatti fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).
La presunzione iuris et de iure riguarda i cosiddetti elementi estrinseci del documento (provenienza, luogo e tempo), mentre dei cosiddetti elementi intrinseci l’efficacia probatoria privilegiata assiste solo le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La verità e l’esattezza delle dichiarazioni delle parti invece sono soggette a qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge[12] (48), come ad esempio i giudizi relativi alla quantità delle cose, al loro valore, al loro stato[13](49).
L’inventario è un atto ricognitivo che si traduce nella descrizione particolareggiata di tutto ciò che componga il patrimonio ereditario e, in particolare, di quanto il notaio verbalizzante rinvenga nell’abitazione del defunto ed, in genere, nei luoghi in cui si ritiene possano essere conservati i beni appartenenti a quest’ultimo, ivi incluso quello in cui esercitava la propria attività.
Le operazioni si svolgono alla presenza degli aventi diritto e, quindi, ai sensi dell’art. 771 c.p.c., del coniuge superstite, dei presunti eredi legittimi (tra i quali figurano, secondo alcuni, i legittimari totalmente pretermessi), l’esecutore testamentario ove nominato, gli eredi istituiti e i legatari e, infine, i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli. A tal fine, ai sensi dell’art. 770 c.p.c., il notaio deve assolvere l’onere di (individuare ed) avvisare, anche senza il rispetto di particolari formalismi, tali soggetti almeno tre giorni prima, comunicando loro il luogo, il giorno e l’ora in cui avranno inizio le operazioni di inventario. La mancata partecipazione di coloro che siano stati regolarmente avvisati non impedisce lo svolgimento delle operazioni di inventario; al contrario, l’omissione dell’avviso determina il diritto di impugnativa da parte degli aventi diritto non convocati.
I risultati dell’attività ricognitiva rappresentati dal pubblico ufficiale sono, sul piano probatorio, vincolanti per il giudice[14] e l’interessato che intenda contestarli, non essendo ammessa nemmeno per giuramento (art. 2739 c.c.) la prova diretta della erroneità o della inesattezza dei fatti attestati, può solo dedurre la falsità del documento attraverso la querela di falso (art. 2701 c.c.).
[1] Secondo la Cass. 3 ottobre 1959, n. 2664, in Foro it., 1960, I, 94, l’indicazione delle passività ereditarie non costituisce elemento indispensabile dell’inventario, prescritto ai fini dell’accettazione beneficiata, per il quale è necessaria e sufficiente la descrizione delle attività ereditarie.È opportuno ricordare che, come poste di inventario, mentre vanno esclusi i beni non patrimoniali, sono invece da includere i beni immateriali a carattere patrimoniale (ad esempio, i brevetti di invenzione e le opere dell’ingegno) suscettibili di valutazione economica (in proposito, cfr. PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962, 41 ss.)
[2] CANDIAN, Il processo di fallimento, Padova, 1934, 439.
[3] VOCINO, Contributo alla dottrina del beneficio d’inventario, Milano,1962, 354
[4] I temi di regolamento delle registrazioni contabili dell’impresa commerciale sono stati studiati ex professo da PANUCCIO, I temi di regolamento delle registrazioni contabili dell’impresa commerciale sono stati studiati ex professo da PANUCCIO, La natura giuridica delle registrazioni contabili, cap. II.
[5] BRACCO, L’impresa nel sistema del diritto commerciale, Padova, 1960, 340 s
[6] PANUCCIO, op. ult. cit., 21
[7] PANUCCIO, op. ult. cit., 22
[8] PANUCCIO, op. ult. cit., 133 s.
[9] DE MARTINO, Dell’usufrutto, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma,1961; PALERMO, Usufrutto. Uso. Abitazione, Torino, 1966, 252.
[10] PANUCCIO, La confessione stragiudiziale, Milano, 1960, 20 ss.
[11] Applicazione in tema di inventario di quanto sostenuto da PANUCCIO, La natura giuridica delle registrazioni contabili, cit., 29; PANUCCIO La confessione stragiudiziale, cit., 44 s.
[12] Cass. 11 marzo 1964, n. 525, in Giust. civ., 1964, I, 954; Cass., sez. un., 18 giugno 1962, n. 1528; Cass. 17 febbraio 1962, n. 326; Cass. 3 agosto 1961, n. 1880; Cass. 17 aprile 1958, n. 1262.
[13] DE MARTINO, op. cit., 258.
[14] DE MARTINO op. cit., 258.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia