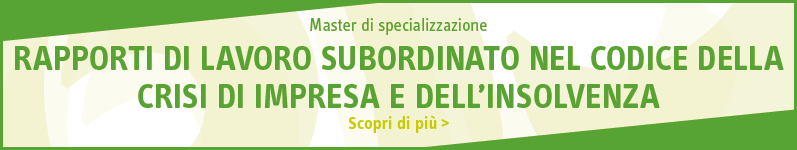Concordato fallimentare ed esdebitazione dai debiti tributari
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. I, 2 settembre 2022, n. 25924 – Pres. Scaldaferri – Rel. Vella
Parole chiave: Fallimento – Concordato fallimentare – Proposta del terzo – Liberazione immediata del fallito – Debiti tributari – Divieto di accollo liberatorio – Applicabilità – Esclusione
[1] Massima: In tema di concordato fallimentare, alla proposta concordataria formulata dal terzo con liberazione immediata del fallito ai sensi dell’art. 137, comma 7, l.fall., non si applica il divieto di accollo liberatorio del debito di imposta previsto dall’art. 8, comma 2, l. 212/2000.
Disposizioni applicate: r.d. 267/1942, art. 137; l. 212/2000, art. 8
CASO
Nell’ambito di una procedura concorsuale, una società terza presentava una proposta di concordato fallimentare che prevedeva, tra l’altro, il pagamento dei crediti erariali nella misura del 2% e la liberazione immediata della fallita, all’atto dell’omologazione, da tutte le passività nei confronti di tutti i creditori. A seguito del parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori e dell’approvazione da parte della maggioranza dei creditori chirografari, veniva chiesta l’omologazione del concordato fallimentare, cui si opponeva l’amministrazione finanziaria.
Il Tribunale di Brescia negava l’omologazione, ravvisando un contrasto con il divieto posto dall’art. 8, comma 2, l. 212/2000, che ammette l’accollo del debito di imposta altrui, ma senza liberazione del contribuente originario; anche il reclamo proposto ai sensi dell’art. 131 l.fall. dalla società che aveva presentato la proposta di concordato fallimentare veniva respinto.
Avverso il decreto di rigetto della Corte d’Appello di Brescia veniva proposto ricorso per cassazione, con il quale era censurata l’affermazione per cui alla liberazione immediata del fallito al momento dell’omologazione del concordato fallimentare prevista dall’art. 137, comma 7, l.fall. osta l’art. 8, comma 2, l. 212/2000 (a mente del quale l’accollo del debito altrui è possibile solo senza liberazione del contribuente originario).
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha affermato l’ammissibilità della liberazione immediata del debitore, qualora il terzo proponente assuma gli obblighi contemplati dal concordato fallimentare, anche se tra le passività vi siano debiti tributari, stante la portata generale della regola dettata dall’art. 137, comma 7, l.fall., a fronte della specialità di quella fissata dall’art. 8 l. 212/2000, insuscettibile di interpretazione estensiva in ambito concorsuale.
QUESTIONI
[1] Affermando un principio di diritto nell’interesse della legge, i giudici di legittimità hanno chiarito che la liberazione immediata del fallito, a fronte dell’assunzione degli obblighi derivanti dal concordato fallimentare da parte del terzo proponente, è possibile in tutti i casi, ossia anche quando le passività comprendano debiti erariali, non operando il divieto sancito dall’art. 8, comma 2, l. 212/2000, che ammette l’accollo del debito di imposta altrui, ma solo senza liberazione del contribuente originario.
L’art. 137, comma 7, l.fall., infatti, non pone alcuna distinzione tra le varie categorie di debiti del fallito, né indica casi nei quali la sua liberazione immediata non è possibile a fronte di un concordato proposto da un terzo o dai creditori.
Considerato, inoltre, che l’accollo – disciplinato dall’art. 1273 c.c. – consiste in un accordo tra il debitore e un terzo in forza del quale il secondo assume il debito del primo (che continua a rimanere obbligato in solido, a meno che la sua liberazione sia consentita dal creditore o costituisca una condizione espressa della stipulazione), quando la liberazione del fallito costituisca semplicemente una condizione della proposta di concordato fallimentare unilateralmente formulata dal terzo, non si è in presenza di un accordo e, dunque, di un accollo liberatorio.
Di conseguenza, non si tratta di una fattispecie riconducibile a quella considerata dall’art. 8, comma 2, l. 212/2000, che, in quanto norma speciale (propria dell’ordinamento tributario) e inderogabile, va interpretata in modo rigoroso.
Più in generale, l’autonomia e la specialità reciproche dell’ordinamento tributario e di quello concorsuale impediscono che le regole e i principi valevoli per il primo possano transitare automaticamente nel secondo per trovare ivi applicazione, dovendosene operare un preventivo vaglio di compatibilità.
Da questo punto di vista, la norma recata dall’art. 8, comma 2, l. 212/2000, se ha ragione di operare nell’ambito di un fisiologico rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, non risulta estensibile a una fattispecie patologica qual è quella concorsuale, in cui la soddisfazione del credito erariale, già definitivamente accertato in sede di formazione dello stato passivo, registra l’iniziativa concordataria di un terzo. Pertanto, poiché l’art. 137, comma 7, l.fall. è inequivocabile nel prevedere, in tema di concordato fallimentare, la possibilità di liberazione immediata del debitore, senza limitazioni di sorta, non può sostenersi che a ciò possa essere di ostacolo il divieto di accollo liberatorio sancito dalla disciplina tributaria.
Sotto altro profilo, chiedendosi se l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva stabilito dall’art. 53 Cost. valga a prescrivere che l’adempimento dell’obbligazione tributaria debba essere non solo completo, ma altresì riconducibile al soggetto che per legge vi è tenuto e se, di conseguenza, l’autonomia negoziale privata possa incidere sull’individuazione del soggetto passivo d’imposta, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che un simile patto è da considerarsi nullo per illiceità della causa e per contrarietà all’ordine pubblico solo quando abbia come conseguenza il fatto che l’imposta non viene corrisposta al fisco dal percettore del reddito.
Nel caso deciso dalla sentenza che si annota, invece, la società che aveva presentato la proposta di concordato fallimentare aveva prospettato di farsi carico del pagamento di tutti i debiti del fallito, nella misura concordataria falcidiata, non solo apportando risorse proprie, ma anche appropriandosi di tutti i beni, i diritti e le azioni già di pertinenza del fallito, con la conseguenza che l’intero patrimonio del contribuente – cioè del soggetto passivo d’imposta – sarebbe stato comunque destinato alla sua funzione solutoria, sia pure secondo le peculiari strutture proprie della procedura concorsuale.
L’assenza, peraltro, di ogni previsione di trattamento dei debiti fiscali nella disciplina del concordato fallimentare dimostra, secondo i giudici di legittimità, la prevalenza delle regole dell’ordinamento concorsuale nel caso in cui il debitore sia stato completamente spossessato e assoggettato alla procedura fallimentare, nella quale vige il principio della par condicio creditorum ogni volta che non sia specificamente derogato dalla legge. A tale riguardo, la ratio sottesa all’art. 8 l. 212/2000, che contempla la possibilità di estinguere l’obbligazione tributaria anche per compensazione o tramite accollo esterno, purché cumulativo e non liberatorio, è ispirata a un obiettivo che, in ambito fallimentare, risulta pienamente e ancora meglio tutelato, attraverso la sostituzione del curatore fallimentare al contribuente, il coinvolgimento di tutti i creditori e il costante controllo giudiziale.
A conforto dei rilievi svolti, nella sentenza annotata viene richiamata anche la giurisprudenza comunitaria, che ha ritenuto non contrario all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione Europea, un pagamento parziale di un credito IVA da parte di un imprenditore in stato di insolvenza nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, in ragione delle peculiari connotazioni di quest’ultima, rispetto alla quale quelle del concordato fallimentare sono ancora più stringenti.
A conclusione del loro ragionamento, i giudici di legittimità hanno reputato necessario svolgere alcune precisazioni in merito alla portata degli effetti esdebitatori del concordato fallimentare.
Gli effetti del concordato fallimentare si producono a seguito della definitività del decreto di omologazione della proposta e assommano una componente esdebitatoria – avuto riguardo alla liberazione del fallito dalle obbligazioni originarie – e una componente obbligatoria – avuto riguardo agli obblighi assunti dal fallito o dall’assuntore o dal terzo proponente – nei confronti dei creditori, nei limiti di quanto stabilito dalla proposta approvata e omologata.
Di regola, gli effetti esdebitatori del concordato fallimentare comportano che il fallito resti liberato solo per la quota della cosiddetta falcidia concordataria, ossia per la differenza tra l’ammontare originario del debito e la percentuale offerta ai creditori, fermi restando gli effetti obbligatori che derivano dalla conformazione del debito nella percentuale concordataria, che sopravvivono alla chiusura del fallimento, durante la fase di esecuzione del concordato (disciplinata dall’art. 136 l.fall.) e sino all’accertamento del suo completamento (con l’assunzione delle conseguenti misure da parte del giudice delegato).
Se il divieto di accollo liberatorio posto dall’art. 8, comma 2, l. 212/2000 fosse ritenuto ostativo alla liberazione immediata del fallito ai sensi dell’art. 137, comma 7, l.fall., ne deriverebbe un contrasto con il suo diritto all’esdebitazione anche dai debiti tributari sin dal momento della chiusura del fallimento, senza dovere attendere la completa esecuzione del concordato fallimentare (come sarebbe a dirsi a fronte di un accollo cumulativo).
La liberazione può essere, invece, totale, con esclusione degli effetti obbligatori del concordato in capo al fallito (e conseguente preclusione della risoluzione del concordato, con riapertura del fallimento e possibilità di agire esecutivamente nei confronti del proponente, ovvero di chiederne il fallimento), solo quando i predetti obblighi vengano, appunto, assunti dal terzo proponente o da uno o più creditori, con liberazione immediata del debitore, come si evince dall’art. 137, comma 7, l.fall.
Quando, poi, il terzo proponente eserciti la facoltà di limitare i propri impegni nei confronti dei soli creditori ammessi al passivo e di quelli che, al tempo della proposta, hanno già proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva, il fallito continua a rispondere integralmente e nella misura originaria verso gli altri creditori (art. 124, comma 4, l.fall.).
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che il fallito-persona fisica venga ammesso, con il decreto di chiusura del fallimento o entro l’anno successivo, su domanda presentata dallo stesso fallito tornato in bonis, al beneficio della liberazione dai debiti residui (anche se di natura tributaria, non rientrando tra quelli esclusi dall’esdebitazione, a norma dell’art. 142, comma 3, l.fall., al pari di quanto ora stabilito dall’art. 278 CCII anche per il fallito-persona giuridica) nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti anche solo parzialmente.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia