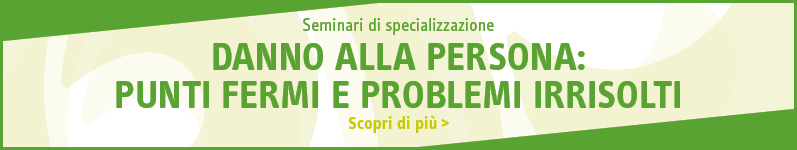Il risarcimento del danno biologico permanente con rendita vitalizia
di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. III, 25 ottobre 2022, n. 31574, Sent., G.Rel. Dott.ssa A. Pellecchia
Danno biologico permanente – Risarcimento – rendita vitalizia
Massima: “Il danno biologico permanente può essere risarcito, con decisione che può e in certi casi deve essere assunta dal giudice anche d’ufficio, con la condanna ad una rendita vitalizia, che costituisce anzi la forma privilegiata di ristoro perché ogni rateo di rendita compensa, giorno dopo giorno, il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo e scongiura il rischio di dispersione di un ingente capitale corrisposto una tantum, a causa di condotte colpose o incolpevoli da parte di soggetti in mala fede o semplicemente inesperti”.
CASO
Tizio e Caia, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Sempronio, citavano in giudizio Filano e l’Azienda Ospedaliera presso cui lavorava, per ottenere il risarcimento del danno patito dal figlio. Esponevano infatti che, a causa di un errore di Filano in servizio il pronto soccorso dell’ospedale di zona, Sempronio, di pochi mesi, aveva visto compromettere in modo grave e irreparabile la propria salute.
Successivamente all’integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice dell’Azienda ospedaliera e all’istruzione della causa, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando Filano e l’Azienda Ospedaliera, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di Sempronio (liquidato in oltre un milione di euro), rigettando invece la domanda di manleva dell’Azienda Ospedaliera nei confronti della compagnia assicuratrice.
La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello, che, dopo avere confermato l’entità del risarcimento nella misura liquidata in primo grado, considerata l’impossibilità di stabilire in modo oggettivo una durata presumibile della vita di Sempronio e tenuto conto altresì del carattere permanente del danno, riteneva d’ufficio che la modalità del risarcimento in forma di rendita vitalizia meglio rispondesse alle concrete esigenze del danneggiato, garantendogli per tutta l’effettiva durata della vita la percezione di quanto liquidato annualmente. I giudici di secondo grado accoglievano invece l’appello dell’Azienda Ospedaliera nella parte in cui lamentava il mancato accoglimento della domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice, che veniva quindi condannata al pagamento diretto di quanto liquidato in favore di Sempronio, nonché a stipulare una polizza fideiussoria, con pagamento a prima richiesta, a garanzia della rendita vitalizia costituita in favore di quest’ultimo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la compagnia assicuratrice, sostenendo, per quello che ci interessa, che la condanna al pagamento di una rendita vitalizia, per di più con l’imposizione della stipula di una polizza fideiussoria a prima richiesta, sarebbe avvenuta extra petita perché non richiesta dalle parti in causa.
Resistevano con separati controricorsi le altre parti in causa e, in particolare, Tizio e Caia – per conto del figlio Sempronio –, i quali proponevano altresì ricorso incidentale lamentando, tra l’altro, la scelta della condanna al pagamento di una rendita vitalizia, in luogo della condanna al pagamento di una somma capitale in un’unica soluzione.
SOLUZIONE
La S.C. respinge il ricorso principale e quello incidentale, nella parte in cui si censura la scelta della condanna al pagamento di una rendita vitalizia.
QUESTIONI
Occorre premettere alcuni principi generali, atti a chiarire la funzione del risarcimento del danno, perché è solo così che potrà apprezzarsi la bontà della conclusione cui è pervenuta la Corte.
In linea teorica, sono possibili tre differenti impostazioni. La prima è quella che vede nel risarcimento una sorta di punizione del responsabile; la seconda vede invece nel risarcimento una forma di reintegrazione di un quid distrutto o diminuito del danneggiato; la terza, infine, attribuisce al risarcimento una funzione “consolatoria”, con la quale vengono assegnate al danneggiato delle utilità sostitutive di quelle perdute.
Per stabilire quanto denaro e come attribuirlo a chi abbia patito un danno alla salute è indispensabile decidere previamente per quale scopo al danneggiato venga dato questo denaro. Se riteniamo infatti che quel denaro debba essere pagato per ammonire il responsabile a stare più attento in futuro (concezione punitiva), il quantum necessariamente dipenderà dal grado di colpa del danneggiante. Se riteniamo invece che il risarcimento debba avere una funzione reintegratrice per equivalente, il quantum varierà in funzione del prezzo che riterremo di assegnare al corpo dell’uomo. Infine, se riteniamo che il risarcimento debba servire a consolare il danneggiato, il quantum varierà in funzione della qualità e quantità di funzioni perdute.
La prima strada è impercorribile, perché contraria alla legge, la quale impone che il danno sia liquidato in base alla perdita subita o al mancato guadagno (art. 1223 c.c.). Inoltre, la tesi della funzione punitiva condurrebbe a risarcire in modo diverso danni identici solo perché una delle vittime è stata danneggiata con colpa grave e l’altra con colpa lieve, con una inaccettabile disparità di trattamento. Non c’è dubbio pertanto che il risarcimento debba essere misurato in base a quello che oggettivamente è il danno e non in base a quello che il danneggiante voleva o non voleva che fosse. Anche sostenere che il risarcimento del danno non patrimoniale serva allo scopo di reintegrare il patrimonio morale della vittima, non sembra accettabile. Il risarcimento in denaro (per equivalente) non può reintegrare nulla, perché non è riparazione quella che non ripristina lo status quo ante. Corretto è invece assegnare al risarcimento del danno alla salute lo scopo di assicurare alla vittima un’utilità sostitutiva di quella perduta, attraverso la liquidazione di una somma di denaro convenzionalmente ritenuta rappresentativa delle funzioni vitali perdute (funzione consolatoria).
Non è oggetto di approfondimento da parte della Corte l’individuazione delle modalità concrete di determinazione del quantum dovuto, per cui non ce ne occuperemo in questa sede (basti qui ricordare che la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali e, cioè, deve essere integrale, deve evitare duplicazioni e deve evitare sperequazioni).
Avere correttamente individuato la funzione del risarcimento del danno alla persona consente però anche di apprezzare la previsione dell’art. 2057 c.c., di cui si occupa la Corte nel caso di specie. Di norma, infatti, il risarcimento avviene mediante la liquidazione di una somma capitale, ma la legge consente anche la liquidazione in forma di rendita, a mente dell’art. 2057 c.c. secondo cui «quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele».
La norma richiede solo due requisiti: che il danno riguardi la persona e che abbia carattere di permanenza; il risarcimento in forma di rendita non è infatti consentito nel caso di lesioni che abbiano determinato soltanto un’invalidità temporanea anche se di notevole durata, ciò che si desume implicitamente dal fatto che l’art. 2057 prevede la possibilità di costituire soltanto una rendita vitalizia, e non una rendita temporanea.
Non costituisce invece presupposto per l’applicazione dell’art. 2057 l’istanza di parte, perché la norma ha configurato la liquidazione della rendita non come un diritto della parte, ma come una facoltà del giudice. Pertanto, abbia o non abbia la parte chiesto la liquidazione della rendita ed anzi anche quando la parte abbia espressamente dichiarato di non volere la liquidazione della rendita, sarà sempre in facoltà del giudice provvedere d’ufficio a tale tipo di liquidazione, con giudizio incensurabile in Cassazione se non per illogicità della motivazione o errore di diritto, come avviene, ad esempio, quando il calcolo della rendita non rispetti il disposto dell’art. 1223 c.c., oppure non si accompagni alle adeguate cautele prescritte dall’art. 2057 c.c. Il principio – pacifico in giurisprudenza: Cass. 20.2.1958 n. 553, Cass. 7.3.1966 n. 658, Cass. 24.5.1967 n. 1140 – ha consentito pertanto alla S.C. di respingere la relativa doglianza, introdotta sia dalla ricorrente che dai resistenti.
Nello scegliere tra risarcimento in forma di capitale e risarcimento in forma di rendita, il giudice deve poi tenere conto delle condizioni delle parti e della natura del danno. Così ad esempio il giudice dovrà seriamente valutare la possibilità di liquidare il danno in forma di rendita quando il danneggiato sia incapace o prodigo oppure quando il danneggiante disponga di un patrimonio e di una struttura commerciale in grado di sorreggere il peso di una rendita vitalizia (come nel caso in cui l’obbligato sia appunto un’impresa di assicurazioni). Al contrario il giudice, sulla base delle condizioni delle parti, dovrebbe preferire il risarcimento in forma di capitale quando il debitore non appaia in grado di far fronte ad un’obbligazione vitalizia, oppure quando il danneggiato trarrebbe maggior vantaggio dalla liquidazione di un capitale, necessario per convertire la propria capacità di lavoro e di guadagno perduta a causa del sinistro. Quanto alla natura del danno, quale parametro di riferimento, la liquidazione in forma di rendita dovrebbe escludersi per i danni che abbiano natura modesta e preferirsi invece per quelli di rilevante entità. Stabilire se sia preferibile un risarcimento in forma di capitale o di rendita è ovviamente una valutazione che va compiuta caso per caso, tenendo conto di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Questi i principi che hanno consentito alla S.C. di rigettare i rimanenti motivi di ricorso di ricorso principale e incidentale.
Quanto poi alla condanna alla stipula di una polizza fideiussoria, la Corte ha respinto la suggestione – introdotta con il ricorso principale – che fosse una condanna illegittima perché extra petita. Difatti, rientra tra i poteri del giudice non soltanto quello di optare per la modalità di liquidazione del risarcimento in forma di rendita, ma anche quello di disporre, in via altrettanto officiosa, le “cautele” che ritiene necessarie per garantire l’adempimento de die in diem dell’obbligo di versare al danneggiato il rateo di rendita, così come stabilito dall’art. 2057, secondo periodo, c.c. Ed è in questo quadro che va considerata la considerata, nel caso di specie, la predetta condanna.
Non viene condivisa dal Collegio nemmeno la censura, mossa dai ricorrenti incidentali, per cui la liquidazione in forma di rendita, cessando con la morte del beneficiario, “agevolerebbe” il responsabile del fatto illecito in tutti i casi in cui proprio la gravità delle lesioni provochi una ridotta aspettativa di vita per la vittima, determinando una riduzione dello stesso risarcimento. Qualora infatti il danno sia stato liquidato in forma di rendita, dopo aver determinato la somma capitale, occorre tenerne distinte due diverse componenti: il coefficiente per la costituzione della rendita (ovvero il criterio di calcolo) e la durata della stessa.
Il coefficiente di costituzione della rendita farà riferimento alla durata media della vita (calcolato sul presupposto che, secondo le statistiche mortuarie attuali, un ventenne ha una aspettativa di vita di sessant’anni, un quarantenne di quaranta ed un sessantenne di venti). Tuttavia – questo il ragionamento della Corte –, una volta determinato il capitale con riferimento alla durata media della vita e non a quella presumibile nel caso concreto, una volta detratti gli eventuali acconti versati prima della sentenza e una volta convertito tale capitale in rendita, il diritto a ricevere quest’ultima matura de die in diem ed ogni rateo di rendita compensa il pregiudizio sofferto dalla vittima nel corrispondente arco di tempo. Se dunque la vittima venisse a mancare ante tempus, con la sua morte cesserebbe il pregiudizio permanente e, cessando il pregiudizio, non sarebbe concepibile la ulteriore pretesa di continuare ad esigere un risarcimento. Salvo ovviamente il risarcimento del danno patito iure proprio dai genitori del minore, nel caso in cui la minor durata della vita del minore dovesse risultare conseguenza dell’evento lesivo. Ed è questo il passaggio che permette di affermare la piena legittimità della scelta operata dal giudice di prime cure, nel caso di specie.
Secondo la Corte, cioè, nel caso di morte precoce del danneggiato bisognerebbe distinguere varie ipotesi. Se la morte anticipata è stata causata dalle lesioni, il responsabile sarà chiamato a risarcire, oltre al danno biologico e morale, possibilmente in forma di rendita, subito dal danneggiato nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la morte, anche il danno iure proprio subito dai genitori, in relazione alla ridotta aspettativa di vita ed al presumibile periodo di vita del minore. Se invece la morte non è stata causata dalle lesioni, il responsabile dovrà risarcire il danno biologico subito dal danneggiato valutato al tempo della commissione dell’illecito, oltre al danno da lesione del rapporto parentale in favore dei genitori.
Ne consegue che il responsabile, versando una somma periodica al danneggiato, non lucra alcuno “sconto” sul risarcimento, in quanto: a) se la durata della vita del danneggiato è maggiore rispetto alla durata della vita media, sarà il danneggiato stesso a realizzare un lucro; b) se la durata della vita del danneggiato sarà, in concreto o presumibilmente, inferiore alla durata della vita media, e ciò a causa delle lesioni, il responsabile sarà tenuto a risarcire il danno sotto forma di rendita oltre al danno parentale subito dai genitori in conseguenza dell’illecito; c) se il danneggiato avrà una vita di durata inferiore alla media, ma ciò avviene per cause del tutto indipendenti dalle lesioni, il responsabile che cessa di pagare la rendita non realizza alcun “vantaggio” patrimoniale, poiché il risarcimento cessa perché cessa il danno.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia