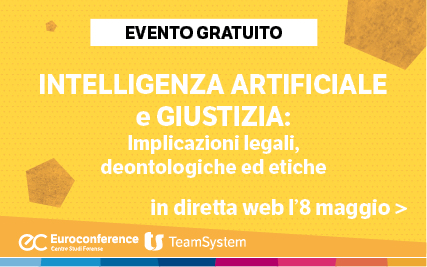Vendita di beni artistici e prelazione dello Stato
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. II, 13 novembre 2020, n. 25791 – Pres. D’Ascola – Rel. Scarpa
Parole chiave: Trasferimento di cose d’interesse artistico e storico – Denuncia al Ministero dei beni culturali e ambientali – Termine per l’esercizio della prelazione – Decorrenza – Data risultante dall’avviso di ricevimento – Assenza di sottoscrizione del destinatario – Fede privilegiata – Insussistenza
[1] Massima: In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di bene d’interesse artistico e storico per il quale lo Stato è legittimato a esercitare il diritto di prelazione, il termine di due mesi entro il quale dev’essere notificato all’acquirente il decreto per l’esercizio della prelazione decorre dalla data in cui è pervenuta la denuncia di alienazione, che, in caso di spedizione mediante raccomandata, coincide con quella di consegna del plico risultante dall’avviso di ricevimento solo se questo reca la sottoscrizione del destinatario.
Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1335, 2700; l. 1089/1939, artt. 30, 31, 32; d.P.R. 655/1982, artt. 8, 36, 37, 38
CASO
A seguito della vendita a un privato di due famosi dipinti e della denuncia di alienazione spedita con raccomandata del 6 dicembre 1995 ai sensi dell’art. 30 l. 1089/1939, il Ministero per i beni culturali e ambientali notificava all’acquirente, il 13 febbraio 1996, il decreto concernente l’esercizio della prelazione artistica.
Si innescava, quindi, un contenzioso circa la tempestività dell’esercizio della prelazione, che tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello di Bologna risolvevano escludendo che, a tale scopo, assumesse rilievo la data apposta sull’avviso di ricevimento della denuncia inviata al Ministero (9 dicembre 1995), in quanto la mancanza della sottoscrizione del ricevente privava l’attestazione dell’agente postale di efficacia fidefaciente; secondo i giudici di merito, pertanto, andavano valorizzate le risultanze della distinta dell’ufficio spedizioni e, in particolare, il timbro appostovi il 15 dicembre 1995 (data dalla quale, dunque, doveva farsi decorrere il termine di due mesi entro cui andava esercitata la prelazione).
L’erede dell’acquirente dei due dipinti, risultato soccombente, proponeva ricorso per cassazione, censurando sotto diversi profili il ragionamento svolto dai giudici di merito per giungere ad affermare che la prelazione era stata esercitata tempestivamente.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, reputando corretta l’esegesi operata dai giudici di merito, i quali, in assenza della sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, avevano escluso che la data ivi riportata dovesse essere considerata quella in cui la denuncia di trasferimento era pervenuta nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla quale, dunque, era iniziato a decorrere il termine di due mesi per l’esercizio della prelazione artistica ai sensi dell’art. 32 l. 1089/1939.
QUESTIONI
Accade spesso, soprattutto nell’ambito delle compravendite immobiliari, che il perfezionamento dell’operazione tra le parti contraenti sia subordinato al mancato esercizio della prelazione spettante a un ente pubblico in ragione della natura del bene, ovvero della sua rilevanza storica, artistica o culturale: in questi casi, della compravendita (o del diverso contratto avente effetti traslativi) dev’essere notiziato, tramite apposita denuntiatio, l’ente pubblico che, in virtù della prelazione, ha diritto di acquistare la proprietà del bene al medesimo prezzo risultante dall’atto, la cui efficacia, così, resta condizionata al mancato esercizio di tale facoltà (sicché, di prassi, una volta scaduto inutilmente il termine per la comunicazione della volontà di avvalersi della prelazione, le parti procedono alla stipula di un atto ricognitivo, con lo scopo di fare constare il definitivo consolidamento della proprietà del bene in capo all’acquirente).
È evidente, pertanto, come assuma rilievo fondamentale l’esatta individuazione dello spazio di tempo nel quale la prelazione può e deve essere esercitata a pena di decadenza.
Da questo punto di vista, nell’esaminare le censure mosse avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, i giudici di legittimità hanno ricostruito la cornice normativa inerente alla prelazione che, in base alla disciplina recata dalla l. 1089/1939 (successivamente abrogata e trasfusa nel d.lgs. 42/2004), compete al Ministero per i beni culturali e ambientali in caso di atti di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, aventi per oggetto cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Detta normativa, in particolare, prevede, all’art. 32, che il diritto di prelazione dev’essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia di alienazione, che funge da atto di interpello idoneo, da un lato, a fare decorrere il termine di decadenza entro il quale l’amministrazione, notiziata della vicenda circolatoria, deve azionare il proprio potere e, dall’altro lato, a delimitare il periodo di inefficacia dell’alienazione intervenuta tra i privati.
Pur essendo controversa la natura della denuncia di trasferimento (discutendosi se essa abbia natura negoziale o se sia piuttosto configurabile come atto non negoziale partecipativo della pendenza di un rapporto contrattuale), si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la decorrenza del termine per l’esercizio della prelazione è direttamente collegato all’effettuazione di una denuncia secondo le modalità prescritte dalla legge, che non può essere surrogata dalla conoscenza non qualificata dell’avvenuto trasferimento acquisita aliunde.
Stante la natura recettizia della denuncia, perché la stessa esplichi efficacia vale la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c., che presuppone che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, ovvero nella sua sfera di controllo; quando, peraltro, la spedizione sia avvenuta a mezzo del servizio postale, è necessario e sufficiente, a tale proposito, che la consegna dell’atto sia avvenuta secondo le norme stabilite dal codice postale.
Allorché, in particolare, si tratti di dichiarazione trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la presunzione di conoscenza non può ritenersi integrata dalla sola prova della sua spedizione, ma deve dimostrarsi il perfezionamento del procedimento notificatorio, attraverso l’avviso di ricevimento (firmato dal destinatario o, qualora questi si rifiuti di sottoscriverlo, munito dell’apposita dichiarazione dell’agente postale prescritta dalla normativa di riferimento), ovvero l’attestazione di compiuta giacenza.
In proposito, sulla base della disciplina recata dal d.P.R. 655/1982, la consegna al destinatario di una raccomandata deve considerarsi avvenuta in corrispondenza della data indicata nel relativo avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altro idoneo consegnatario, sicché tale sottoscrizione assurge a elemento costitutivo del procedimento notificatorio, che concorre a perfezionarlo, conferendo all’avviso di ricevimento la fede privilegiata che assiste gli atti pubblici.
Nel caso di specie, pertanto, l’assenza della firma del destinatario impediva di attribuire valenza probatoria assoluta (rectius: legale) alla data (9 dicembre 1995) risultante dal timbro apposto sull’avviso di ricevimento e ha consentito ai giudici di merito di affermare, sulla base degli altri elementi introdotti in giudizio (precisamente, sulla scorta del timbro datario apposto sulla distinta dell’ufficio spedizioni), che il plico doveva considerarsi, in realtà, ricevuto il 15 dicembre 1995, con la conseguenza che la prelazione – mediante la notifica del decreto del Ministero avvenuta il 13 febbraio 1996 – era stata esercitata tempestivamente.
Nella sentenza che si annota è stato, altresì, precisato che sulla conclusione raggiunta non influiva il fatto che il destinatario fosse una pubblica amministrazione, sebbene il comma 3 dell’art. 36 d.P.R. 655/1982 stabilisca come, in questi casi, i plichi, anziché essere consegnati tramite i portalettere, sono distribuiti in ufficio, sicché – secondo l’interpretazione consolidatasi – rientra tra i doveri delle amministrazioni pubbliche ritirare la corrispondenza direttamente presso l’ufficio postale per mezzo di propri incaricati; tale disciplina, infatti, non deroga a quella specificamente riferita alla corrispondenza raccomandata, caratterizzata dalla certezza non solo della sua spedizione, ma anche del suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, tenuto a firmare l’avviso di ricevimento onde attestare la ricezione del plico, con la conseguenza che, in ogni caso, il momento della consegna, anche ai fini dell’integrazione della presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c., coincide con quello in cui risulta apposta la firma del destinatario o di un suo incaricato.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia